Norberto Bobbio biografia vita e opere
Norberto Bobbio biografia vita e opere
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Norberto Bobbio biografia vita e opere
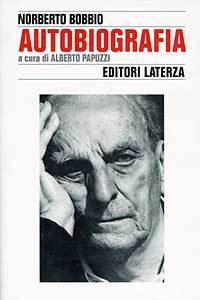 Recensione Bobbio Norberto, Autobiografia, a cura di A. Papuzzi, Laterza, Bari 1997
Recensione Bobbio Norberto, Autobiografia, a cura di A. Papuzzi, Laterza, Bari 1997
Norberto Bobbio (Torino, 18 ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 2004) è stato un filosofo, storico e politologo italiano.
È considerato uno dei maggiori intellettuali del Novecento ed una delle personalità culturali più influenti Bobbio nacque a Torino il 18 ottobre 1909 da Luigi (medico) e Rosa Caviglia.
Una condizione familiare agiata gli permise una infanzia serena. Il giovane Norberto scrive versi, ama Bach e la Traviata, ma svilupperà, per causa di una non ben determinata malattia, un sentimento malinconico di fondo che si rivelerà poi essenziale nella sua maturazione.
Studiò prima al Ginnasio e poi al Liceo classico Massimo D'Azeglio dove conoscerà Ginzburg, Foa e Cesare Pavese, poi divenute figure di primo piano della cultura dell'Italia repubblicana. Dal 1928, come molti giovani dell'epoca, fu infine iscritto al Partito Nazionale Fascista.
La sua giovinezza, come da egli stesso descritto fu: "vissuta tra un convinto fascismo patriottico in famiglia e un altrettanto fermo antifascismo appreso nella scuola, con insegnanti noti antifascisti, come Umberto Cosmo e Zino Zini, e compagni altrettanto intransigenti antifascisti come Leone Ginzburg e Vittorio Foa".
Allievo di Gioele Solari e Luigi Einaudi, si laureò in giurisprudenza nel 1931 con una tesi su "Filosofia e dogmatica [Scienza] del Diritto". Nel 1932 seguì un corso estivo all'Università di Marburg, in Germania, insieme a Renato Treves e Ludovico Geymonat, ove conoscerà le teorie di Jaspers e i valori dell'esistenzialismo. L'anno seguente, il 1933, si laureò anche in filosofia con una tesi su Husserl e la fenomenologia e nel 1934 conseguì la libera docenza in filosofia del diritto, che gli aprì le porte nel 1935 all'insegnamento, dapprima all'università di Camerino (Macerata), poi all'università di Siena e a Padova (dal 1940 al 1948). Nel 1934 pubblicò il primo libro, L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica.
Le sue frequentazioni sgradite al regime gli valsero, nel 1935, un primo arresto a Torino, insieme agli amici del gruppo antifascista Giustizia e Libertà.[1] La chiara reputazione fascista di cui godeva la famiglia gli permise però una piena riabilitazione, tanto che, pochi mesi dopo, ottenne la cattedra di filosofia del diritto a Camerino.
E' in questi anni che Norberto Bobbio delineò parte degli interessi che saranno alla base della sua ricerca e dei suoi studi futuri: la filosofia del diritto, la filosofia contemporanea e gli studi sociali; uno sviluppo culturale che Bobbio vive contemporaneamente al contesto politico temporale. Un anno dopo le leggi razziali infatti, esattamente il 3 marzo 1939, giurò fedeltà al Duce per poter ottenere la cattedra all'Università di Siena. E la giurò ancora nel 1940, a guerra dichiarata, per insediarsi alla cattedra del professor Adolfo Ravà, che era stato allontanato perché ebreo, all'Università di Padova. Inoltre scrisse e fece scrivere ulteriori ed analoghe lettere di perorazione della propria causa, emerse molti anni dopo. Questa parte della sua vita fu poi oggetto di svariate e severe critiche personali.
L'adesione al Partito d'azione
Nel 1942 partecipò al movimento liberalsocialista fondato da Guido Calogero e Aldo Capitini, e nell'ottobre dello stesso anno aderì al Partito d'azione clandestino. Nel 1943 sposò Valeria Cova: dalla loro unione nacquero i figli Luigi, Andrea e Marco. Il 6 dicembre del 1943 fu arrestato a Padova per attività clandestina e rimase in carcere per tre mesi. Nel 1944 venne pubblicato il saggio La filosofia del decadentismo, nel quale criticò l'esistenzialismo.
Dopo la liberazione collaborò regolarmente con Giustizia e Libertà, quotidiano torinese del Partito d'azione, diretto da Franco Venturi. Collaborò all'attività del Centro di studi metodologici con lo scopo di favorire l'incontro tra cultura scientifica e cultura umanistica, e poi con la Società Europea di Cultura.
L'attività accademica
Nel 1948 lasciò l'incarico a Padova e venne chiamato alla cattedra di filosofia del diritto dell'Università di Torino, annoverando corsi di notevole importanza come Teoria della scienza giuridica (1950), Teoria della norma giuridica (1958), Teoria dell'ordinamento giuridico (1960) e Il positivismo giuridico (1961). Dal 1962 assunse l'incarico di insegnare scienza politica, che ricoprirà sino al 1971.
La politica, del resto, divenne via via un tema fondamentale nel suo percorso intellettuale e accademico, e parallelamente alla pubblicazioni di carattere giuridico, avviò un dibattito con gli intellettuali del tempo; nel 1955 scrisse Politica e cultura, considerato una delle sue pietre miliari, mentre nel 1969 uscì il libro Saggi sulla scienza politica in Italia, e nello stesso anno fu tra i fondatori della odierna facoltà di Scienze politiche all'Università di Torino insieme con Alessandro Passerin d'Entrèves, al quale subentrò nella cattedra di filosofia politica nel 1972, e dal 1973 al 1976 divenne preside della facoltà.
Nei venticinque anni accademici all'ombra della mole, Bobbio svolse anche diversi tra corsi su Kant, Locke, lavori su Hobbes e Marx, Hans Kelsen, Carlo Cattaneo, Hegel, Pareto, Gaetano Mosca, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, e contribuì con una pluralità di saggi, scritti, articoli ed interventi di grande rilievo che lo portarono, in seguito a diventare socio dell'Accademia dei Lincei e della British Academy.
Significativa la collaborazione, sul tema pacifista, col filosofo e amico antifascista Aldo Capitini, le cui riflessioni comuni sfoceranno nell'opera I problemi della guerra e le vie della pace (1979).
L'attività politica
Nel 1953 partecipò alla lotta condotta dal movimento di Unità popolare contro la legge elettorale maggioritaria e nel 1967 alla Costituente del Partito socialista unificato. Nel tempo delle contestazioni giovanili, Torino fu la prima città a farsi carico della protesta, e Bobbio, fautore del dialogo, non si sottrasse ad un difficile confronto con gli studenti, tra i quali il suo stesso primogenito. Nel contempo, venne anche incaricato dal Ministero per la Pubblica Istruzione quale membro della Commissione tecnica per la creazione della facoltà di sociologia di Trento.
Fu tra i firmatari del controverso appello pubblicato sul settimanale L'espresso contro il commissario Luigi Calabresi, e a metà degli anni settanta, nel solco di un sempre più vivace impegno civile, ed alle soglie di uno dei periodi più drammatici in Italia (culminato col rapimento e l'omicidio di Aldo Moro), provocò un vivace dibattito sia negando l'esistenza di una cultura fascista che trattando estensivamente sui rapporti tra democrazia e socialismo. Successivamente la sua attenzione si concentrò a favore di una "politica per la pace", con dei motivati distinguo a supporto del diritto internazionale in occasione della guerra del golfo del 1991. [2]
La nomina a senatore a vita
Nel 1979 fu nominato professore emerito dell'Università di Torino, nel 1984 fu nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. In quanto membro del Senato si iscrisse prima come indipendente nel gruppo socialista, poi dal 1994 al gruppo misto ed infine dal 1996 al gruppo parlamentare del Partito Democratico della Sinistra, poi divenuto dei Democratici di sinistra.
Nel 1994, dopo la stagione di mani pulite, e la cosiddetta fine della Prima Repubblica, venne pubblicato il saggio Destra e sinistra, i cui contenuti -tuttora di concreta attualità- provocarono un notevole dibattito culturale, agitando non poco l'humus della politica italiana. Il libro toccò le cinquecentomila copie vendute in pochi mesi e venne ripubblicato l'anno successivo, riveduto e ampliato, con risposte ai critici.
A riconoscimento di una intera vita lucidamente dedicata alle scienze del diritto, della politica, della filosofia e della società, tra dubbio e metodo, tra ethos e laicità, Bobbio ricevette lauree honoris causa da molte università, tra le quali quelle di Parigi (Nanterre), Buenos Aires, Madrid (tre, in particolare alla Complutense) e Bologna, e vinse il Premio Balzan del 1994, ed il Premio Agnelli nel 1995.
Nel 1997 pubblicò la sua autobiografia. Nel 1999 uscì una terza edizione aggiornata del suo best seller, ormai tradotto in una ventina di lingue. Nel 2001 morì la moglie Valeria, e Bobbio iniziò un graduale ritiro dalla vita pubblica, pur rimanendo in attività e curando ulteriori pubblicazioni. Fecero rumore le sue osservazioni critiche sia nei confronti di Silvio Berlusconi che del centrosinistra e della partitopenia. Il 18 ottobre 2003, ricevette il "Sigillo Civico" della sua Torino "per l'impegno politico e il contributo alla riflessione storica e culturale".
Norberto Bobbio morì a Torino il 9 gennaio 2004, e la salma venne deposta dopo alcuni giorni in forma strettamente privata, secondo le sue volontà, ed una regolare messa funebre, nel cimitero di Rivalta Bormida, comune piemontese in provincia di Alessandria.
Fonte: http://www.salvobertolami.net/WEB%20biblioteca/Documenti%20Recensioni%20Libri/Bobbio%20Norberto_autobiografia.doc
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Parola chiave google : Norberto Bobbio biografia vita e opere tipo file : doc
Norberto Bobbio biografia vita e opere
CONSUETUDINE (1961)
a) TEORIA GENERALE
1. Considerazioni preliminari.
2. La consuetudine come fonte di diritto.
3. I requisiti della consuetudine.
4. Il fondamento del diritto consuetudinario cercato nell'autorità del soggetto che lo pone.
5. ... nel comportamento degli utenti.
6. ... nella materia regolata.
7. ... nel riconoscimento del giudice.
8. ... nell'appartenenza ad un ordinamento giuridico.
9. Confronto tra consuetudine e legge.
10. Consuetudine superiore alla legge.
11. Consuetudine pari alla legge.
12. Consuetudine inferiore alla legge.
13. Consuetudine e legge nell'evoluzione del diritto.
1. Considerazioni preliminari.
Tutta la nostra tradizione giuridica è dominata dalla distinzione tra due modi tipici di produzione del diritto: la consuetudine e la legge. La consuetudine rappresenta il modo spontaneo, naturale, incosciente, informale, contrapposto a quello riflesso, artificiale, cosciente, formale. Ancor più plasticamente, la consuetudine rappresenta il diritto che nasce direttamente dai conflitti sociali esistenti in una determinata società, la legge il diritto che nasce dalla società attraverso l'intermediazione di un potere organizzato. La forza da cui scaturisce la prima è quella della tradizione; la forza da cui nasce la seconda è quella di una volontà dominante: l'una impersonale, l'altra personale o personificata. Non vi è società organizzata in cui questi due momenti della produzione giuridica non siano, in misura maggiore o minore, presenti. La storia della consuetudine è la storia della funzione e dell'efficacia delle regole derivanti dal costume nella evoluzione del diritto. Ma questa storia deve esser tenuta distinta dalla storia della dottrina sulla consuetudine, che è la storia del modo con cui i giuristi hanno valutato la funzione e l'efficacia del diritto consuetudinario. Le due storie non coincidono necessariamente. Non bisogna dimenticare che la dottrina giuridica ha scopi non solo descrittivi, ma prescrittivi: orbene, nei paesi sotto l'influsso del diritto romano, dominati dalla codificazione giustinianea prima, dalle codificazioni moderne poi, la dottrina ha di solito sottovalutato l'elemento consuetudinario nella formazione del diritto. La sua maggior preoccupazione, generalmente, è stata quella di stabilirne i limiti o di giustificarlo riducendolo a qualche cosa d'altro (ora alla volontà del legislatore, ora al riconoscimento del giudice); e ciò nonostante è risuonata frequentemente sulla bocca dei giuristi dell'ultimo secolo la recriminazione sul troppo inchiostro versato per un argomento così poco degno, sulla sproporzione tra le pagine dedicate allo studio della consuetudine e la sua scarsa o nulla importanza pratica. In due momenti soltanto della storia del pensiero giuridico più recente la consuetudine ha avuto, nell'àmbito del diritto statale, il suo quarto d'ora di celebrità, con la scuola storica al principio del secolo scorso, con la scuola del diritto libero, al principio di questo: entrambe caratterizzate da un'appassionata (e sfortunata) reazione contro l'onnipotenza del diritto legislativo. Lo studio del diritto consuetudinario oggi è affidato quasi esclusivamente alla dottrina del diritto internazionale, dove, da ultimo, il concetto di diritto spontaneo ha fornito il principale argomento contro la concezione tradizionale del diritto positivo (1); ed è pur sempre coltivato in quella sede di ricerche più dottrinali che pratiche, che è la teoria generale del diritto, dove la consuetudine è un banco di prova severissimo per i concetti generali del diritto, come imperatività, destinatari, validità ed effettività. Ma non manca qualche sintomo di risveglio anche nell'àmbito del diritto statale vigente (2).
I problemi essenziali che la dottrina della consuetudine ha dovuto affrontare nel corso dei secoli sono due: la natura del diritto consuetudinario; la forza del diritto consuetudinario nella società. Sono i problemi a cui è dedicata prevalentemente questa voce, la quale tratta del primo nei § 2-8, del secondo nei § 9-13. Nella trattazione del primo, abbiamo fatto frequenti riferimenti alla storia della dottrina della consuetudine; nella trattazione del secondo, alla storia della consuetudine.
NOTA:
(1) AGO, Diritto positivo e diritto internazionale, in Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano, Milano, 1955.
NOTA:
(2) Mi riferisco in modo particolare agli studi del BALOSSINI, Consuetudini, usi, pratiche, regole del costume, Milano, 1958; ID., Gli usi del commercio tessile in Italia, Milano, 1954; ID., Gli usi locativi urbani in Italia, Milano, 1958; ID., Usi e tariffe della mediazione in Italia, Milano, 1959. Di questi studi, e segnatamente del primo, mi sono valso nella redazione della presente voce.
2. La consuetudine come fonte di diritto.
La consuetudine è una specie del genere «fonti del diritto». La sua teoria si inserisce nella teoria più generale delle fonti del diritto (v. Fonti del diritto ). Che la consuetudine sia una fonte del diritto, è dottrina comune. Ma è tutt'altro che pacifico il significato dell'espressione «fonti del diritto». Secondo che si attribuisca a «fonti del diritto» questa o quella ac accezione, anche il significato del termine «consuetrudine» è destinato a mutare. È particolarmente rilevante, allo scopo di dare una definizione iniziale della consuetudine, la distinzione tra fonti di cognizione giuridica e fonti di produzione giuridica. Per fonte di cognizione si intende il complesso dei materiali da cui l'organo autorizzato a emanare norme giuridiche trae il contenuto della disposizione che esso pronuncia; per fonte di produzione, il fatto che un determinato ordinamento giuridico considera idoneo a produrre norme giuridiche. La mancata distinzione tra i due significati è causa talora di confusione o di difficoltà meramente verbali: ad esempio, la dottrina, cioè il complesso delle opere dei giuristi, è fonte di cognizione, anzi, è, nelle società giuridicamente evolute, la fonte di cognizione per eccellenza, quella da cui il legislatore e il giudice traggono più frequentemente i materiali per elaborare norme giuridiche; quando ci si domanda se la natura delle cose sia fonte di diritto, la difficoltà si scioglie se si risponde che essa è fonte non di produzione, ma di cognizione; le decisioni dei giudici sono nello stesso tempo fonti di produzione giuridica nel singolo caso deciso, o con riguardo ai casi futuri dove vige il principio del precedente obbligatorio, e fonti di cognizione per i giudici successivi non vincolati dal precedente; la legge che è di solito la fonte di produzione per eccellenza, diventa fonte di cognizione per il giurista che ne trae la maggior parte dei materiali per le proprie costruzioni scientifiche.
Quanto alla consuetudine, che essa sia fonte di cognizione, non dà luogo a dubbi: anche coloro che la considerano fonte secondaria o indiretta, nel senso di attribuirle forza vincolante solo in quanto venga espressamente o tacitamente riconosciuta da fonti primarie o dirette, come la legge o la giurisprudenza, non negano che da essa tanto il legislatore quanto il giudice possano trarre materiali idonei alla produzione di norme giuridiche. Chi nega alla consuetudine il carattere di fonte del diritto, non rifiuta di attribuirle il carattere di fonte di cognizione, bensì quello di fonte di produzione. Sulla considerazione della consuetudine come fonte di produzione, la dottrina è discorde. In sede di teoria generale del diritto, il problema principale e tradizionale della consuetudine è se essa sia fonte di produzione giuridica, in qual senso ed entro quali limiti. L'affermazione che essa sia fonte di produzione giuridica significa: 1) che è un procedimento idoneo a produrre regole di condotta; 2) che le regole di condotta, da essa prodotte, appartengono a quella specie particolare di regole, che sono le norme giuridiche. La prima affermazione è generalmente ammessa; la seconda, invece, è contestata. Le critiche che si sogliono muovere alla consuetudine come fonte di diritto sono rivolte a negare alla consuetudine la capacità non già di produrre regole di condotta, ma di produrre regole giuridiche, cioè regole di una specie particolare. Il riconoscere in ogni società l'esistenza di regole del costume non conduce necessariamente all'ammissione che vi siano regole giuridiche consuetudinarie accanto alle regole giuridiche formatesi attraverso il procedimento della legislazione o della giurisprudenza. Le regole consuetudinarie danno luogo a quel fenomeno, comune ad ogni società, che è il costume: ora il costume non è diritto; anzi la differenza fra diritto e costume viene cercata di solito proprio nella differenza fra le rispettive regole di condotta.
3. I requisiti della consuetudine.
La consuetudine in ogni società, e specie nelle società primitive, è una delle principali fonti di regole di condotta. Regole sociali nascono, o dalla tradizione, o da autorità pubbliche costituite e riconosciute, o dalla necessità o natura delle cose. Le regole consuetudinarie sono quelle che nascono dalla forza della tradizione. La dottrina giuridica si è soffermata con particolare attenzione sulla consuetudine in quanto generatrice di regole di condotta, e ha per lunga e costante tradizione fissato alcuni requisiti che essa considera come determinanti per la formazione di una regola consuetudinaria, e quindi come delimitanti l'àmbito di validità di una regola consuetudinaria al fini della sua applicazione nei tribunali. Si tratta della dottrina dei cosiddetti requisiti esterni, che costituiscono l'elemento materiale della consuetudine, inteso come contrapposto a spirituale o a psicologico, e non a formale, giacché, se si considera, anziché la coppia materiale-spirituale, la coppia materiale-formale, quei requisiti costituiscono l'elemento formale, piuttosto che quello materiale, cioè la forma che la consuetudine deve assumere per essere idonea a produrre regole di condotta, indipendentemente dal contenuto, preso in considerazione da altri requisiti (come, ad esempio, la rationabilitas).
Il principale requisito esterno è il decorso del tempo, ovvero il fatto che i comportamenti, oggetto della regola, sono stati ripetuti per un certo periodo di tempo. Che il decorso del tempo idoneo alla formazione di una regola consuetudinaria debba essere quantitativamente determinato, non è regola costante: la disciplina del diritto canonico che, attraverso una analogia tra diritto consuetudinario e prescrizione, fissa il numero degli anni utili alla formazione della consuetudine (§ 11), non trova riscontro negli ordinamenti statali contemporanei, che lasciano il giudizio sulla vetustà della consuetudine al libero apprezzamento del giudice. Nel diritto inglese, la consuetudine doveva essere immemorabile, e si intendeva per immemorabile quella consuetudine di cui potevasi provare l'esistenza prima del 1189, primo anno del regno di Riccardo I.
È dottrina costante, invece, dal diritto comune in poi, quella che enumera alcuni requisiti come necessari alla ripetizione o reiterazione dei comportamenti, oggetto della regola consuetudinaria, affinché il decorso del tempo dia origine ad una regola consuetudinaria. Vari e non sempre perfettamente coincidenti sono i requisiti della ripetizione, di volta in volta enumerati. Una certa concordanza esiste nell'accoglimento dei cinque seguenti: 1) generalità; 2) uniformità; 3) costanza (o continuità); 4) frequenza; 5) pubblicità. Per «generalità» si intende che il comportamento ripetuto non deve essere di una sola persona, ma di più persone, della maggior parte delle persone che si trovano nella situazione prevista; per «uniformità» si intende che quella generalità di persone deve comportarsi, nella situazione prevista, in modo identico o perlomeno simile (ma questo requisito è già contenuto nella stessa nozione di ripetizione, perché, se i comportamenti non fossero uniformi, non si potrebbe neppure parlare di ripetizione); per «costanza» (o continuità), che la ripetizione non deve essere interrotta; per «frequenza», che, oltre che non interrotta, deve succedersi a brevi intervalli; per «pubblicità», che il diritto di cui si chiede il riconoscimento in base alla regola consuetudinaria consolidata, non sia stato esercitato segretamente.
Questi requisiti sono stati elaborati dalla dottrina nei confronti delle consuetudini che si formano nei rapporti tra privati, per esempio, degli usi del commercio o dell'agricoltura. Altro discorso conviene che sia fatto circa le consuetudini nel diritto pubblico o nel diritto internazionale. Qui il decorso del tempo ha minore importanza e in nessun caso è richiesta la longi temporis praescriptio. Via via che si passa, per quel che riguarda gli utenti, dai privati agli organi dotati di poteri d'impero, e quindi capaci di produrre diritto scritto volontario, la formazione della regola consuetudinaria diventa sempre più rapida, sino al caso limite degli organi legislativi supremi, come il Parlamento, in cui può bastare talora un solo atto innovativo per dar vita ad una norma costituzionale non scritta: in questo caso, però, mentre è corretto parlare di diritto costituzionale non scritto in contrapposto al diritto legislativo o scritto, non è altrettanto corretto parlare di diritto consuetudinario, perché è venuta a mancare per la formazione della regola quella ripetizione dei comportamenti, in cui consiste la consuetudine. Il termine più proprio per indicare questo modo di formazione del diritto è «precedente». Si può dire allora che nel caso di organi dotati di potestà d'impero il diritto non scritto conosce, accanto alla figura della regola consuetudinaria propriamente detta, quella del precedente; ma, com'è noto, molto spesso l'espressione «diritto consuetudinario» viene adoperata in senso largo, per indicare ogni specie di diritto non scritto, o addirittura il diritto non legislativo. Tra i requisiti della ripetizione della consuetudine privatistica quello che certamente vien meno nel caso di consuetudine costituzionale, là dove ripetizione vi è stata, è quello della generalità: la consuetudine costituzionale può nascere dal comportamento uniforme e costante di un organo solo, sia esso il governo, uno dei rami del Parlamento e così via. Anche il requisito della frequenza, trattandosi di comportamenti di solito non numerosi, perde gran parte del suo valore (3).
NOTA:
(3) Ricordiamo, a puro titolo di curiosità, la tesi di chi ha negato ogni valore all'elemento temporale della consuetudine e vi ha sostituito l'elemento spaziale, sostenendo che «la ripetizione uniforme della data condotta non è necessario che si diluisca nel tempo, quando sia estesa nello spazio, cioè nella società, sia essa professionale o territoriale» (FERRARI, Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinario, Milano, 1950, 67).
4. Il fondamento del diritto consuetudinario cercato nell'autorità del soggetto che lo pone.
La ripetizione degli stessi comportamenti per un certo periodo di tempo dà luogo ad una regola consuetudinaria, ma non di per se stessa ad una regola giuridica, cioè a quella specie di regole di condotta che costituiscono il diritto consuetudinario. Anche le regole del costume sono il prodotto di consuetudini. Il cosiddetto requisito esterno, di cui sin qui si è discorso, non serve a distinguere una regola del costume da una regola giuridica. Chi ritiene legittimo parlare di un diritto consuetudinario come di una specie del genere diritto, cioè come di un insieme di regole giuridiche, deve preoccuparsi di trovare un criterio di distinzione tra regole del costume e diritto consuetudinario oltre l'elemento esterno o materiale della ripetizione. La ricerca di questo criterio distintivo ha dato luogo a differenti opinioni, anzi a vere e proprie scuole, e costituisce la parte più controversa e di gran lunga più importante della dottrina intorno alla natura della consuetudine giuridica.
In generale si può dire che la risposta alla domanda qual sia l'elemento che determina il passaggio dalla consuetudine non giuridica alla consuetudine giuridica, dipende dalla nozione di diritto di volta in volta prescelta, e che pertanto nella teoria relativa alla giuridicità delle norme consuetudinarie si ritrova la varietà delle teorie intorno alla nozione di diritto. La nota differenziale della norma giuridica rispetto alle norme morali, da un lato, e alle norme del costume dall'altro, è stata cercata in qualche carattere peculiare ora del soggetto che la pone, ora del soggetto cui è rivolta, ora della materia regolata, ora del meccanismo della sanzione. La ricerca della giuridicità delle norme consuetudinarie ha seguito su per giù questa stessa strada e può considerarsi quindi come una manifestazione della travagliata vicenda della definizione del diritto. Le soluzioni, che sono state date di volta in volta al problema della giuridicità della consuetudine, sono le stesse escogitate per rispondere alla domanda generale: «che cos'è il diritto?».
La dottrina tradizionale della consuetudine, detta comunemente romano-canonistica, che ha dominato incontrastata sino al fiorire della scuola storica, passando dal diritto romano al diritto comune, dal diritto canonico al diritto civile, dal diritto dello Stato al diritto internazionale, cerca il fondamento del valore giuridico della regola consuetudinaria nel prestigio del soggetto cui deve la propria esistenza, il popolo, considerato come l'organo per eccellenza di ogni forma di produzione giuridica. Sotto questo rispetto il diritto consuetudinario non si distingue dal diritto legislativo: il fondamento della loro forza giuridica è lo stesso, cioè la volontà del popolo. La differenza è puramente e semplicemente procedurale: nella formazione della legge la volontà del popolo è espressa (direttamente o indirettamente); nella formazione della consuetudine la volontà del popolo è tacita. In un celebre passo di Ermogeniano (D. 1, 3, 35), ove si vuol mostrare che legge e consuetudine hanno pari dignità, la seconda è chiamata tacita civium conventio. In un altro celebre passo, Giuliano pone legge e consuetudine sullo stesso piano con queste parole: «Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis?» (D. 1, 3, 32, 1) (4). Nell'elaborazione del pensiero giuridico medioevale, sino alle soglie dell'età moderna, considerato il popolo come ente politico, titolare del potere sovrano, la dottrina della consuetudine continua ad appartenere a quelle teorie del diritto che cercano l'elemento caratteristico delle norme giuridiche, e quindi anche della consuetudine, nella natura particolare del potere da cui promanano, consistente nella superiorità o sovranità, intesa come potere invincibile, che sta a fondamento di ogni altro potere e non è da alcun altro a sua volta fondato. Così si spiega perché nella dottrina medioevale, e più ancora in quella dei giuristi durante il prevalere delle monarchie assolute, la tesi originaria della tacita voluntas populi sia stata soppiantata da quella della tacita voluntas principis o superioris, senza che la soluzione del problema giuridico della consuetudine abbia cambiato natura: nell'un caso e nell'altro, viene considerata norma giuridica quella che può essere fatta risalire alla volontà di colui o coloro che detengono il potere sovrano. Ciò che mutava in questo passaggio era il prestigio della consuetudine come fonte autonoma di diritto: mentre il popolo può essere considerato autore di norme e legislative e consuetudinarie, il principe è l'autore per eccellenza del solo diritto legislativo, e pertanto ammettere come norme giuridiche solo le consuetudini approvate dal principe significava disconoscere l'autonomia del diritto consuetudinario. Non diverso è stato il tipo di soluzione dato al problema del fondamento della consuetudine nel diritto internazionale, nella prima fase del positivismo giuridico, oggi superata, quando si sostenne che la consuetudine internazionale derivava la sua validità giuridica dal tacito consenso degli Stati: anche in questo caso la teoria della consuetudine si identificava con la teoria secondo cui diritto è il complesso delle regole emanate direttamente o indirettamente dai soggetti che detengono il potere sovrano.
La volontà tacita del popolo o del principe era una finzione legalistica. A questo modo di porre il problema della consuetudine, che si era tramandato per secoli, reagì energicamente la scuola storica con un tipo di analisi che oggi diremmo sociologica o realistica, anche se sfociava nella scoperta di un'entità piuttosto misteriosa e inafferrabile, com'era lo spirito del popolo. Fondamento del valore giuridico della consuetudine era pur sempre il popolo, ma non più come ente politico della dottrina tradizionale, ma come formazione naturale, o sociale, contrapposta alla formazione artificiale dello Stato. Il PUCHTA, che fu il maggior seguace del SAVIGNY, e uno dei più profondi studiosi del diritto consuetudinario (5), affermava che tre sono le vie di formazione del diritto: l'accordo naturale delle convinzioni, la legislazione e la scienza, donde derivano rispettivamente il diritto consuetudinario, il diritto promulgato, e il diritto dei giuristi o scientifico. Ogni forma di diritto nasce dalla convinzione giuridica del popolo: il popolo, non lo Stato, è il creatore originario del diritto in tutte le sue forme. Ma la fonte genuina, immediata, quella da cui anche le altre forme giuridiche, quella legislativa e quella scientifica, derivano, è il diritto popolare che nella consuetudine ha la sua manifestazione e la prova della sua esistenza. In contrasto con le teorie sino allora dominanti intorno alla consuetudine, il PUCHTA fissa essenzialmente tre punti: 1) il diritto consuetudinario sorge dal popolo in senso naturale e non in senso politico; 2) sorge in modo immediato a differenza del diritto scientifico con cui troppe volte è confuso; 3) si esprime nel costume, cioè nel comportamento generale, costante, uniforme dei consociati, onde viene invertita la tesi tradizionale che faceva del diritto un prodotto del costume, essendo, invece, secondo il PUCHTA, il costume un prodotto del diritto; e pertanto la ripetizione non è elemento costitutivo, ma soltanto probativo del diritto popolare. La rivalutazione del diritto consuetudinario, compiuta dalla scuola storica, consistette nel fare del diritto popolare, che si esprime nel costume, la fonte principale del diritto, mentre la dottrina tradizionale, elaborata nella tarda epoca del diritto romano, quando il diritto scritto aveva preso ormai il sopravvento sul diritto non scritto, aveva espresso la tendenza opposta, attribuendo alla consuetudine un fondamento che l'avvicinasse alla legge, ne facesse un'imitazione della legge, come aveva detto in un noto passo il giurista Gaio: «Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur» (I, 1, 2, 9). Rispetto alla teoria tradizionale, che poneva il fondamento della consuetudine nella volontà del legislatore, il PUCHTA replicava che lo Stato stesso, nella migliore delle ipotesi, derivava il proprio potere da quella stessa convinzione popolare da cui lo traeva il diritto consuetudinario.
NOTA:
(4) Per la storia della dottrina sulla consuetudine, fondamentale è ancora l'opera di BRIE, Die Lehre vom Gewohnheitsrecht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung, Breslau, 1899. La più ampia trattazione e critica della dottrina romano-canonistica si trova in LAMBERT, La fonction du droit civil comparé, Paris, 1903, 111-804. Pur sempre da consultare come fonte storica è la classica opera di PUCHTA, Das Gewohnheitsrecht, 2 voll., Erlangen, 1828-1837, soprattutto il primo volume. Per un particolareggiato commento al frammento di GIULIANO, sopra citato, cfr. STEINWENTER, Zur Lehre vom Gewohnheitsrecht, in Studi in onore di Bonfante, II, Milano, 1930, 419-441.
NOTA:
(5) PUCHTA, op. cit.
5. ... nel comportamento degli utenti.
La teoria più diffusa intorno alla natura giuridica della consuetudine è quella che cerca di spiegarla non già riferendosi al soggetto che pone la norma ma a quello, o meglio a quelli cui la norma è rivolta, e che possiamo chiamare gli utenti; in particolare al modo con cui la norma consuetudinaria non già è posta, ma è accolta e seguita. Si tratta della teoria dell'opinio iuris et necessitatis, secondo cui il carattere che contraddistingue una regola del costume da una norma giuridica è il cosiddetto requisito interno o psicologico o spirituale, inteso come credenza o convinzione o sentimento che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio, perché conforme ad una norma giuridica valida o giusta, e pertanto l'atto contrario sia da considerarsi illecito e quindi assoggettabile ad una sanzione giuridica.
Questa teoria deve essere distinta da quella precedente della volontà o convinzione popolare, con cui pur sovente è confusa: anzitutto occorre considerare che opinio significa «credenza», e non «volontà» o «convinzione»; in secondo luogo la volontà o convinzione popolare è uno stato collettivo che sta prima dello svolgersi della consuetudine nel tempo, mentre l'opinio iuris è un atto individuale che, o accompagna il formarsi della consuetudine, o, secondo un'interpretazione forse più plausibile, addirittura la segue. La convinzione popolare esprime l'idea di una fondazione del diritto consuetudinario prima della ripetizione; l'opinio iuris di una fondazione contemporanea o successiva alla ripetizione.
Importa sottolineare che la derivazione del carattere giuridico del diritto consuetudinario dall'atteggiamento dei destinatari è stata fatta valere per determinare non soltanto la nozione specifica di diritto consuetudinario, ma anche quella generica di diritto, da parte delle cosiddette teorie psicologiche del diritto: ad esempio, il MICELI afferma che norma giuridica è «quella che viene come tale ritenuta» (6); più recentemente lo HAESAERT sostiene che ciò che contraddistingue il diritto dal costume, dalle regole del gioco, ecc., è l'atteggiamento di dipendenza che noi assumiamo di fronte alle prime contrapposto all'atteggiamento libero con cui eseguiamo le seconde (7). Lo ZITELMANN, che chiamò psicologica la sua dottrina, secondo cui la validità giuridica di una norma dipende dalla rappresentazione che il soggetto si fa del suo ripetersi nel tempo e dalla previsione della sua applicazione in futuro, aveva molto chiaramente affermato che questa spiegazione valeva tanto per il diritto legislativo quanto per il consuetudinario, ed era ottenuta non già attraverso la riduzione della consuetudine alla legge, come facevano i più, ma, all'inverso, della legge alla consuetudine (8). Diritto legislativo e diritto consuetudinario sono siffattamente intrecciati nella fenomenologia giuridica di ogni tempo che, mentre la teoria tradizionale della voluntas tacita del popolo ha cercato di spiegare la consuetudine riportandola alla legge, la teoria psicologica del diritto ha cercato, al contrario, di spiegare la legge riconducendola alla consuetudine. Sarebbe facile dire che sono due visioni unilaterali del diritto, che scambiano il problema del diritto con una delle sue fonti, se non fosse che diritto legislativo e diritto consuetudinario, oltre che due fonti del diritto, sono anche due aspetti mal distinguibili e insieme concorrenti della formazione giuridica, il momento della posizione o della nascita della regola e il momento della sua evoluzione ed efficacia nel tempo.
Cadute in discredito le teorie psicologiche con il prevalere del positivismo giuridico di orientamento normativistico, anche il requisito dell'opinio iuris è stato spesso sottoposto a critica, e mentre continua ad essere accolto dalla giurisprudenza, è guardato con diffidenza dalla dottrina: si veda, ad esempio, quel che ne disse il KELSEN, e da noi il FERRARA (9). Le difficoltà, cui va incontro la teoria dell'opinio iuris sono, su per giù, le seguenti. Si può osservare, anzitutto, che la sua ammissione implica un circolo vizioso: da un lato, si afferma che la norma giuridica consuetudinaria non si costituisce se non esiste l'opinio; ma, dall'altro lato, l'opiniopresuppone che la norma giuridica sia già costituita. In altre parole, essa presuppone proprio quel diritto, che dovrebbe contribuire a costituire. Da questa difficoltà si può uscire con due possibili soluzioni che non sono esse stesse scevre di inconvenienti: o si riconosce che l'opinio è fondata sopra un errore, nel senso che la credenza nell'obbligatorietà di un comportamento è derivata dalla falsa credenza che esistesse una norma giuridica che in realtà non esiste; oppure si ammette che l'opinio non abbia valore costitutivo del diritto consuetudinario, perché la credenza nell'obbligatorietà di un comportamento presuppone che già esista una regola giuridica valida, ma soltanto probativo, e pertanto appartenga non già al momento della formazione della consuetudine, ma a quello della sua efficacia, dopo che è stata formata. Seguendo la prima via si giunge alla stranezza di concepire tutto il diritto consuetudinario, proprio quel diritto che vien di solito decorato degli attributi «spontaneo», «immediato», «corrispondente alla natura delle cose», come fondato sopra un errore collettivo; seguendo la seconda, si finisce per negare proprio quel che si voleva dimostrare, cioè che l'opinio iuris sia necessaria per la formazione della regola consuetudinaria come regola giuridica. Purtroppo, anche come elemento probativo, essa sembra di scarsa utilità per quel carattere di inafferrabilità che è stato il bersaglio preferito dai suoi critici. Si aggiunga che, se non esiste altro modo di provare una credenza che quello di osservare il comportamento che da essa deriva, e il comportamento nel caso dell'opinio è la sottomissione alla regola, il miglior modo di provare se esista l'opinio è di esaminare se sia o non sia stata ripetuta la regola, il che ci riconduce dalla credenza alla ripetizione, cioè dall'elemento interno a quello esterno.
NOTA:
(6) MICELI, Le fonti del diritto dal punto di vista psichico-sociale, Palermo, 1905, 190.
NOTA:
(7) HAESAERT J., Théorie générale du droit, Bruxelles, 1948, 116 ss.
NOTA:
(8) ZITELMANN, Gewohnheitsrecht und Irrthum, in Arch. civ. Prax., 1883, 323-468.
NOTA:
(9) Per il KELSEN cfr. Théorie du droit international coutumier, in Rev. int. théorie du droit, 1939, 253-275; e in generale; ID., Teoria generale del diritto e dello Stato (trad. it.), Milano, 1952, 128-130. Per il FERRARA, Trattato di diritto civile italiano. Parte gen., Roma, 1921, 125 ss. Ma non si dimentichi BONFANTE, Per una revisione della teoria della consuetudine, in Riv. dir. comm., 1904, I, 274 ss.
6. ... nella materia regolata.
Anche nella teoria della consuetudine, come nella teoria generale del diritto, la fragilità dell'elemento soggettivo o psicologico ha suscitato il miraggio di una caratterizzazione attraverso l'elemento oggettivo della materia regolata. Il FERRARA, ad esempio, è passato dalla severa critica dell'opinio iuris, cui ci siamo riferiti nel paragrafo precedente, all'affermazione che diventa diritto solo quel costume «che cade su un oggetto che per sua natura è capace e passibile di una disciplina giuridica» (10). Questa tesi, per la sua apparente obiettività, ha avuto qualche seguito: il FRANCESCHELLI afferma che è una consuetudine giuridica quella che «verte su una materia che per il carattere dell'interesse in conflitto, o per la sua stessa natura, sia giuridica (non sociale o di etichetta, ecc.)»(11), e precisa che il giudice non crea la regola consuetudinaria perché «non fa che accertare che, nella fattispecie sottopostagli, il comportamento ripetuto si è avverato rispetto ad un rapporto o interesse meritevole di tutela giuridica secondo le regole valide in quel momento nell'ordinamento in cui opera» (12). Il LONGO definisce l'uso giuridico come «prassi relativa a fatti di rilevanza giuridica», e quindi sostiene che, perché esista un uso giuridico, basta che esista «in un campo di rilevanza giuridica una prassi e cioè un'abitudine» (13). È curioso che anche uno studioso, come il ROSS, particolarmente sensibile all'aspetto comportamentistico del diritto, di fronte al problema della distinzione fra costume e consuetudine giuridica, non trovi altra soluzione per caratterizzare la seconda che quella di definirla come «un costume in una sfera di vita che è (o diviene) oggetto di regolamentazione giuridica» (14). L'opinio necessitatis, secondo il ROSS, non è un carattere costitutivo della consuetudine giuridica, perché accompagna ogni forma di consuetudine: la differenza tra una consuetudine che regola la modalità di pagamento di merci e quella che regola l'uso della toga all'università, sta nel fatto che la questione del pagamento è oggetto di regolamentazione giuridica, mentre «la materia dell'abbigliamento non è normalmente regolata dal diritto» (15).
Che la nozione del diritto possa essere data ratione materiae, è contestabile. La definizione materiale del diritto (e quindi anche della consuetudine giuridica) difficilmente può andare al di là dell'affermazione che oggetto di regolamentazione giuridica sono rapporti intersoggettivi; ma siccome rapporti intersoggettivi sono in gran parte pure quelli regolati dalle norme morali o sociali, quella definizione non risolve il problema della differentia specifica. Certamente le regole che chiamiamo giuridiche si riferiscono normalmente, in tutte le società, a certe materie piuttosto che a certe altre (16) . Ma a parte il fatto che ci sono materie-limite, regolate dal diritto in alcune società e non in altre, anche nelle materie regolate non tutte le regole che si riferiscono ad esse sono o diventano giuridiche. Nelle materie regolate normalmente dal diritto (per usare l'espressione del ROSS) vi possono essere regole del costume, e viceversa vi possono essere regole giuridiche in materie non regolate normalmente dal diritto: materia normalmente giuridica e regolamentazione giuridica sono nozioni distinte. Di qua è nata l'esigenza di cercare un carattere comune alle diverse materie giuridiche, diverso dalla generica intersoggettività o socialità. Chi scrive suggerì la distinzione tra regole essenziali alla costituzione e alla conservazione del gruppo e regole inessenziali, donde la distinzione tra «la consuetudine che tramanda regole meramente estrinseche e non necessarie all'esistenza del gruppo (la moda, la foggia del vestire, ecc.) e la consuetudine che tramanda regole incidenti sulla struttura, sulla natura, sulle finalità stesse del gruppo» (17) ; la prima mera regola del costume, la seconda regola giuridica. Fu osservato che questa «essenzialità» era «tanto tanto grigia», più che una spiegazione, la notazione di un rapporto che può coprire tante cose (18) . Ciò nonostante il criterio è stato recentemente accolto dal PIGLIARU nella redazione delle regole consuetudinarie della vendetta barbaricina, allo scopo di distinguere le regole giuridiche da accogliere e quelle non giuridiche da respingere (19) : ad esempio, la pratica che al delatore vada recisa la gola con un taglio da orecchio a orecchio è stata espunta, perché accidentale, inessenziale alla vendetta, non legata da un rapporto di necessità alla norma principale che impone la vendetta come un dovere. Ma questa inessenzialità come si trova? Se elemento fondamentale di prova è la non frequente ripetizione, si torna al requisito esterno; se è la mancata convinzione collettiva che quell'atto sia necessario, si torna al requisito interno. La necessità sociale di un comportamento è qualche cosa che inerisce al comportamento in quanto tale, o non è piuttosto il riflesso di una ripetizione e di una convinzione?
NOTA:
(10) FERRARA, op. cit., 139.
NOTA:
(11) FRANCESCHELLI, Consuetudine, in Noviss. dig it., IV, Torino, 1959, 324 a.
NOTA:
(12) FRANCESCHELLI, op. cit., 324 b.
NOTA:
(13) LONGO M., Introduzione allo studio degli usi giuridici in campo privatistico, in Temi, 1949, 526.
NOTA:
(14) Ross A., On Law and Justice, London, 1958, 93-94.
NOTA:
(15) Ross A., op. cit., 94.
NOTA:
(16) Un etnografo e comparatista come il MAZZARELLA, nella sua opera Gli elementi irriduttibili dei sistemi giuridici, Catania, 1918, considera come atti giuridicamente rilevanti quelli che si riferiscono a queste dieci materie: 1) forme aggregative; 2) matrimonio; 3) parentela; 4) giurisdizione domestica; 5) proprietà; 6) obbligazioni; 7) successioni; 8) struttura politica; 9) pene; 10) processo.
NOTA:
(17) BOBBIO, La consuetudine come fatto normativo, Padova, 1942, 77.
NOTA:
(18) GIANNINI M. S., Sulla consuetudine, in Riv. intern. fil. dir., 1947, 92.
NOTA:
(19) PIGLIARU, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, 1959, 62 ss.
7. ... nel riconoscimento del giudice.
Sul fondamento della consuetudine la dottrina che ha avuto forse maggior seguito dalla fine del secolo scorso in poi è quella che considera giuridica la norma consuetudinaria, accolta e applicata dal giudice nella soluzione di una controversia. Prima dell'applicazione al caso concreto da parte del giudice, non vi sarebbero regole giuridiche, ma solo regole del costume. Quando il giudice, tra le molte regole del costume che gli si presentano, ne accoglie una come criterio di soluzione per una determinata controversia, questa diventa da quel momento, e solo da quel momento in poi, una regola giuridica.
Questo modo di intendere il diritto consuetudinario si riconnette a quella teoria generale del diritto, diffusa soprattutto tra i giuristi anglosassoni, ma anche nel continente ad opera della Scuola del libero diritto, secondo cui per diritto si intende il complesso delle regole applicate dai tribunali. Il fondatore della Scuola del libero diritto, Hermann KANTOROWICZ, disse in un saggio del 1928 che il diritto è «il complesso delle regole della condotta esterna della cui applicazione è incaricato il giudice» (20) , e in un'operetta postuma sulla definizione del diritto ribadisce che il diritto è un insieme di regole della condotta esterna, come il costume, ma si distingue da questo perché è justiciable, cioè «è suscettibile di essere applicato da un organo giudiziario con una procedura ben definita» (21) . Con questa teoria il momento decisivo del diritto è quello dell'applicazione giudiziaria, cioè della risposta alla violazione della regola rivolta ai membri della società. Il giudice è il personaggio che entra in scena in questa fase del ciclo giuridico, ed è quindi all'attività del giudice che viene attribuita la funzione di trasformare una regola del costume in una regola giuridica.
A questo punto siamo meglio in grado di vedere come la teoria del diritto consuetudinario, non diversamente da quella generale del diritto, abbia cercato il proprio sostegno, mettendo, di volta in volta, in risalto i diversi soggetti che concorrono alla vita della regola giuridica nel suo intero ciclo: il legislatore che la pone, il membro del gruppo cui è rivolta, il giudice che la applica in caso di violazione. Vi è però una differenza rilevante tra le prime due teorie e l'ultima, quella che stiamo esaminando in questo paragrafo. Le prime due hanno dovuto mettere in rilievo una particolare proprietà del rispettivo soggetto per contrassegnare le regole giuridiche da quelle non giuridiche. Generalmente, riguardo al soggetto ponente si è ricorso al carattere della sovranità, onde la definizione del diritto come complesso di regole poste dal potere sovrano; riguardo ai soggetti destinatari, si è cercato di individuare il particolare atteggiamento con cui la regola giuridica è seguita, onde le teorie del riconoscimento, della convinzione, in genere dell'opinio iuris. Solo rispetto alla teoria del giudice, si ha riguardo alla funzione senza ulteriore ricerca di note caratteristiche: il diritto è il complesso delle regole connesse in qualche modo alla funzione del giudice.
Una esplicita formulazione della teoria giudiziaria del diritto consuetudinario si trova nell'AUSTIN, il quale distingue modi diretti e modi indiretti di formazione del diritto: tra i modi indiretti vi è il diritto giudiziario che trasforma il costume in regola giuridica (22) . In Inghilterra oggi è dottrina comune che la common law debba essere interpretata come diritto non consuetudinario, ma giudiziario (v. COMMON LAW). Nel continente la più ampia e documentata formulazione della teoria giuridica della consuetudine si deve al LAMBERT, il quale svolse una ampia e documentata critica della teoria romano-canonistica, per giungere all'affermazione che soltanto la pratica giudiziaria dà alla consuetudine forza giuridica (23) . In Germania la tesi era già stata precedentemente sostenuta dallo SCHULTZE, dal BÜLOW, in parte anche dallo SCHUPPE, e diventò una delle tesi ricorrenti nei testi della Scuola del diritto libero (24) . Se ne fece eco il ROSS, in un'opera fondamentale sulle fonti del diritto (25) . Nota comune a tutti gli autori che sono inclini ad appoggiare questa teoria, che si può chiamare austiniana, è la scarsa considerazione della consuetudine come fonte giuridica di per se stessa, addirittura la trasformazione del diritto consuetudinario in diritto giudiziario; il che porta alla scomparsa di un diritto consuetudinario propriamente detto.
La tesi, nella sua estrema e più conseguente formulazione, è difficilmente accettabile, ed è stata sottoposta a critiche piuttosto imbarazzanti. Due argomenti sono soprattutto degni di rilievo. Si è osservato in primo luogo che la tesi della riduzione del diritto consuetudinario a diritto giudiziario può essere accolta per le consuetudini giuridiche private, non per quelle pubbliche, in particolare per quelle costituzionali che si formano avendo per utenti organi forniti di potestà d'impero: tali consuetudini vengono considerate giuridiche e distinte dalle regole del costume o della correttezza costituzionale, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla prassi giudiziaria (26) . In secondo luogo, si tratta di sapere, pur limitatamente al diritto consuetudinario tra privati, se il giudice in ogni caso sia libero di applicare questa o quella regola consuetudinaria o di non applicarne alcuna, oppure in qualche caso sia obbligato ad applicare una determinata regola consuetudinaria. Se si ammette anche questa seconda possibilità, si accetta l'esistenza di un diritto consuetudinario preesistente al riconoscimento del giudice, o, in altre parole, si accetta l'esistenza di una regola, la cui obbligatorietà non dipende dalla forza che le attribuisce il giudice, dal momento stesso che questa forza essa la possiede di già nei confronti del giudice stesso. Il problema era stato formulato con chiarezza dallo SCHUPPE (1890), il quale sin nelle prime righe della sua monografia si domandava: come avviene che la consuetudine acquisti tale forza da obbligare il giudice a tenerne conto? (27) . Anche Max RÜMELIN, iniziando il suo saggio sulla forza vincolante della consuetudine (1929), impostava immediatamente il problema in questi termini: vi sono regole giuridiche, a cui il giudice sia vincolato nello stesso modo che alle statuizioni del legislatore, e come sono fatte queste regole? (28) . Affinché si possa accettare legittimamente l'esistenza di un diritto consuetudinario, occorre ammettere che vi siano regole consuetudinarie, obbligatorie non soltanto nei confronti dei membri del gruppo, ma anche dei giudici. Le teorie della volontà tacita, dell'opinio iuris e della materia giuridica, mirano a spiegare ciò che la teoria della riduzione del diritto consuetudinario a diritto giudiziario sembra non avvertire, ovvero il fatto che in alcuni ordinamenti vi sono regole consuetudinarie che il giudice non soltanto è autorizzato, ma è obbligato ad applicare, nel senso che la non applicazione può rendere invalida la sua decisione. Donde ricevono queste consuetudini la loro forza vincolante non solo nei confronti dei cittadini ma anche dei giudici? La teoria giudiziaria o austiniana non può dare una risposta a questa domanda: essa, piuttosto che spiegare il diritto consuetudinario, lo elimina.
NOTA:
(20) KANTOROWICZ, Legal Science. The Summary of its Methodology, in Columbia Law Rev., 1928, 679.
NOTA:
(21) KANTOROWICZ, The Definition of Law, Cambridge, 1958, 79.
NOTA:
(22) AUSTIN J., Lectures on Jurisprudence, London, 1885, 536-537. Una regola del costume, secondo AUSTIN, può divenire giuridica in due modi: o perché è adottata dal sovrano, o perché è assunta come base per la decisione dal giudice. In questo secondo caso la regola giuridica derivata dalla consuetudine è una regola di diritto giudiziario.
NOTA:
(23) LAMBERT, op. cit. In Italia, aderì ben presto alla tesi del LAMBERT il D'AMELIO, La giurisprudenza etnologica e la revisione della teoria della consuetudine, in Riv. dir. pubbl., 1910, 37-45.
NOTA:
(24) SCHULTZE A., Privatrecht und Prozess in ihrer Wechselbeziehung, Freiburg, 1883; BÜLOW O., Gesetz und Richteramt, Leipzig, 1885; SCHUPPE W., Das Gewohnheitsrecht. Zugleich eine Kritik der beiden ersten Paragraphen des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich , Breslau, 1890. Per il diritto libero si veda KISS G., Billigkeit und Recht mit besondere Berücksichtigung der Freirechtsbewegung, in Arch. f. Recht-und Wirtschaftsphil., 1909-10, 536-550.
NOTA:
(25) Ross A., Theorie der Rechtsquellen, Leipzig und Wien, 1929, 426.
NOTA:
(26) Questo argomento è addotto per esempio dal SOMLÒ, nella Juristische Grundlehre2, Leipzig, 1917, 358.
NOTA:
(27) SCHUPPE, op. cit., 3.
NOTA:
(28) RÜMELIN M., Die bindende Kraft des Gewohnheitsrechts und ihre Begründung, Tübingen, 1929, 7.
8. ... nell'appartenenza ad un ordinamento giuridico.
A chi a questo punto volesse saperne di più, cioè volesse sapere quale delle teorie sul fondamento della consuetudine sia quella giusta, si potrebbe rispondere dicendo che nessuna è esclusiva: esse rappresentano null'altro che i principali argomenti adoperati di volta in volta e in diverse circostanze per giustificare l'assunzione, l'esecuzione o l'applicazione di regole la cui formazione non è dovuta a organi a ciò designati e agenti secondo determinate procedure, ma ad una libera e inorganica produzione sociale. Si osservi, in primo luogo, che la teoria della volontà tacita del sovrano e le altre menzionate (opinio iuris, materia regolata, pratica giudiziaria) servono, rispettivamente, a diversi scopi, e quindi in linea di principio non si escludono a vicenda. Mentre la prima fu posta, già dai giuristi romani, per giustificare la forza obbligatoria della consuetudine accanto alla legge, tutte le altre vengono impiegate per distinguere il diritto consuetudinario dal semplice costume. In secondo luogo, se si considerano attentamente le tre ultime teorie, ci si accorge, che, anziché escludersi, si richiamano l'una con l'altra, e formano insieme un circolo.
Cominciamo dalla teoria dell'opinio iuris: come e in quale momento si forma questa credenza? Essa si forma nel momento in cui l'utente ritiene probabile o addirittura certo che, se egli violasse la regola, il suo atto sarebbe considerato illecito dall'organo giudiziario incaricato di mettere in moto l'apparato della coazione. In altre parole, il requisito dell'opinio rimanda alla probabile applicazione della regola da parte del giudice per determinare la sanzione: il che val quanto dire che, dal punto di vista dell'utente, è giuridica quella consuetudine che egli ha fondate ragioni di credere (opinio) che il giudice applicherà. A sua volta la teoria del giudice rimanda a quella della materia: e infatti, con quale criterio questi applica e quindi rende esecutiva ai fini della sanzione una regola consuetudinaria, e ne esclude o ignora altre? Il maggior argomento che il giudice può addurre è fondato ratione materiae, cioè consiste nel dimostrare che essa ha una particolare rilevanza sociale, è necessaria, è giusta, risponde al fine del bene comune e così via. Infine la teoria della materia rinvia a quella dell'opinio e il circolo si chiude: qual è il mezzo per provare che una materia ha particolare rilevanza sociale? Si osserva il comportamento dei consociati e le modalità di esso: si tenderà a rispondere che ha particolare rilevanza sociale, è giusta, è necessaria, quella regola, che è generalmente e costantemente ripetuta con la particolare convinzione della sua obbligatorietà. Questa funzione bivalente del requisito dell'opinio, che per un verso rinvia all'autorità del giudice e per l'altro verso prende avvio dalla materia giuridicamente rilevante, si rivela nella stessa espressione con cui la si designa abitualmente: opinio iuris et necessitatis. Essa può essere intesa tanto come previsione di un certo comportamento del giudice e quindi delle conseguenze che possono derivare dalla violazione, quanto come credenza che si tratti di una regola socialmente necessaria e quindi, per questo rispetto, doverosa.
Uscire dal circolo si può solo facendo un passo ulteriore, abbandonando la considerazione tradizionale del diritto dal punto di vista della singola norma, e avvicinandosi alla più complessa e più comprensiva considerazione del diritto dal punto di vista dell'intero ordinamento giuridico. Dalla teoria dell'istituzione in poi l'attenzione dei giuristi è stata richiamata sul fatto che ciò che noi chiamiamo diritto è un fenomeno sociale complesso, caratterizzato da un certo tipo di organizzazione di poteri con relative funzioni, avente lo scopo di esercitare un certo tipo di controllo sociale: le norme giuridiche non sono mai sole, ma esistono ed esercitano la loro funzione unite in ordinamento. Di qua può sembrare legittimo trasportare il problema della definizione del diritto dal piano della norma a quello dell'ordinamento. Questa trasposizione sembra giustificata dal fatto che su questo secondo piano è più facile trovare un accordo sulla domanda: che cos'è il diritto? E anche dalla considerazione che il criterio con cui il giurista o il giudice prescelgono una norma, l'uno per farne oggetto di studio, l'altro per applicarla, è unicamente quello dell'appartenenza ad un sistema dato.
Proviamo a partire dalla definizione di ordinamento giuridico come insieme di norme garantite da una sanzione istituzionalizzata: chiameremo diritto consuetudinario quelle regole, prodotte per ripetizione costante, generale, uniforme, ecc. che entrano a far parte di un ordinamento così definito. Vi sono due modi principali con cui una regola diventa parte di un ordinamento: 1) in quanto contribuisce a far sorgere e a far agire i poteri cui è affidato il funzionamento del meccanismo della sanzione; 2) in quanto offre ai poteri così costituiti criteri per il giudizio dei conflitti di interesse che possono sorgere tra i membri del gruppo (o tra questi e gli organi dirigenti). Pertanto, se noi partiamo dalla definizione sopra riportata di ordinamento giuridico, considereremo norme giuridiche tutte quelle che in quell'ordinamento adempiono all'una o all'altra delle due funzioni. Torniamo allora alla nostra domanda principale: quand'è che una regola del costume diviene una regola giuridica? In base alle considerazioni precedenti, si dovrebbe dire che una regola del costume diventa giuridica nel momento in cui diventa regola di un certo sistema giuridico. Ciò accade, accettata quella definizione di ordinamento giuridico, in questi due casi: 1) quando da tali regole dipende o a tali regole si ispira la formazione di organi costitutivi dell'ordinamento; 2) quando tali regole sono accolte dagli organi così costituiti come criteri per la risoluzione di un conflitto di interesse. Nella prima categoria rientrano le cosiddette consuetudini costituzionali; nella seconda le consuetudini del diritto privato, compresi gli usi mercantili.
9. Confronto tra consuetudine e legge.
La considerazione della consuetudine in rapporto all'ordinamento giuridico ci porta alle soglie del secondo argomento che ci eravamo proposti: la funzione e la forza del diritto consuetudinario nell'evoluzione del diritto. Questo argomento è strettamente connesso al problema dei rapporti tra consuetudine e legge. Isolatamente considerate, le due fonti rappresentano due momenti diversi dell'evoluzione giuridica: dove l'una è rigogliosa, l'altra cresce stentata; quando l'una progredisce, l'altra decade. È stato detto che tutta la storia del diritto degli ultimi secoli può essere raffigurata come un processo d'involuzione della consuetudine, a cui corrisponde un processo di evoluzione della legge. Due punti mi sembrano particolarmente degni di attenzione in questa parte: 1) pregi e difetti delle due fonti, astrattamente considerate; 2) efficacia del diritto consuetudinario nei diversi ordinamenti storici.
Cominciando dal primo punto, la dottrina si è spesso soffermata sui pregi e difetti delle due fonti per cercare di dare una ragione dell'alterna vicenda dell'una e dell'altra secondo le diverse epoche storiche. Si attribuisce in primo luogo alla legge il vantaggio di essere più certa, cioè di esprimere con maggior precisione e stabilità di significato il contenuto di una regola: questa virtù della legge è connessa particolarmente col suo carattere di ius scriptum. Se si considera pregio dell'amministrazione della giustizia la regolarità e la costanza del giudicato, si ritiene generalmente che a questo scopo serva più la forma in cui si presenta la legge che quella da cui si deve ricavare il contenuto di una consuetudine. Come un qualsiasi altro fatto, la consuetudine, per diventare criterio di giudizio in una controversia, deve essere provata, e non diversamente dalla prova di un fatto, anche la prova della consuetudine, può essere soggetta a contestazione. In una tradizione giuridica secolare, come la nostra, caratterizzata dal principio che il giudice deve giudicare in base ad una regola preesistente, la enunciazione scritta della regola evita l'inconveniente che, accanto al procedimento per provare l'esistenza del fatto in contestazione, si debba svolgere anche il procedimento per provare l'esistenza della regola da applicare. Per ovviare a questo inconveniente, cui darebbe luogo il diritto consuetudinario, si ricorre di solito all'espediente della redazione scritta delle consuetudini, alle quali si applica il principio generale che una regola consuetudinaria trascritta in una raccolta si presume esistente fino a prova contraria: la redazione di una consuetudine non la trasforma in legge per quel che riguarda la sua forza obbligatoria (in un ordinamento in cui non si riconosca alla consuetudine potere di abrogare la legge, la riduzione non le attribuisce certo questo potere), ma la allinea alla legge quanto a certezza, onde resta al giudice il potere non più di accertarne l'esistenza, bensì soltanto di interpretarne il contenuto. Particolarmente importante nella storia del diritto europeo, la redazione di consuetudini promossa da Carlo VII in Francia con l'ordinanza di Montils-les-Tours del 1454, e terminata verso la fine del secolo XVI (29) . Nel nostro diritto positivo un riferimento esplicito alle «raccolte di usi» si trova nell'art. 9 disp. prel. c.c.: tali raccolte sono state affidate alle camere di commercio, industria e agricoltura dal t.u. 20 settembre 1934, n. 2011, e al Ministero per l'industria e il commercio dall'art. 1 d.l. C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152 (30) .
Se la legge offre il vantaggio di esser più certa, la consuetudine, all'opposto, è più flessibile: la certezza produce nella legge una certa rigidità. È stata soprattutto la Scuola storica a mettere in rilievo il contrasto tra la mobilità della consuetudine e la fissità della legge, la quale, una volta posta, rappresenta per il giudice che la deve applicare un letto di Procuste. Oltre che rigida, la legge, in contrapposto alla consuetudine, è stata considerata dalla Scuola storica come prodotto artificiale di una classe dirigente, imposta più con la forza che con la convinzione, e recante in sé un elemento di arbitrarietà e di eteronomia. Si osserva, infine, che la legge, proprio a causa della rigidità che le proviene dalla forma scritta, non può prevedere tutti i casi possibili e, anche se al momento della sua emanazione sembra riflettere con sufficiente chiarezza e completezza la fattispecie regolata, è destinata, presto o tardi, per il naturale evolversi dei rapporti sociali, ad invecchiare. Negli interstizi lasciati liberi dalla legge, continua ad avere efficacia o acquista nuova efficacia, magari contro la volontà stessa del legislatore, che si crede onnipotente ma non è, la consuetudine (consuetudo praeter legem). E anche là dove la legge provvede, ma è oscura o ambigua, la consuetudine, cioè il modo costante con cui la legge viene seguita ed applicata, ne fissa il significato, trascegliendo quello che è più consono ad una equilibrata valutazione degli interessi in gioco (consuetudo secundum legem).
L'altro vantaggio della legge è la maggior rapidità di produzione. Una delle cause della decadenza della consuetudine negli Stati contemporanei è stata individuata nella lentezza con cui essa si forma in una società che l'incessante progresso tecnico rende estremamente mobile. È certo che vi sono forme di intervento, destinate a modificare profondamente una serie di comportamenti, che solo la legge può compiere tempestivamente ed efficacemente: quando vogliamo una riforma sociale, ci rivolgiamo alla legge, non alla consuetudine, la quale è per sua natura conservatrice. Ma proprio per la facilità e rapidità con cui la legge può essere modificata, essa può diventar causa di instabilità e di perturbamenti. La legge ci assicura il vantaggio delle rapide riforme, ma non ci assicura contro lo svantaggio delle riforme cattive. Anche in questo campo, i pro e i contra si bilanciano. Mettiamo da un lato l'unica costituzione inglese, le cui principali regole non sono scritte, e si sono formate per consuetudine, e attraverso la consuetudine vengono tramandate e la dozzina di costituzioni scritte che la Francia ha avuto in poco più di centocinquanta anni: nessuno vorrà negare che la storia costituzionale più esemplare sia quella caratterizzata dall'evoluzione consuetudinaria e non quella dominata dal rapido, troppo rapido, succedersi di leggi scritte.
In realtà il decantare le virtù dell'una o dell'altra forma di produzione giuridica, sino a che legge e consuetudine vengono considerate astrattamente, fuori dal loro contesto storico, è poco più che un elegante esercizio scolastico. Leggi e consuetudine sono sempre esistite, succedendosi con alterna fortuna alla guida della produzione giuridica, perché corrispondono a diversi momenti dello sviluppo giuridico e servono a diverse situazioni. Quel che oggi può essere utile dire è che, nonostante la supremazia incontrastata delle fonti scritte negli ordinamenti statali, la consuetudine non è del tutto estinta, e chi credesse di impadronirsi di un ordinamento positivo considerandone soltanto le fonti scritte, e non cercando di rendersi conto dei comportamenti effettivi, generanti consuetudini, soprattutto nel campo del diritto costituzionale e dei rapporti commerciali, si farebbe un'idea incompleta del diritto vigente.
NOTA:
(29) Cfr. LEBRUN A., La coutume. Ses sources, son autorité en droit privé, Paris, 1932, 17-139.
NOTA:
(30) Per le varie questioni connesse alla prova della consuetudine cfr. BALOSSINI, Consuetudini, usi, pratiche, regole del costume, cit., parte IV.
10. Consuetudine superiore alla legge.
Passando da questa discussione astratta ad un'indagine storica, apprendiamo che legge e consuetudine si trovano a fianco a fianco nei diversi ordinamenti, ma con diversa forza. La storia del diritto consuetudinario (distinta dalla storia delle teorie sul diritto consuetudinario) è la storia del suo contrasto con la legge (e in genere con le fonti scritte) per il primato nella gerarchia delle fonti. Si possono distinguere tre situazioni tipiche: 1) la consuetudine è superiore alla legge; 2) consuetudine e legge hanno pari forza; 3) la legge è superiore alla consuetudine. Seppure un po' schematicamente, si può dire che nella prima situazione la consuetudine successiva abroga la legge (liceità della consuetudo contra legem), mentre la legge successiva non abroga la consuetudine; nella seconda situazione la consuetudine successiva abroga la legge, e viceversa; nella terza situazione la legge successiva abroga la consuetudine, e non accade il contrario (illiceità della consuetudo contra legem).
Un esempio particolarmente interessante della prima situazione lo offre - relativamente alle consuetudini generali, distinte da quelle locali - la storia del diritto inglese. È noto qual parte abbia avuto nella formazione del diritto inglese la common law, considerata per lungo tempo come diritto consuetudinario distinto dal diritto legislativo (statute law). Ancora nel '700 BLACKSTONE scriveva: «Il diritto municipale inglese... può essere distinto con sufficiente proprietà in due specie: la lex non scripta, cioè il diritto non scritto, o il diritto comune; la lex scripta, cioè il diritto scritto legislativo. La lex non scripta include non solo le consuetudini generali o il diritto comune propriamente detto, ma anche le consuetudini particolari di certe parti del reame; e parimenti quelle norme particolari, osservate per consuetudine solo in certe corti e giurisdizioni» (31) . Per lunga tradizione gli interpreti del diritto comune, di cui il maggior rappresentante fu, all'inizio del '600, Sir Edward COKE sostennero la tesi che il potere di legiferare da parte del re non era assoluto, bensì limitato; e questo limite non era posto soltanto dalla legge divina o naturale, ma anche dalla legge comune, che era il diritto consuetudinario del Paese. Ancora all'inizio del '600, il COKE scriveva: «Il re coi suoi atti o con altri modi non può mutare parte alcuna della legge consuetudinaria o del diritto statutario o delle consuetudini del reame» (32). E altrove: «Talvolta il diritto consuetudinario controllerà gli atti del Parlamento e talvolta li giudicherà nulli» (33). Questa tenace resistenza dell'antico diritto consuetudinario all'invadenza del potere regio rappresenta uno degli aspetti fondamentali del costituzionalismo inglese, che si svolse in opposizione all'assolutismo continentale (34): il maggior teorico dell'assolutismo in Inghilterra, Tommaso HOBBES, cercò di smantellare, insieme con la teoria della separazione dei poteri, quella della supremazione della common law (35). Col rafforzarsi della sovranità del parlamento nello stato costituzionale moderno, le vecchie voci dei difensori del diritto comune si sono affievolite, ma non tanto da escludere che «un controllo generale del diritto comune sugli statuti - come si esprime lo ALLEN - non sia, comunque, interamente senza significato, pure al tempo presente, per quanto non giunga sino al diritto di resistere anche allo statuto più draconiano, purché questo esprima chiaramente la propria intenzione» (36). Tale controllo è fondato sul principio dominante «che il diritto comune è più ampio e fondamentale degli statuti e che, dovunque sia possibile, una legge deve essere interpretata in armonia coi princìpi stabiliti dal diritto comune più che in opposizione ad essi» (37). Questo principio non esclude che uno statuto possa derogare al diritto comune: ma è regola tradizionale che lo statuto derogante sia interpretato restrittivamente; il che significa che lo statuto vale, per quella parte in cui deroga al diritto comune, come legge speciale o eccezionale, e trae la sua forza derogante dal fatto di essere non lex superior, ma lex specialis, secondo la massima che una legge speciale, anche se inferiore, deroga alla legge generale.
NOTA:
(31) BLACKSTONE, Commentaires, I, 63.
NOTA:
(32) COKE 12, Reports, 65.
NOTA:
(33) COKE 8, Reports, 118.
NOTA:
(34) Questo contrasto è bene illustrato da MCILWAIN C. H., Costituzionalismo antico e moderno (trad. it.), Venezia, 1956, da cui ho tratto le due citazioni del COKE, 96 e 175.
NOTA:
(35) In particolare nell'opera A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England (1666), di cui ho curato la prima traduzione italiana: T. HOBBES, Opere politiche, Torino, 1959, I, 391-558.
NOTA:
(36) ALLEN C. K., Law in the Making4, Oxford, 1946, 378.
NOTA:
(37) ALLEN, op. cit., 378.
11. Consuetudine pari alla legge.
Come esempio di un ordinamento giuridico, in cui il diritto consuetudinario è più debole che in un diritto di origine consuetudinaria come quello inglese, ma, nello stesso tempo, più forte che negli ordinamenti della maggior parte degli Stati continentali europei, può essere scelto l'ordinamento canonico (v. anche infra: Diritto canonico).
È stato più volte notato che nel diritto canonico si manifestarono, sin dai primi secoli, due correnti, l'una più favorevole, l'altra meno favorevole alla consuetudine (38). Questa incertezza non faceva che riprodurre una contraddizione, su cui si affaticheranno per secoli i commentatori, nei testi romani, dei quali uno, il passo di GIULIANO già citato, ammetteva la forza abrogativa della desuetudine (D. 1, 3, 32), l'altro, una costituzione di COSTANTINO, la escludeva (C. 8, 52, 2). Il primo passo diceva: «Rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislationis, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur »; e il secondo: «Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem ». Per quanto nel Decretum Gratiani si affermi che la consuetudine deve cedere alle leggi divine e naturali, ed anche a quelle umane («Quod vero legibus consuetudo cedat, Ysidorus testatur in Sinonimis lib. II, c. 16», ante c. 1, Usus, dist. XI), nel diritto delle Decretali questa dottrina viene largamente attenuata, e da esse ha inizio un indirizzo favorevole allo sviluppo della consuetudine, cui viene riconosciuto un sempre più vasto campo d'azione. Nella decretale Quum tanto di Gregorio IX, da cui ha inizio la teoria canonistica della consuetudine (39), si trova l'affermazione secondo cui la consuetudine ha forza di abrogare la legge, qualora le siano riconosciuti i due requisiti della rationabilitas e della legitima praescriptio. Il testo di Gregorio IX si presenta come una modificazione o limitazione della sopra citata costituzione di COSTANTINO, in cui si disconosceva alla consuetudine la forza di abrogare la legge. La costituzione è trascritta e corretta in questo modo: «Licet etiam longaevae consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tamen est usque adeo valitura, ut vel iuri positivo debeat praeiudicium generare, nisi fuerit rationabilis et legitime praescripta » (cap. XI, Quum tanto, X, 1, 4). Da allora la forza abrogatrice della consuetudine, se pur entro i limiti della razionalità e della prescrizione, non viene più disconosciuta. Nella prima grande sistemazione dottrinale della consuetudine secondo il diritto canonico, quella dell'OSTIENSE (sec. XIII), alla consuetudine sono attribuiti cinque effetti, tra cui quello di abrogare e disconoscere la legge precedente. Nella Summa di Giovanni ANDREA (sec. XIV), viene esposta la dottrina del quasi perfetto equilibrio fra consuetudine e legge nella gerarchia delle fonti: è la dottrina secondo cui tra una consuetudine e una legge contrarie vale quella che è cronologicamente posteriore, sempre che si tratti di una consuetudine rationabilis: o la consuetudine è anteriore alla legge e allora la legge prevale su di essa; o è la legge anteriore alla consuetudine, e allora prevale la consuetudine. È superfluo aggiungere che nella soluzione delle incompatibilità normative, il criterio cronologico si applica quando due norme hanno pari grado; là dove le norme sono su due piani diversi, il criterio gerarchico prevale su quello cronologico (40). Il più largo riconoscimento alla consuetudine abrogatrice si trova nell'opera fondamentale in materia, il libro VII del De legibus del SUAREZ (sec. XVII); da un lato SUAREZ, nel cap. IV, non si limita ad affermare che la consuetudine può abrogare, oltre la legge civile, anche la legge canonica: «Regula certa est legem humanam sive canonicam, sive civilem, posse consuetudine abrogari» (41), ma cerca di darne la dimostrazione richiamandosi allapotestas del popolo e alla volontà popolare che la consuetudine stessa rivela; d'altro canto, nel cap. XIX, esclude tutte le limitazioni che venivano poste alla forza abrogatrice della consuetudine in alcune specie di leggi, come le penali, le irritantes, quelle che proibiscono le consuetudini contrarie e quelle relative ai sacramenti.
Nel passo citato, in cui SUAREZ afferma la forza abrogatrice della consuetudine, aggiungeva: «In hoc omnes doctores conveniunt». In effetti, la dottrina della consuetudine abrogatrice è rimasta per secoli costante tra i dottori del diritto canonico, fino ad essere accolta nel Codex iuris canonici, ove, al can. 27, com'è noto, si ammette che la consuetudine possa abrogare la legge umana, se rationabilis e durata quarant'anni, e anche la legge proibente le consuetudini future, se rationabilis e centenaria (o immemorabile).
NOTA:
(38) Cfr. BRIE, op. cit., 61 ss.
NOTA:
(39) Come osserva il WEHRLÉ, autore dell'opera fondamentale in materia: De la coutume dans le droit canonique, Paris, 1928.
NOTA:
(40) Traggo le citazioni dei due canonisti dall'opera del WEHRLÉ, citata nella nota precedente, che ne riporta integralmente il testo (p. 177 e 242).
NOTA:
(41) Cito dall'edizione della Opera Omnia, VI, Paris, 1847, 200.
12. Consuetudine inferiore alla legge.
Gli ordinamenti giuridici degli Stati, in cui vigorosa è stata l'influenza del diritto romano ed è avvenuta in tempi più o meno recenti la codificazione del diritto privato, come la Francia e l'Italia (in minor misura la Germania), sono esempi di sistemi a quasi assoluta prevalenza del diritto legislativo, ove la consuetudine è fonte subordinata e ha funzione sussidiaria. Una delle conseguenze delle codificazioni rispetto alla forza obbligatoria della consuetudine è l'estendersi e il consolidarsi, fino a diventare opinione quasi unanime, della dottrina che rifiuta la consuetudine contra legem e ne accetta l'efficacia soltanto secundum legem e, con qualche limitazione, praeter legem.
Nel diritto francese, l'art. 7 della legge 30 ventoso, anno XII, abrogava le consuetudini generali e locali relative a materie formanti oggetto del Codice napoleonico; rimanevano in vita solo le consuetudini cui la legge espressamente si riferiva e, secondo l'interpretazione più larga, quelle relative a materie non regolate. Dal principio, secondo cui la legge non poteva essere abrogata se non da un'altra legge, si deduceva la regola che proibiva la consuetudine contra legem, e tale regola è diventata dottrina dominante(42). Questo mutamento radicale nella forza della consuetudine può essere espresso esemplarmente con le parole di AUBRY e RAU, che dànno voce all'opinione media del giurista francese: prima della codificazione la consuetudine era generalmente ammessa, perché era compatibile con un sistema assolutistico, e magari anche con un sistema democratico di governo; ma in seguito essa doveva essere esclusa, perché non era più compatibile con un ordinamento fondato sul principio della separazione dei poteri (43). Il LEBRUN ci ha dato dell'evoluzione del diritto consuetudinario in Francia, una sintesi che può valere in genere per gli ordinamenti il cui sbocco è stata la codificazione: «Dal X secolo al XII il nostro diritto era stato puramente consuetudinario; poi, erano apparse le prime ordinanze. Il periodo monarchico aveva rappresentato una fase transitoria durante la quale la consuetudine non aveva cessato di decadere. Infine, venne la codificazione, e all'indomani della promulgazione dei codici, il nostro diritto diventò esclusivamente legislativo. La rivalità tra legge e consuetudine terminava con la sconfitta di questa ultima. La codificazione consacrava la sua rovina e il trionfo della legge» (44).
Quanto al diritto italiano, la teoria della consuetudine veniva formulata, sotto l'impero del codice civile del 1865, in base all'art. 48 disp. att. per quel che riguarda la consuetudine praeter legem, e in base all'art. 5 disp. sulla legge in gen. per quel che riguarda la consuetudine contra legem. L'art. 48 citato disponeva che «gli usi e le consuetudini a cui il codice stesso espressamente non si riferiva» cessavano «di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo» «nelle materie che formano soggetto del nuovo codice». Era aperta la discussione se la consuetudine praeter legem avesse vigore nelle materie non regolate dal codice, ma era prevalente la tendenza restrittiva, che si valeva principalmente di due argomenti: il rifiuto di ammettere che vi fossero materie non regolate, e l'ammissione che vi fossero, sì, materie non regolate, ma in queste gli strumenti previsti per l'integrazione non fossero già gli usi ma l'analogia o i princìpi generali del diritto. L'art. 5 disp. sulla legge in gen. prevedeva l'abrogazione espressa e tacita della legge da parte della legge, e quindi escludeva implicitamente la consuetudine abrogativa. Il lamento funebre per la consuetudine ormai estinta diventò costante nella dottrina. Dallo STOLFI: «La consuetudine è ormai ridotta a scarsissima importanza nel diritto civile»(45) al FERRARA: «Del triplice valore che si attribuisce alla consuetudine: integrativa, interpretativa, abrogativa, non resta che il primo, e questo nei soli casi in cui la legge attribuisce tale efficacia» (46), il coro era all'unisono (47). Più larga parte alla consuetudine integrativa era fatta nel codice di commercio del 1882, ove l'art. 1 dichiarava che, in mancanza delle leggi commerciali, si dovessero osservare gli usi mercantili: ma quanto alla consuetudine abrogativa valeva anche in questa materia il principio generale che la escludeva. Quanto al codice civile attuale, basti dire che l'art. 15 disp. prel. c.c. sull'abrogazione delle leggi riproduce esattamente l'art. 5 disp. sulla legge in gen. del codice precedente, e che pertanto vien confermato l'ostracismo alla consuetudine abrogativa, in altre parole vien ribadita la considerazione della consuetudine come fonte gerarchicamente inferiore e sussidiaria (48) (sul punto v. peraltro anche infra: Diritto costituzionale).
NOTA:
(42) Per un elenco di opinioni cfr. LEBRUN, op. cit., 465, nota 1. Anche lo GÉNY, uno dei giuristi meno tradizionalisti, è contrario alla consuetudine abrogatrice: «Tutto considerato, poiché bisogna tener conto delle esigenze dell'ora attuale, ritengo, in linea di principio e nello stato presente della nostra civiltà, che convenga respingere ogni consuetudine formalmente contraria alla legge scritta» (Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif2, I, Paris, 1919, 409).
NOTA:
(43) AUBRY et RAU, Droit civil français6, a cura di E. BARTIN, I, Paris, 1936, 29.
NOTA:
(44) LEBRUN, op. cit., 135-136. Ma il LEBRUN, sulla base della reale evoluzione del diritto in Francia, ritiene che non si possa escludere del tutto l'efficacia della consuetudine contra legem. Analogamente, CHARMONT J., La coutume contre la loi, in Revue de métaphysique et de morale, 1917, 469-476. Contra, DE KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, Le code civil et la coutume. Revision de la notion de coutume, in Etudes de droit civil à la mémoire de H. Capitant, Paris, s.d., 403-415, il quale sostiene addirittura che ammettere la consuetudine contra legem significherebbe «il ritorno alla vita sociale primitiva, regolata dalla giustizia privata» (p. 415).
NOTA:
(45) STOLFI, Diritto civile, I, Torino, 1917, 419.
NOTA:
(46) FERRARA, op. cit., 143.
NOTA:
(47) Per una documentazione favorevole alla communis opinio, cfr. DEGNI F., L'autorità del diritto consuetudinario nella legislazione civile italiana, Napoli, 1906 (estratto dagli Studi in onore di C. Fadda). Ma non erano mancate voci contrarie: ad esempio il VANNI, il quale riteneva, sì, esclusa la consuetudine contra legem, ma non la desuetudine (Della consuetudine nei suoi rapporti col diritto e colla legislazione, in Saggi di filosofia sociale e giuridica, Bologna, 1906, 111 ss.).
NOTA:
(48) Più favorevole alla forza abrogatrice della consuetudine è stata la dottrina tedesca. Dal SAVIGNY (Sistema, trad. it., I, Torino, 1886, 102-103) al WINDSCHEID (Pandette, trad. it., I, Torino, 1902, 59) la consuetudine contra legem fu sempre, se pur con qualche limitazione, accettata. Il primo progetto del codice civile (1888), il quale al § 2 ammetteva la consuetudine là soltanto dove fosse espressamente richiamata dalla legge, suscitò molte critiche tanto che tale disposizione scomparve nel progetto definitivo e nel codice, il quale non dispone nulla in materia di consuetudine. Il libro dello SCHUPPE, già citato, fu scritto in occasione di quel progetto per criticarne la tendenza contraria al diritto consuetudinario. Nella stessa occasione, ma in senso opposto, il saggio di RÜMELIN G., Das Gewohnheitsrecht, in Jherings Jahrb., 1889, 153-252. Il silenzio del codice ha fatto sì che anche la dottrina civilistica odierna sia favorevole alla consuetudine contra legem: cfr. ENNECCERUS-NIPPERDEY, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts14, Tübingen, 1952, Erster Halbband, 165.
13. Consuetudine e legge nell'evoluzione del diritto.
La diversa prevalenza della consuetudine e della legge è un criterio che serve a distinguere le diverse epoche giuridiche, i diversi tipi di società statale, i diversi tipi di ordinamento giuridico (49). La prevalenza della consuetudine caratterizza: 1) le epoche primitive, di solito le società barbariche, ove un potere centrale esiste, sì, ma ha funzioni prevalentemente militari, ed affida la funzione della disciplina giuridica al potere sacerdotale; 2) Stati con molti centri di potere in concorrenza tra loro come era, ad esempio, lo stato feudale, se si prende questa espressione in senso largo, come l'antitesi dello stato burocratico: esempio caratteristico è il predominio della common law nello stato inglese del Medioevo; 3) ordinamenti decentrati, come l'ordinamento internazionale, in cui non esiste un organo centrale per la produzione di norme generali valide per tutta la collettività. Sinteticamente, la consuetudine si sviluppa e fiorisce ai margini o a dispetto o in mancanza di un potere centrale fortemente organizzato, là dove il potere centrale è limitato o debole o addirittura inesistente.
Ma contrariamente a quella che è stata l'opinione dominante al tempo della più intransigente concezione statuale e legalistica del diritto, la consuetudine non è destinata a scomparire mai del tutto, neppure nello Stato moderno fortemente accentrato. Se mai, negli Stati moderni, si constata una progressiva diminuzione del diritto consuetudinario via via che si accresce la disciplina giuridica del settore economico, perché la sfera del libero scambio economico è quella tradizionalmente più feconda per la formazione di regole consuetudinarie: il diritto consuetudinario sarà quindi più fiorente in uno Stato a struttura capitalistica che in uno a struttura collettivistica. Se il diritto consuetudinario è la produzione giuridica propria delle società inorganiche, è naturale che la sua influenza diminuisca con l'allargarsi dei settori organizzati della società civile, sottostante allo Stato. Ma anche in una società collettivistica vi è una sfera di rapporti in cui difficilmente la disciplina legislativa è sufficiente: la sfera dei rapporti tra organi pubblici o politici, ove si formano le consuetudini costituzionali. Chi voglia oggi conoscere la realtà costituzionale dell'U.R.S.S. non deve limitarsi a studiare gli articoli della Costituzione e delle leggi costituzionali, ma deve rendersi conto degli effettivi rapporti di potere fra i vari organi.
Infine, vi è un aspetto della nozione di consuetudine, per cui essa non solo non può scomparire mai del tutto, ma è anzi un momento permanente di ogni ordinamento giuridico: ogni regola giuridica, quale che sia la sua provenienza, acquista efficacia attraverso la ripetizione costante dei comportamenti regolati. Prescindiamo dalla questione, soprattutto oggi tanto controversa, se sia opportuno distinguere, nei confronti di una norma singola, la validità giuridica dalla efficacia. Ma è certo e non contestato che rispetto ad un ordinamento giuridico nel suo complesso, si può dire che questo esiste solo se è efficace, ed è efficace solo se la maggior parte delle sue norme sono spontaneamente rispettate o fatte rispettare, se, in altre parole, si forma quella ripetizione costante, uniforme, generale di comportamenti conformi in cui consiste appunto una consuetudine. A lungo andare un ordinamento sopravvive solo se la maggior parte delle sue norme dànno origine a consuetudini conformi. La consuetudine non è solo, secondo la vecchia massima di PAOLO, optima legum interpres (D. 1, 3, 47), ma è anche la nutrice e alimentatrice della legge: la consuetudine fa qualche cosa di più che interpretare la legge, la mantiene in vita. Quando alla legge manca l'appoggio di quel consenso tacito, in cui per lunga tradizione i giuristi hanno visto il carattere saliente della consuetudine, si affloscia, vien meno, diventa lettera morta. Molto spesso la differenza fra diritto legislativo e consuetudinario consiste nel fatto che nel primo si forma in un primo tempo la regola astratta, che viene poi convalidata dalla consuetudine, nel secondo, prima la consuetudine, che viene poi fissata in una regola astratta.
In questa prospettiva legge e consuetudine appaiono, più che due diversi canali di formazione del diritto, i due momenti dialettici del fenomeno complesso della produzione giuridica. Così accade che l'accentuazione dell'uno o dell'altro, da parte della dottrina, sia spesso il prodotto più che di una spregiudicata analisi della realtà, di orientamenti generali della cultura favorevoli ad una concezione naturalistica piuttosto che convenzionalistica, realistica piuttosto che razionalistica, della vita sociale. Nel contrasto alla fine del '700 tra fautori della legge e della consuetudine, si esprimeva il contrasto nientemeno che tra illuminismo e romanticismo. Oggi, lo stesso contrasto è uno degli aspetti della polemica permanente tra formalismo e realismo, statualismo e istituzionalismo, oltre tutto, ciò ci dà conferma della necessità della distinzione, da cui abbiamo preso le mosse, tra storia della consuetudine e storia della dottrina sulla consuetudine, e ci autorizza a concludere che la consuetudine ha nella prima un'importanza maggiore di quel che appaia, di solito, nella seconda.
NOTA:
(49) Il problema dei rapporti tra consuetudine e legge, e della decadenza della consuetudine, è stato trattato recentemente da GUARINO A., La consuetudine e la legge alla luce dell'esperienza romana, in Dir. giur., 1956, 413-428.
LETTERATURA.
In questa bibliografia sono indicate soltanto opere specifiche e generali sulla consuetudine: sono pertanto escluse sia le opere che trattano della consuetudine insieme con altri argomenti (come le monografie sulle fonti del diritto e in genere tutti i trattati di filosofia del diritto, di teoria generale del diritto, e le parti generali dei trattati sulle singole materie); sia quelle che considerano un solo aspetto del problema della consuetudine (la consuetudine nelle singole materie e nei singoli ordinamenti, oppure singole questioni, come la prova, l'errore, questo o quel requisito, ecc.); alcuni di questi saggi parziali sono citati nelle note al testo: BALOSSINI C. E.,Consuetudini, usi, pratiche, regole del costume, Milano, 1958;
BOBBIO N., La consuetudine come fatto normativo, Padova, 1942;
BRIE S., Die Lehre vom Gewohnheitsrecht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung, parte I, Breslau, 1899;
DAHN F., Rechtsphilosophische Studien, Berlin, 1883, 234-269;
FLUMENE F., La consuetudine nel suo valore giuridico, Sassari, 1925;
KNITSCHKY W., Gewohnheitsrecht und Gerichtsgebrauch, in Arch. f. öff. Recht, 1898, 161-252;
LAMBERT E., La fonction du droit civil comparé, Paris, 1903 (sulla storia e la dottrina della consuetudine, 111-804);
LEBRUN A., La coutume. Ses sources, son autorité en droit privé, Paris, 1932;
MOKRE J., Zur Theorie des Gewohnheitsrechts, in Zeit. f. öff. Recht, 1932, 2 e 3;
MORI U.-CHECCUCCI, Gli usi normativi come fattispecie, Genova, 1948;
NEUKAMP E., Das Gewohnheitsrecht in Theorie und Praxis des gemeinen Rechts, in Arch. f. bürg. Recht, 1897, 89-184;
PARESCE E., La genesi ideale del diritto. Saggio sull'attuazione spontanea del diritto e la sua creatività, Milano, 1938;
PROSDOCIMI L., Observantia. Ricerche sull'aspetto consuetudinario del diritto dai commentatori alla scuola storica: I. I commentatori e i pratici italiani, Milano, 1960;
PUCHTA G. F., Das Gewohnheitsrecht, Erlangen, I, 1828, II, 1837;
ROMANO S., Consuetudine, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947;
RÜMELIN G., Das Gewohnheitsrecht, in Jherings Jahrb., 1889, 153-253;
RÜMELIN M., Die, bindende Kraft des Gewohnheitsrechts und ihre Begründung, Tübingen, 1929;
SCHMIDT B., Das Gewohnheitsrecht als Form des Gemeinwillens, Leipzig, 1899;
SCHUPPE W., Das Gewohnheitsrecht. Zugleich eine Kritik der beiden ersten Paragraphen des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetsbuches für das deutsche Reich , Breslau, 1890;
SIOTTO M.-PINTOR, Riflessioni sul tema della consuetudine nel diritto interno, in Studi di diritto pubblico in onore di O. Ranelletti, II, Padova, 1931, 253-273;
TESAURO A., La consuetudine, in Rass. dir. pubbl., 1955, I, 189-207;
VANNI, Della consuetudine nei suoi rapporti col diritto e colla legislazione, Perugia, 1877 (in Saggi di filosofia sociale e giuridica, Bologna, 1906, 1-127);
WEHRLÉ R., De la coutume dans le droit canonique. Essai historique s'étendant des origines de l'Eglise au pontificat de Pie XI, Paris, 1928;
ZITELMANN E., Gewohnheitsrecht und Irrthum, in Arch. civ. Prax., 1883, 323-468.
Fonte: http://davidelaurino.altervista.org/N.%20Bobbio%20-%20Consuetudine%20(Teoria%20generale).docx
Autore del testo: Norberto Bobbio
Parola chiave google : Norberto Bobbio biografia vita e opere tipo file : doc
“Non sono ottimista, ma non per questo credo che ci si debba arrendere. Altro è prevedere, altro è fare la propria scelta. Quando io dico che la scelta è nel senso di non lasciare alcun mezzo intentato per la formazione d’una coscienza atomica, e la filosofia che oggi non si impegna in questa strada è un ozio sterile, non faccio alcuna previsione sul futuro. Mi limito a far intendere quel che con tutte le mie forze vorrei non accadesse, anche se in fondo in fondo alla mia coscienza ho l’oscuro presentimento che accadrà. Ma la posta in gioco è troppo alta perché non si debba, ciascuno dalla propria parte, prendere posizione, benché le probabilità di vincere siano piccolissime. Qualche volta è accaduto che un granello di sabbia sollevato dal vento abbia fermato una macchina. Anche se ci fosse un miliardesimo di miliardesimo di probabilità che il granello, sollevato dal vento, vada a finire nel più delicato degli ingranaggi per arrestarne il movimento, la macchina che stiamo costruendo è troppo mostruosa perché non valga la pena di sfidare il destino”
(Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, 1979).
Norberto Bobbio: fedele fino alla fine al proprio dubbio
“Se ne va un altro baluardo contro la rinascente barbarie, anzi un altro infaticabile coltivatore di civiltà”.
Con queste parole, dalle colonne di Avvenire, Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di Bose, commenta la morte di Norberto Bobbio. Si tratta forse della dichiarazione più densa ed equilibrata fra quelle che si sono lette sui quotidiani subito dopo la dipartita del filosofo. Le altre sono sature di una retorica che vorrebbe, a seconda dei casi, enfatizzare pleonasticamente le qualità del maestro o celare maldestramente il disagio di chi è costretto a chinarsi davanti alla indiscutibile grandezza dell’avversario. Ma la retorica, soprattutto quella post mortem, non si addice al Professore, descritto da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, per esserne stato allievo a Torino negli anni caldi della lotta studentesca, come dotato di un “temperamento piemontese, cortese e formale, schivo da grandi entusiasmi e da ogni platealità”, il che è del resto confermato dalla sobrietà cui Bobbio stesso ha voluto fosse improntato il proprio funerale.
Confesso di conoscere poco o nulla del suo pensiero, perché sono altre le rotte che finora ho seguito nell’immenso mare della conoscenza, ma come cittadina di un Paese che sembra sprofondare giorno dopo giorno nei gorghi dello squallore, del compromesso, della meschinità, avverto, dopo la sua morte, un ulteriore vuoto e mi sento ancor più indifesa di fronte all’imperversare della barbarie. Una barbarie dai mille volti, ma che consiste, essenzialmente, nella perversa ostinazione nel considerare gli altri e il mondo intero come materiale grezzo, da utilizzare senza scrupoli per innalzare il proprio personale altare.
Chissà cosa pensava il Professore dei meccanismi tentacolari che soffocano, nel mondo accademico, l’emergere di spiriti liberi? E il Senatore a vita dei suoi colleghi parlamentari? Se è corretta l’idea che, leggendo i quotidiani, mi sono fatta dell’uomo, credo che reagisse alla barbarie con mite fermezza, con signorile distacco, con un pessimismo mai disperato. Di quella civiltà che, per riprendere la bella metafora di Enzo Bianchi, ha infaticabilmente coltivato, oltre che semplice maestro, era esempio vivo, come attesta chi l’ha conosciuto: “Era sempre disponibile al dialogo, a cui si rapportava con stile attico, essenziale, e con metodo razionale, senza mai concedere nulla a qualsiasi debolezza o sentimento se non alla ragione, citando sempre le fonti delle argomentazioni che poneva a confronto. Ha cercato in tutti i modi di comprendere le ragioni del movimento studentesco, nato alla fine degli anni ’60, e di contrastare con coraggio le posizioni estreme che lo stesso movimento ha assunto nel corso degli anni ’70, attraverso il confronto e le ragioni di un filosofo che della politica percepiva la potenza e viveva il disincanto”.
Queste parole delineano il profilo di un uomo che conosceva e praticava ai massimi livelli la difficile arte del dialogo, che sublima i più radicati istinti di sopraffazione violenta dell’avversario trasferendo lo scontro sul piano razionale e verbale, senza mai derogare da un assoluto rigore di metodo. Con la sua implacabile razionalità, affinata dalla pratica quotidiana della speculazione e del confronto, ha affrontato anche gli interrogativi sui problemi ultimi: il male, la morte, la fede. Ed ecco cosa affermava a tale proposito, scostando appena il velo di pudore che sempre custodiva il suo sentire più profondo: “In realtà, se dovessi veramente cercare di giungere sino infondo dei miei pensieri e delle mie convinzioni, sarei tentato di dire che io sono piuttosto un uomo di dubbio che di una qualsiasi fede, sia pure quelle laica. Se fede laica vuol dire fede nell’uomo, mi domando se questa fede non sia altrettanto soggetta al dubbio di quella religiosa. Allora non resta che il senso - che può anche essere angoscioso, ma è l’ultimo termine cui giunge la nostra ragione - del mistero. Non è forse questo senso del mistero che lega profondamente e indissolubilmente gli uomini dell’una e dell’altra fede?”. Se il mistero di cui la morte ci svela l’essenza abbia l’inquietante sembianza del nulla o uno dei volti che le varie fedi gli attribuiscono non ci è dato sapere. Ma è bello l’esempio di chi ha la forza di varcare con serenità e disincanto l’estrema soglia, fedele fino alla fine al proprio dubbio. Ora che ha attraversato il punto dove - come credeva Platone - la foce si rivela essere la sorgente, possa il Professore trovare lì pace e riposo. Questa era la sua sola speranza.
Fonte: http://tempoper.altervista.org/ARTICOLO%20BOBBIO.doc
Autrice : di Myriam Perdichizzi
Norberto Bobbio biografia vita e opere
Visita la nostra pagina principale
Norberto Bobbio biografia vita e opere
Termini d' uso e privacy