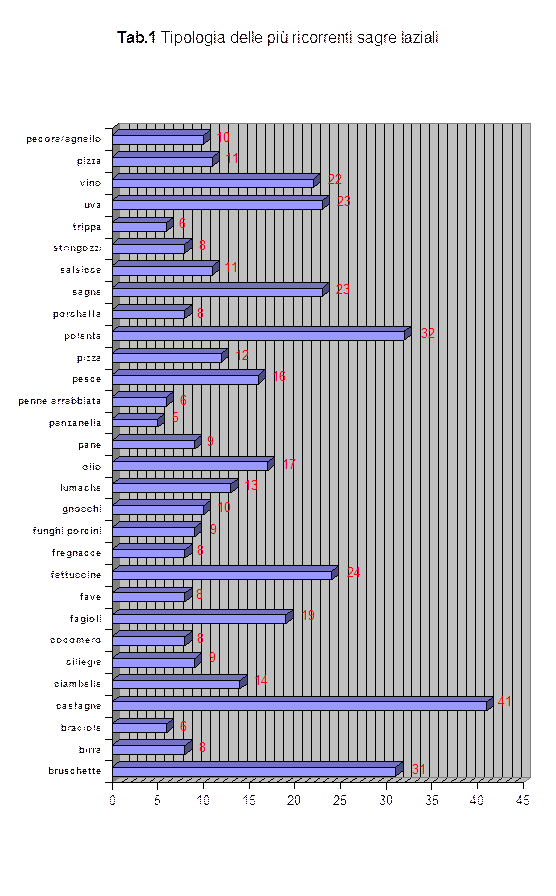Storia delle tradizioni popolari
Storia delle tradizioni popolari
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
Dispense ed appunti del corso monografico di
Storia delle Tradizioni Popolari
- a. 2010-2011
Ernesto Di Renzo
INDICE
- Il “cibo locale” tra comunicazione mass-mediatica e marketing turistico del territorio
- Oltre l’edibile. Su alcune valenze antropologico-culturali del cibo
- Mangiare geografico: i modelli alimentari nel lazio tra tradizione e riproposizione culturale
- Case study II. Effetto Sagra: gastronomie di piazza nel Lazio rurale contemporaneo.
Il “cibo locale”
tra comunicazione mass-mediatica
e marketing turistico del territorio
Da alcuni anni, gli spazi della comunicazione mass-mediatica si sono venuti affollando di notizie, consigli, dibattiti, commenti e riflessioni riguardanti il cosiddetto “cibo locale”, proponendolo come una sorta di “controriforma alimentare” da opporre al mito anglosassone del fast food (Teti, 1999). Esaltato come salutisticamente appropriato e gastronomically correct con i paradigmi alimentari espressi su scala territoriale, il cibo locale (o tipico, o paesano, o caratteristico, o genuino) costituirebbe cioè l’uscita di sicurezza in grado di redimere i gusti contemporanei da infauste derive esterofile ed iperlipidiche, consentendone un riorientamento in chiave narcisisticamente “nostrana”: quindi piemontese, emiliana, irpina, teramana, salentina, gallurese, oratinese. E così, casce e ova, scripelle m’busse, paparotte, bazzoffie, strinù, turcinatieddi, musciame, ciciri e tria, ciufulitti, minchiarieddhi, batù, cres’tajat, mandilli de sea, hanno progressivamente assunto la connotazione di un “mangiare geografico” capace di riconnettere gusto e tradizioni, ricette e stagioni, appetiti e salute, stomaci e cittadinanze, secondo consuetudini sedimentatesi nella storia culinaria di ciascun territorio.
Questo richiamo al mangiare geografico, perorato da autorevoli guru dei mass-media (nutrizionisti, philosophes de table, vip-gourmet, giornalisti-gastronauti) e da importanti presìdi della promozione turistico-locale (Pro Loco, Assessorati, Agenzie per il turismo, Consorzi di produzione, Distretti del gusto) come il modo più corretto di approcciarsi alle pratiche del nutrimento, individua i suoi presupposti in necessità di ordine economico, ecologico e culturale.
Ovverosia:
- nel bisogno di tutelare le bio-diversità del territorio, che rischiano altrimenti di sparire sotto la standardizzazione degli alimenti messa in atto dalle multinazionali del cibo, della ristorazione industriale e della grande distribuzione;
- nel bisogno di contribuire alla salute generale del pianeta, favorendo la riduzione del monossido di carbonio mediante la riterritorializzazione delle derrate e la riproposizione di filiere corte capaci di incidere vantaggiosamente sulla dinamica dei prezzi (le cosiddette cucine a “chilometri zero”)
- nel bisogno di salvaguardare il proprio sé identitario dai processi di omologazione che trasformano ovunque le persone in consumatori, vale a dire delle perfette macchine digerenti piegate ai dettami dei consigli pubblicitari e della cucina globalizzata.
- nel correlato bisogno di garantire un sostegno alle autenticità e ai sapori del territorio, irrimediabilmente corrosi dal dissolversi della “civiltà rurale” e vieppiù esposti ai fenomeni di metissage e di esotizzazione dei gusti.
Riferitamente a quest’ultimo aspetto, chiosa in maniera del tutto consona Chef Kumalè (2007: 5):
Sono in molti a temere che il fenomeno dell’esotizzazione dell’offerta gastronomica rappresenti una minaccia alla nostra identità e alla nostra cucina tradizionale. [Al riguardo] alcuni partiti politici hanno addirittura lanciato nuovi slogan per resistere a queste nuove presenze, del tipo “polenta sì, Couscous no!” nel vano tentativo di arginare il fenomeno di circolazione e scambio che da sempre contraddistingue la storia dell’alimentazione, dimenticando fra l’altro che il mais non è certo un prodotto d’origine padana […]
Contro un simile dilagare del livellamento e dell’esotizzazione dei gusti, in Italia, così come nel resto dell’Occidente post-moderno, “genuino”, “autentico”, “casereccio” hanno via via assunto la connotazione di un modo di mangiare coerente con le istanze della tradizionalità (da una parte) e dell’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente (dall’altra). Un modo di mangiare, tuttavia, che se da una parte annovera a sè nuclei indiscutibili di verità – una porzione di pizza e m’nestra molisana è pur sempre da ritenersi identitariamente e nutrizionalmente preferibile ad un mulligan's monster, ad un whatafarm burger, ad un quadruple bypass burger o ad una qualsiasi altra “prelibatezza” da Junk food – dall’altra rischia di indurre nel malinteso che mangiando cibi e piatti locali «si possano far rivivere sapori autentici di cui si avverte l’infelice mancanza» (Di Renzo, 2009, 28).
Ma l’illusione del “mangiare l’autentico” non è l’unico fraintendimento al quale rischia di condurre il battage massmediatico o il marketing territoriale legato alla promozione turisticogastronomica dei cibi locali. Accanto a tale fraintendimento, infatti, ne sussiste anche un altro di diverso genere che ha attinenza con la gamma dei consumatori e che chiama in causa i prezzi “fuori misura” con cui farro, pane nero, finocchiona, ventricina, cicerchie, mostarde di frutta, caci podolici, orapi, vengono posti in vendita negli scaffali delle “botteghe del gusto” o nelle tavole delle hostarie tipiche. Prezzi che risultando (spesso) accessibili alle disponibilità economiche di poche selezionate categorie di persone trovano la loro fondata giustificazione nelle nozioni di “patina” e di “nostalgia da tavolino” con le quali, per Arjun Appadurai, viene abilmente manipolata l’immagine della tradizione – rurale, agro-pastorale, marinaresca, popolare – a fini commerciali, turistici e di appartenenza identitaria (2001: 104-109):
La nostalgia [da tavolino] è uno scaltro strumento nella cassetta degli attrezzi del pubblicitario […] Rovistare nella storia è diventata una procedura standard della pubblicità, soprattutto dei messaggi pubblicitari visivi ed elettronici, come mezzo per suscitare in determinate classi d’età nostalgia genuina per passati conosciuti poi di fatto solo attraverso esperienze altrui, ma anche come modo per rimarcare che il presente è intrinsecamente effimero.
Con ciò si vuol far risaltare come dietro il revival dei cibi locali si celino sovente simbolismi e dinamiche di distinzione sociale non sempre apertamente dichiarate e non da tutti chiaramente percepite. Detto in altre parole, e con le dovute cautele, si vuol segnalare come dietro l’attuale riscoperta dei cibi locali ci sia:
l’esperienza polisensoriale di alcune privilegiate categorie di persone post-consumatrici di massa che fanno del ricorso al tradizionale, al genuino, al tipico al casereccio, uno stile alternativo di vita per attuare nuove forme di distinzione sociale. (Costa, 2007: 341)
In proposito, nota molto pertinentemente Simone Cinotto (2006: 635):
Il discorso della nostalgia alimentare e il rinnovato interesse nelle produzioni locali e regionali ha in sé certamente elementi di reazione all’internazionalizzazione della dieta che poggiano sulla narrazione del cibo “di una volta” come cibo semplice, robusto, domestico e familiare. E tuttavia questo cibo genuino ed essenziale finisce per prendere la via soprattutto di ristoranti alla moda o di castelli di campagna riattati a tali. Si produce, in altre parole, l’ennesimo paradosso e l’ennesimo rovesciamento storico della globalizzazione culinaria, per cui solo ai ricchi è concesso di mangiare come i contadini: una nicchia più o meno ampia di consumatori seleziona con cura piccole produzioni d’eccellenza dal percorso tracciabile o le consuma direttamente sul luogo di produzione.
Ne consegue che la possibilità di nutrirsi dei ricercati cibi certificati TRAD, IGT, STG, DOP, DOC, rappresenta un appannaggio destinato per lo più alle fasce sociali più abbienti e selezionate; laddove, viceversa, alla massa generalizzata dei consumatori viene riservato l’uso di cibi scaffalati,
«surgelati, pastorizzati, industrialmente confezionati, gustativamente standardizzati, geneticamente modificati, geograficamente delocalizzati e televisivamente garantiti». (Di Renzo, 2009, 22).
Chiarisce con attinenza Chef Kumalè (2007: 14-15):
I gourmet e gli edonisti del terzo millennio, ovvero coloro che fanno della ricerca del piacere il proprio indirizzo di vita, hanno la loro dispensa colma di prodotti di nicchia e d'eccellenza. Comprano preferibilmente in enoteca e gastronomia, se non direttamente dai produttori, magari consorziandosi tra amici attraverso i siti internet. Conoscono più o meno chiaramente il significato delle diverse sigle che contraddistinguono le denominazioni d'orìgine, s'informano d'ogni nuovo ristorante e produttore attraverso le guide specialìstìche e le riviste dì settore, facendo sfoggio delle conoscenze in occasione di cene e degustazioni luculliane tra amici, giocando ad abbinare i migliori vini con i piatti ed i prodotti dell'enogastronomia. Affollano i saloni e le fiere culinarie, viaggiano con gusto, frequentando le migliori trattorie o i ristoranti stellati. La loro cucina è molto ben attrezzata con pentolarne tradizionale o neo-tecnologico, coltelli di ultima generazione, cavatappi ipermoderni; apprezzano il gusto antico delle cose ma anche il design più innovativo, ripudiano il kitsch e le imitazioni. Amano viaggiare nel confort e se possono permeiterselo anche nel lusso tra resort esclusivi e ristoranti di cucina d'autore. Generalmente si tratta di persone di livello culturale e classe sociale medio alta.
Simili rimandi, esemplificando in maniera «estremizzata e caricaturale» una tendenza assai diffusa tra le abitudini alimentari delle élites urbane e post-moderne del mondo occidentale, testimoniano in definitiva come la nostalgia alimentare al tempo della globalizzazione culinaria sia sostanzialmente da intendersi come un fenomeno di moda che «tende a ricreare, in un riordinamento simbolico non privo di ironia storica, vecchie divisioni di classe basate sul consumo vistoso, la rarità di ciò che si consuma e il capitale culturale e finanziario del consumatore».
(Cinotto, 2006: 636).
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
APPADURAI A. (2001), Modernità in polvere, Roma, Meltemi
CHEF KUMALÈ (2007), Il mondo a tavola, Torino, Einaudi
CINOTTO S. (2006), Il mondo nel piatto. Globalizzazione e cucine nazionali tra passato e presente, «Quaderni Storici», XLI, 123, 3, Bologna, Il Mulino
COSTA N. (2007), La nuova imprenditoria del settore agrituristico nell’area metropolitana di Roma, in F. SALVATORI, E. DI RENZO (a cura di), Roma e la sua campagna. Itinerari del XX secolo, Roma, Società Geografica Italiana
DI RENZO E. (2009), Mangiare geografico: i modelli alimentari nel Lazio tra tradizione e riproposizione culturale, «Documenti geografici», Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
TETI V. (1999), Il colore del cibo, Roma, Meltemi
OLTRE L’EDIBILE.
Su alcune valenze antropologico-culturali del cibo
Premessa
Che il cibo, e l’intero universo di precetti gastronomico-alimentari che ne regolano preparazione e consumo, costituisca uno degli argomenti di più generalizzato dominio del nostro vivere quotidiano è un dato così acclarato da non richiedere eccessive specificazioni di merito.
Che il cibo, e il grande credito discorsivo ad esso tributato, costituisca oggi un’affollata e dibattuta arena del sapere erudito e della cultura ufficiale è invece un dato così originale, e fino a non molto tempo fa del tutto inopinato, da richiedere alcuni minimi e non eludibili chiarimenti. Non fosse altro per fare giustizia di una lunga consuetudine di ostracismi, biasimi e disconoscimenti di cui sono stati fatti oggetto coloro che, forse troppo precocemente, hanno manifestato un interesse “accademico” verso questo tipo di argomento.
Per lungo tempo, infatti, e praticamente fino alle soglie della contemporaneità, le dissertazioni sul cibo e sull’alimentazione hanno rappresentato per la comunità scientifica italiana e internazionale un esercizio del tutto privo di qualunque valore conoscitivo “vero”; hanno cioè rappresentato una tipologia del sapere di serie B da consegnarsi all’impegno di penne volenterose, magari colte, tuttavia distinte e distanti dal mondo della ricerca rigorosamente orientata. In altre parole, il discorso sul cibo ha incarnato una dimensione fatua del sapere nella quale, assai spesso, «lo studioso i cui interessi si spingevano in tale direzione si trovava ad affrontare il non facile compito di liberarsi da un certo qual senso di colpa» . Un senso di colpa rinviante ad un diffuso e grossolano modo di pensare per il quale era da ritenersi scientificamente privo di significato non solo:
tutto ciò che aveva il sapore del quotidiano [o dell’ozioso, o del popolare, o del godereccio], ma anche tutto ciò che era legato alla sfera domestica e quindi, sulla scorta di un’eredità ottocentesca difficile da eliminare, al lavoro femminile, di cui quello in cucina è certamente uno tra i più creativi.
Lo stesso grossolano modo di pensare che ha annoverato tra le sue vittime più illustri finanche Jean Anthelme Brillat-Savarin, autore di quella celebrata Physiologie du Goût destinata a segnare una pietra miliare della moderna scienza culinaria. Difatti, anche per l’autore del celebre aforisma «dimmi come mangi e ti dirò chi sei», il condizionamento esercitato dal pensiero ufficiale, razionalistico, androcentrico, è stato a tal punto stringente e inderogabile da indurlo a pubblicare il suo lavoro (lui che era un magistrato e un uomo di ampia e conclamata cultura scientifica) a proprie spese e privo del suo nome. Ma, si dirà, eravamo ancora nel 1825.
Tuttavia, affinché comincino lentamente ad attenuarsi i sensi di colpa derivanti dall’assumere il cibo ad oggetto focale (non solo incidentale) di studi analiticamente fondati e metodologicamente condotti occorrerà attendere i nuovi sviluppi venutisi a creare nel campo delle discipline umanistico-sociali, ovvero medico-psicologiche, a partire dalla fine degli anni ‘70 del 900 in conseguenza dell’incrociare di tre fondamentali eventi:
- il consolidarsi del boom economico che in epoca post-bellica ha decretato in tutto l’Occidente la fine della precarietà alimentare e la conseguente possibilità di pensare al cibo non più come ad una necessità da soddisfare per sopravvivere ma (pure) come ad oggetto su cui riflettere per conoscersi, comunicare e vivere meglio;
- l’onda corta (ma anche lunga se pensiamo in prospettiva attuale) innescata dagli studi di Ancel Keys sulla dieta mediterranea; studi che, scardinando in pieno benessere alimentare il mito della bistecca e rivalutando quello ipocolesterolico della pastasciutta ha diviso il mondo accademico e quello dell’industria alimentare in due acerrime partigianerie, ciascuna impegnata ad incentivare e far prevalere ricerche “inoppugnabili” volte a dimostrare la bontà delle proprie ragioni riformistiche e controriformistiche;
- l’avvento dei paradigmi post-modernisti che, rinunciando ovunque alla pretesa di perseguire obiettivi di razionalismo scientifico propri del formalismo, del marxismo, dello strutturalismo, del materialismo culturale, e mirando a rifondare l’epistemologia del sapere su basi più umanistico-interpretative ha aperto la strada a nuovi campi e dimensioni della conoscenza.
Di riflesso a ciò, quelli che fino al ventennio precedente erano stati gli interessi di ricerca di pochi studiosi di scienze umane e sociali iniziano man mano a diventare gli snodi di riflessione di un numero sempre maggiore di sociologi, antropologi, storici, psicologi e demologi, evidentemente non più ancorati a paradigmi riduzionistici del proprio sapere disciplinare e (soprattutto) sempre più “sensibili” al crescendo mediatico-commerciale coagulatosi attorno al cibo e ai discorsi che su di esso si potevano vantaggiosamente fare.
In Italia, il diffondersi generalizzato del benessere, l’onda lunga degli studi nutrizionistico-alimentari portati avanti dal Keys e dalla sua scuola, nonché la ventata di novità intellettuale sollecitata dalla sensibilità post-modernista, hanno iniziato a produrre concreti effetti di ricerca solo a partire dalla fine degli anni ’80 inizi anni ’90. A partire da allora, e con forza sempre più prorompente, il dibattito sul cibo ha pervaso esponenzialmente l’interesse pubblico, finendo con il fuoriuscire dai suoi normali circuiti di produzione/vendita/consumo per catodizzarsi, editorializzarsi, vetrinizzarsi, cinematografizzarsi, feticizzarsi, fierizzarsi, medicalizzarsi, eticizzarsi, popolarizzarsi e, come ultime inevitabili conseguenze, sdoganarsi culturalmente e accreditarsi accademicamente. Uno sdoganamento e un accreditamento da cui è conseguito un inarrestabile gemmare di corsi e master universitari, di convegni scientifici, di forum, di tavole rotonde, di saggi e riviste a tema, di siti e portali web, di specializzazioni disciplinari volte a scandagliare il cibo sotto ogni sua valenza di contenuto, dimensione di significato nonché evenienza di remunerabilità economica.
La dimensione “sovrastrutturale” del cibo
Questa recente valorizzazione del cibo come “discorso” da affrontarsi sul piano della conoscibilità e del rigore scientifico, sottraendo la sfera gastronomico-alimentare ad una dimensione strettamente gourmettistica, manualistico-culinaria e domestico-femminile ha di fatto collocato il tema dell’alimentazione nella sua dimensione che più gli compete: quella culturale.
E che il cibo, oltre ad essere nutrimento (of course) sia anche e soprattutto cultura sono lì a documentarcelo secoli di fonti scritte e interi repertori di testimonianze etnografiche. Da esse è possibile evincere come per l’uomo di ogni epoca storica e contesto geografico gli alimenti non sono mai stati semplice materia prima atta a soddisfare la necessità fisiologica della sopravvivenza, bensì prodotti fortemente investiti di significato sociale, religioso, comunicativo, identitario e, non ultimo gustativo-sensoriale.
Le stesse attività di caccia e raccolta, che qualcuno potrebbe citare a giudizio come la dimostrazione palese di una fruizione puramente nutrizionale del cibo, costituiscono in realtà delle pratiche già fortemente investite di specifiche valenze culturali. Se non altro perché nessun cacciatore è stato mai lì ad attendere che l’animale morisse di vecchiaia o di malattia per consumarne a morsi le sue parti edibili, ma ha adottato via via più complesse tecniche di selezionamento, accaparramento, trasformazione e consumo delle carni. Tecniche che procedendo dalle semplici pratiche di scuoiatura, arrostitura, bollitura, frollatura, affumicatura, salatura dei vari quarti con lo scopo di renderli più appetibili/digeribili/conservabili, sono andate evolvendosi verso procedimenti sempre più artefatti, includenti marinatura, salmistratura, fumettatura, congelamento, liofilizzazione, sterilizzazione fino ad arrivare alle recentissime frontiere della molecolarizzazione e della ricomposizione materica.
Ma la culturalità e la culturabilità del cibo non riguardano solo la sfera delle tecniche messe in atto per favorire i processi di assunzione e assimilazione degli alimenti. Esse, infatti, si possono cogliere anche nel modo in cui questi ultimi vengono differentemente caricati di valori nutrizionali, gustativi, simbolici ed economici che ne rendono praticabile, o inaccessibile, il consumo da parte di determinate società o categorie di persone.
Per ebrei e musulmani osservanti, che il maiale sia un animale tabù è un fatto che non ha nulla a che vedere con la sua indisponibilità a ruminare o con la nocività/ipercaloricità delle sue carni, largamente apprezzate da milioni di europei, americani e asiatici residenti a cavallo dell’equatore. Al contrario è una proibizione culturale dipendente da precise sollecitazioni storiche ed economico/produttive che in certe epoche e in certi contesti geografici si è reso necessario adottare per garantire la coesione e la sopravvivenza delle stesse società che ne hanno favorito il consolidamento. E’ inoltre una proibizione che si è successivamente ed efficacemente provveduto a rafforzare e blindare attraverso il crisma sanzionatorio del verbo sacro, cosicché la sua trasgressione avrebbe significato per l’uomo non solo infrangere una norma sociale (estinguibile tramite una ammenda più o meno gravosa) bensì una disposizione divina assai più difficile da sanare (soprattutto in assenza di procedimenti rituali o sacramentali compensativi).
Per gli europei del XVII e di buona parte del XVIII secolo, che la patata appena importata dal Nuovo Mondo fosse ritenuta pericolosa per la salute umana non aveva nulla a che vedere con la reale tossicità del tubero bensì era la conseguenza di un processo mentale che la caricava di ripercussioni del tutto estranee alla sua piena commestibilità. Ripercussioni che si riteneva potessero comprendere lebbra, scrofola e altre patologie di grave afflizione per l’uomo. Affinché il pregiudizio sulla velenosità della patata riesca ad estinguersi nella mentalità colta e popolare europea occorrerà attendere la seconda metà del XVIII secolo e il verificarsi di numerose carestie che obbligheranno le comunità locali a fare inevitabile ricorso al suo uso alimentare. Un ricorso sempre più frequente e generalizzato che condurrà, nel secolo successivo, non solo a riscattare le sue qualità nutrizionali ma anche ad apprezzare in chiave gastronomica le sue inaspettate doti gustative.
La polisemia degli alimenti
Sempre in riferimento alla dimensione culturale del cibo, e alla componente sovrastrutturale che ne accompagna materialità, circolazione e consumo, può essere del tutto rilevante comprendere come gli alimenti possano (all’occorrenza) diventare oggetto di investimento simbolico al punto da creare delle associazioni molto forti tra ciò che si mangia e le differenti forme di identità: di genere, di ceto, di etnia, di religione e via discorrendo. In questo preciso senso:
da ciò che si mangia, da quanto si mangia, da dove si mangia e da come si mangia, ciascuno comunica di sé, e comprende dell’altro, ciò che più intimamente lo riguarda. Comunica cioè, prima ancora e senza il bisogno di esibire qualsiasi documento di identificazione, da quale territorio si provenga, a quale classe sociale si appartenga, quale culto si professi e perfino quali disagi psicologici si patiscano.
Al riguardo, riflette Tullio Seppilli, all’interno di ogni società, e in relazione ad ogni epoca storica, il cibo viene investito di valori e di significati extra-nutrizionali alle cui basi agiscono complessi e contradditori processi sociali, culturali ed economici. Questi processi fanno sì che spesso singoli alimenti, o classi di alimenti, in base a talune loro caratteristiche come il sapore, l’odore, il costo, la provenienza o la disponibilità sul mercato assumano significati «che si proiettano sulle persone o sui gruppi sociali che ne fanno uso, denotando raffinatezza o volgarità, scarsa vitalità o esuberanza, anti-conformismo, ricchezza, esotismo, creatività o piatta ripetitività». Per siffatta ragione, chiarisce l’antropologo, pressochè ovunque si sviluppano delle vere o proprie stereotipie che sono più o meno da tutti condivise e riconosciute.
Tra le più marcate si possono considerare quelle che stabiliscono delle associazioni simboliche tra alimenti e polarità sessuale, oppure quelle che stabiliscono dei collegamenti tra cibi e polarità ceto-anagrafiche:
In correlazione con i tratti che definiscono la tradizionale dicotomia dei modelli di uomo e di donna, gran parte dei cibi e delle bevande risultano ancora associati a connotazioni di sesso e assumono perciò precise posizioni lungo un asse di polarità in cui ciascun elemento è più maschile o più femminile di altri.
Così ad esempio in Italia, o in gran parte di essa, una grappa è tutt’oggi considerata più maschile di un cognac, che a sua volta è considerato più maschile di un martini, che a sua volta è considerato più maschile di una tisana o del latte. Analogamente, ragionando in termini di prodotti caseari, si può sostenere che una mozzarella è percepita più femminile del parmigiano, che a sua volta è percepito più femminile del pecorino, che a sua volta è percepito più femminile del casu marzu e via dicendo.
Stesso discorso di stereotipie lo si può fare in riferimento alle distinzioni riguardanti i modelli ceto-sociali. Anche in questo molti cibi risultano mentalmente collocati lungo un continuum di valori in relazione al quale ciascun alimento, o piatto, è ritenuto più “signorile” (leggi raffinato) o più “popolare” (leggi grossolano) di un altro. Così ad esempio un’anatra all’arancia è reputata più raffinata di un tacchino ripieno, che a sua volta è reputato più raffinato di un arrosto di pollo, che a sua volta è reputato più raffinato di una trippa alla romana o di una coratella di agnello. Allo stesso modo una minestra di cotiche e fagioli è valutata più grossolana dei bucatini all’amatriciana, i quali sono valutati più grossolani delle pennette al pomodoro e basilico, le quali sono valutate più grossolane di un risotto alle erbe o di una chitarrina al tartufo bianco di Alba.
Ma attenzione. Poiché, come ci ricorda Ferdinand De Saussure, nei simboli il nesso che intercorre tra significante e significato è di natura arbitraria e poiché la cultura (produttrice di simboli) è sempre variabile nelle sue configurazioni storiche e geografiche, può accadere che ciò che in un dato territorio risulta provvisto di valori positivi in un altro venga invece rivestito di valori diametralmente opposti. Così come può accadere che ciò che in una determinata epoca assume connotazioni elitarie in un'altra invece si carichi di connotazioni popolari o di massa. Del tutto emblematico al riguardo è da reputarsi il caso del caffè (o del cioccolato) che, se nell’Europa del XVIII secolo veniva percepito come la bevanda borghese/benestante per eccellenza, a partire dal secolo successivo è diventato un prodotto di largo consumo e di ampissima diffusione popolare.
Altrettanto significativo poi è il caso del caviale che, da cibo per pescatori poveri quale era nelle sue zone geografiche di maggior produzione, è via via diventato un marcatore di agiatezza economica e di raffinatezza di gusti solo a seguito di un lungo processo di “aristocratizzazione”. Ricostruisce al riguardo Luciano Sterpellone:
Mentre ai nostri tempi il caviale rappresenta un vero status symbol per chi siede al ristorante di lusso, nell’antichità era semplicemente il cibo base dei pescatori, che lo estraevano dalla pancia dello storione femmina prima di vendere il resto […] Solo a partire dagli inizi del XX secolo, e in Francia, il caviale incontrò il favore dei viveurs del tempo, entusiasti di tutto ciò che fosse raro e soprattutto “caro”. Ma la gente comune non trovò poi il caviale così tanto gustoso tant’è che all’esposizione Gastronomica del Grand Palais, dove si faceva gustare gratis il caviale, gli organizzatori si videro costretti ad installare delle sputacchiere dinanzi allo stand [che ne offriva l’assaggio].
Un fenomeno di risemantizzazione analogo a quelli del caffè, del caviale, ma anche delle spezie, delle ostriche o del vino, si è di recente imposto alla nostra esperienza quotidiana con i casi del pane nero e delle zuppe di farro: alimenti che fino ad epoche anteriori al boom economico costituivano la monotonia alimentare di tutti quei ceti subalterni che evidentemente non potevano permettersi sia il tanto agognato pane di farina di grano tenero sia i grassi consommé della cucina benestante.
Ebbene, per tutta una serie di sincronismi socio-economico-culturali verificatisi nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo, oggi quello stesso pane nero e quella stessa zuppa di cereali sono per molti diventati un simbolo di prelibatezza e un segnale visivo di appartenenza di classe, posta la rarità di domanda che li accompagna e posto il prezzo “fuori misura” con cui sono messi in vendita nelle botteghe del gusto o nei menù dei ristoranti più à la page. Del resto è proprio dall’antieconomicità e dal consumo selettivo, fanno rilevare sociologi, semiologi e antropologi come Bourdieu, Barthes, Le Breton, che deriva la concettualizzazione di questi (ed altri) alimenti come perfetti marcatori di status elevato e di raffinatezza dei gusti.
Ebbene, da tutto questo esemplificare affiora prepotente il concetto che il cibo, fuoriuscendo da un discorso strettamente nutrizionale, non solo incarna un fatto appartenente alla sfera dei valori socio-economico-produttivi dell’uomo, ma si colloca anche e a pieno titolo nella sfera del simbolico-comunicativo.
In altre parole il cibo, qualunque sia la materia prima che lo componga, si “ipersignifica” come l’assuntore di una dimensione segnico-comunicativa di cui ciascuno fa (ed ha) esperienza più o meno consapevole nei propri comportamenti quotidiani. È infatti la dimensione segnica ciò che fa ritenere buono da mangiare il panettone a Natale o la colomba a Pasqua, rendendoli inadatti al consumo in rapporto a qualunque altro momento dell’anno. È ancora la dimensione segnica ciò che induce a considerare un piatto di trippa alla romana una gustosa ricetta da assaporare in un qualunque giovedì della settimana mentre la rende una portata del tutto inappropriata per un pranzo di nozze. È sempre la dimensione segnica ciò che in occasione di una cena romantica a lume di candela, induce l’invitante ad ordinare una tartare di spigola su verdurine mediterranee, oppure un filetto di vitello in salsa vanigliata su purea di topinambur, piuttosto che rigatoni con la pajata oppure spaghetti aglio e oglio e peperoncino. Piatto di spaghetti che la stessa dimensione segnica ce lo fa invece ritenere del tutto congruo ad intrattenere gli amici durante lo svolgimento televisivo di una partita di campionato.
Brevi conclusioni: il cibo come fabbrica delle identità etnico-territoriali
Asiago, Madeira, Gorgonzola, Chianti, Fiorentina, San Daniele, Champagne, San Marzano, Bavarese, Bordeaux, mortadella di Campotosto, cipolle di Tropea, zafferano di Navelli, culatello di Zibello, speck di Sauris, aceto balsamico di Modena: sia che si impieghino stringati poleonimi, o coronimi, sia che si faccia ricorso ad appena più estese locuzioni binomiali, i cibi esplicitano sovente un’intima connessione con città, territori, regioni, stati.
Vera o inventata, presunta o comprovata, antica o recente la si possa qualificare, tale connessione cibo-territorio reca impressa una delle più evidenti prove degli interventi culturalizzanti operati dall’uomo sulla sfera dell’alimentazione: vuoi per i meccanismi denominativi/identificativi che hanno dato luogo alle citate sinonimie toponomastiche; vuoi per i metodi produttivi localmente escogitati per ottimizzare le modalità di preparazione e gli attributi di gusto; vuoi per le prassi normative messe in atto nei procedimenti di tutela qualitativa degli alimenti.
Tale culturalizzazione, inoltre, soprattutto laddove il concetto di “cibo del territorio” viene posto in strettissima correlazione con quello di tradizione, di memoria e di identità, diventa spesso oggetto di un così deciso processo di intensificazione simbolica da arrivare a compenetrarsi con la sfera delle appartenenze etniche. In simili casi, lo stomaco e i gastrocentrismi diventano allora l’elemento/concetto mediante cui le singole comunità:
- autocelebrano la propria unicità
- inverano la propria identità “mistica”
- radicalizzano/stigmatizzano le forme dell’alterità (Inuit: divoratori di carne cruda, Tedeschi: mangia-patate, Italiani: maccheroni, Veneti: polentoni, Napoletani: mangia-pizza; Avezzanesi: cococciari, Ortucchiesi: ranocchiari)
- perseguono dei profitti di natura economico-commerciale
- chiamano a raccolta nel territorio schiere di food trotter, gastronauti e di enoturisti.
In pratica: l’IGT si fa “totemismo”.
In Italia, così come del resto in tutto il mondo globalizzato, l’affermarsi del totemismo alimentare in chiave anti-omologativa ed auto-celebrativa delle identità locali, da circa un trentennio a questa parte rappresenta un fenomeno in costante crescita che chiama in causa determinanti di varia natura e di complessa interpretazione. È un fenomeno, inoltre, che si appalesa in una gamma diversificata di azioni che vanno dalla costituzione di marchi e di consorzi di tutela all’allestimento di imponenti gastro-liturgie di piazza; dalla riassunzione di spazi e tempi del mangiare more antiquo alla riscoperta della ruralità borghigiana; dal recupero della biodiversità animale e vegetale alla musealizzazione del gusto; dalla riproposizione di piatti e gastronomie della memoria alla sollecitazione di expertises accademico-specialistiche volte a validare il loro legame con il territorio.
Tutto ciò, naturalmente, alla luce di quanto Leon Rappoport, indagando sulle componenti socio-psicologiche del cibo, ha voluto ricordarci con assai perspicace pensiero: «Che ne siamo consapevoli o meno quando mangiamo stiamo inghiottendo non solo un determinato alimento, ma anche il concetto, [la cultura, il territorio] che gli si accompagna».
BIBLOGRAFIA
APPADURAI, A. (1988), How to make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, «Comparative Studies in Society and History», n. 30.
BARTHES, R. (1966), Elementi di semiologia, Torino, Einaudi (ed. or. 1965)
BOURDIEU, P. (1983), La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1979).
BRILLAT-SAVARIN, J.A. (2002), Fisiologia del gusto, Milano, BUR, (ed. or. 1825).
DI RENZO, E. (2006), Il paradigma della cultura nel quadro di una politica di tutela e valorizzazione dell’heritage, «Annali italiani del turismo internazionale», n. 6, Milano, Università degli Studi di Milano- Bicocca
DI RENZO, E. (2008), Il "cibo locale" tra comunicazione mass-mediatica e marketing turistico del territorio, «Annali italiani del turismo internazionale», n. 7, Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
DI RENZO, E. (2009), Mangiare geografico. I modelli alimentari nel lazio tra tradizione e riproposizione culturale, «Documenti geografici», n. 13, 2008, Roma, Università di Roma Tor Vergata.
DOUGLAS, M. (1998), Purezza e Pericolo, Il Mulino, Bologna, (ed. or. 1966).
FISCHLER, C. (1992), L' onnivoro: piacere di mangiare nella storia e nella scienza, Milano, Mondadori, (ed. or. 1990).
FLANDRIN, J. L. (1994), Il gusto e la necessità, Milano, Il Saggiatore.
GOODY, J. (1982), Cooking, cuisine and class: a study in comparative sociology, Cambridge, Cambridge university press.
HARRIS, M. (1990), Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, Torino, Einaudi, (ed. or. 1985).
KEYS, A. (1980), Seven countries: a multivariate analysis of death and coronary heart disease, Cambridge, Harvard University Press.
LE BRETON, D. (2007), Il sapore del mondo: un'antropologia dei sensi, Milano, Cortina, (ed. or. 2006)
LÉVI-STRAUSS, C. (1966), Il crudo e il cotto, Milano, Il Saggiatore, (ed. or. 1964).
LUPTON, D. (1999), L'anima nel piatto, Bologna, Il Mulino, (ed. or. 1996).
MINTZ, S. W. (1996), Tasting Food, Tasting Freedom. Excursions into Eating, Culture and the Past, Boston, Beacon Press.
MONTANARI, M. (2004), Il cibo come cultura, Bari, Laterza.
MONTANARI, M. (1997), I luoghi della cultura alimentare, in Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo (a cura di G. Musca), Bari, Dedalo,.
PEDRINI, C. (2005), Buono. Pulito. Giusto. Principi di nuova gastronomia, Torino, Einaudi.
POULAIN, J.P.(2002), Sociologies de l’alimentation, Paris, Puf.
RAPPOPORT, L. (2003), Come mangiamo: appetito, cultura e psicologia del cibo, Milano, Ponte alle Grazie.
SASSATELLI, R. (2004), L’alimentazione: gusti, pratiche e politiche, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 4.
SEPPILLI, T. (1994), Per una antropologia dell’alimentazione. Determinazioni, funzioni e significati psico-culturali della risposta sociale a un bisogno biologico, «La ricerca folklorica», n. 30.
STERPELLONE, L. (2008), A pranzo con la storia, Torino, SEI.
TETI, V. (1999), Il colore del cibo: geografia, mito e realta dell'alimentazione mediterranea Roma, Meltemi.
MANGIARE GEOGRAFICO: I MODELLI ALIMENTARI NEL LAZIO TRA TRADIZIONE E RIPROPOSIZIONE CULTURALE
Premesse. Il cibo come crocevia di influssi ambientali, materiali e culturali
Comprendere l’intreccio delle relazioni che collegano un modello alimentare al contesto territoriale che lo adotta è una operazione conoscitiva complessa che chiama in causa moventi multifattoriali tra loro strettamente interconnessi.
Non si può infatti pervenire ad una definizione di mangiare geografico, nelle sue differenti declinazioni “mangiare siciliano”, “mangiare abruzzese”, “mangiare laziale”, “mangiare romanesco”, senza che si tengano in debito conto le processualità diacroniche e i rapporti sistemici che il cibo intrattiene con gli assetti morfologici, economico-produttivi, socio-culturali espressi da un determinato territorio.
Per questo, prima di affrontare il discorso delle pratiche gastronomiche tradizionali in uso nel Lazio, e per meglio comprenderne le specificità, si pone indispensabile operare alcune riflessioni preliminari volte a far emergere sia la dimensione antropologica che il cibo sottintende, sia le peculiarità fisionomiche espresse da una regione dai tratti identitari tutt’altro che unitari.
Partiamo dal primo ambito di riflessione. L’alimentazione, nella sua connotazione primaria di risposta fisiologica al bisogno di sopravvivenza, costituisce una strategia adattiva mediante la quale l’uomo si relaziona all’ambiente in cui vive. Al suo interno giocano un ruolo decisivo tanto fattori di tipo materiale quanto fattori di tipo culturale da cui dipendono sia le tipologie dei cibi destinati al consumo alimentare, sia le pratiche culinarie adottate nel confezionamento delle vivande e sia le propensioni dei gusti: vale a dire ciò che a livello individuale e collettivo viene reputato buono o cattivo da mangiare (Harris, 1992, p. 5).
I fattori di tipo materiale sono rappresentati dalla natura orografica dei suoli, dai condizionamenti climatici, dalla qualità mineralogica dei terreni, dagli strumenti e dai metodi utilizzati per il reperimento delle derrate, dal grado di complessità tecnologica con cui vengono gestiti i processi produttivi (agricoltura, allevamento, pesca, caccia, raccolta) che trasformano gli elementi di natura in elementi di cultura.
I fattori culturali, dal canto loro, sono rappresentati dal dipanarsi degli accadimenti storici, dal disporsi dei flussi migratori, dal susseguirsi dei processi di acquisizione/scambio delle conoscenze, dall’influire dei dettami religiosi, dall’alternarsi delle mode e dei costumi che ovunque collegano il cibo alla possibilità (scelta) di essere mangiato o meno. E che il cibo incarni in sé un fatto appartenente a pieno titolo alla sfera dei valori culturali dell’uomo lo si può agevolmente dedurre dalla circostanza che esso, fuoriuscendo da un discorso meramente nutrizionale, si iscrive all’interno delle pratiche identitarie e dei comportamenti socialmente condivisi. Da ciò che si mangia, da quanto si mangia, da dove si mangia e da come si mangia, infatti, ciascuno comunica di sé, e comprende dell’altro, ciò che più intimamente lo riguarda. Comunica cioè, prima ancora e senza il bisogno di esibire qualsiasi documento di identificazione, da quale territorio provenga, a quale classe sociale appartenga, quale culto professi e perfino quali disagi psicologici patisca.
Valgano, al riguardo le seguenti affermazioni (Di Renzo, 2005c, p. 9):
l’alimentazione […] rappresenta un campo globale dell’esperienza umana, un “fatto sociale totale”, attorno al quale tutte le culture organizzano la vita dei loro membri dotandola dei suoi significati più completi. Infatti, se da una parte, e prima di ogni altra cosa, il cibo è essenzialmente nutrimento, sostentamento, bisogno, dall’altra è fondamentalmente cultura, sovrastruttura, pensiero. Se nel suo configurarsi in termini di puro vitto è quanto permette all’uomo di assolvere ai processi biologico-vitali dell’esistenza, nel suo rappresentarsi in termini di “fatto gastronomico” è ciò che gli consente di assurgere a persona simile di chi mangia con lui e come lui: è in pratica un principio generatore di identità territoriali distintive.
Quest’ultima dichiarazione permette di accedere direttamente al secondo livello di riflessione sopra individuato, ossia quello inerente ai modelli alimentari tradizionali in uso nel Lazio. Più precisamente, la domanda che ci si deve porre è la seguente: esiste un modo di mangiare che caratterizzi la gastronomia della regione in modo internamente univoco ed esternamente distinguibile da quella delle altre gastronomie italiane?
Come si cercherà di chiarire, la risposta a tale quesito è tutt’altro che affermativa e scontata, con buona pace di chi intende fare dei “piatti regionali” il cavallo di battaglia di efficaci strategie commerciali volte a perseguire la promozione di marchi alimentari o il marketing turistico del territorio.
Sostiene sull’argomento Vito Teti (1999, pp. 107-108):
le cucine regionali sono essenzialmente una costruzione postmoderna nella quale confluiscono elementi disparati, frammentari, non omogenei, provenienti da diverse località di un territorio più vasto di quello regionale. Alimenti o piatti che oggi vengono inseriti in non sempre ben definite cucine regionali hanno avuto nel passato elaborazione, specializzazione e diffusione quasi esclusivamente locali.
E, per rendere ancora più esplicito il suo pensiero precisa a mo’ di esempio (Ibidem, p. 108):
la ‘nduja, il famoso insaccato preparato con le parti grasse del maiale e con una quantità elevata di peperone piccante, viene oggi pubblicizzato e commercializzato come un insaccato tipico della Calabria, mentre, fino ad anni assai recenti, veniva prodotta esclusivamente a Spilinga e nella zona dell’altopiano del Poro.
Ebbene, le stesse considerazioni che l’antropologo avanza a proposito della sua terra d’origine, possono essere estese anche all’intero territorio nazionale senza possibilità di fraintendimenti o approssimazioni di sorta. Lazio compreso.
Breve quadro descrittivo di una “regione mosaico”
Coerentemente con il pensiero del Teti, e contrariamente a quanto una certa comunicazione mass-mediatica di stampo generalista lascia spesso intendere, la dizione “cucina laziale” è da ritenersi un’espressione (slogan) del tutto priva di livelli oggettivi di riscontro. Al suo posto, dunque, è preferibile usare unità “minime” di definizione tipo “cucina romanesca”, “cucina ciociara”, “cucina sabina”, “cucina viterbese”, “cucina castellana”, in quanto più rispecchianti gli assetti territoriali e socio-culturali espressi dalla regione.
Del resto, che parlare di cucina o gastronomia laziali incarni un indebito abuso linguistico- concettuale lo conferma il fatto che lo stesso Lazio, così come oggi lo si conosce, rappresenta una “invenzione geografica” fatta a tavolino nel corso di un arco cronologico che va dall’Unificazione d’Italia fino agli anni trenta del Novecento. Chiarisce in proposito il Landini (1981, p. 27):
Il Lazio è una regione artificiale in quanto il suo territorio deriva in buona parte da aggregazioni recenti di tipo amministrativo e dal recupero di vaste zone anecumeniche o subecumeniche interne, non suscettibili fino a pochi decenni or sono di un popolamento stabile.
Nel Lazio odierno, spiega più in dettaglio il geografo (ibidem, pp. 18-19)
rientrano parti di Toscana meridionale (la Maremma Laziale, cioè la fascia costiera a nord di Civitavecchia, e la stessa parte settentrionale della Tuscia viterbese), di Umbria (nell'incerto confine tra Acquapendente ed Orvieto, ma soprattutto con Rieti e la Sabina, sottratte nel 1923 alla provincia di Perugia; […] di Abruzzo (l'alto bacino del Tronto, con Amatrice, e l'antico circondario di Cittaducale, aggregati solo nel 1927), e infine di Campania (per l'appartenenza storica di Formia e Gaeta al Regno di Napoli, come per la cessione, ancora nel 1927, di una cinquantina di comuni della provincia di Caserta, allora temporaneamente soppressa, a quella, neocostituita, di Frosinone).
Ma a rendere gli assetti della regione tutt’altro che omogenei ed unitari, oltre ai citati fattori politico-amministrativi, se ne devono considerare anche altri di diverso ordine che si rapportano alle sue contrastanti conformazioni geo-morfologiche, pedologiche, idrografiche, climatiche e paesaggistiche. Da esse dipendono l’alternarsi di differenti ambienti ecologici che oppongono zone montuose a zone di pianura; zone collinari a zone costiere, zone vallive a zone lacustri; così come oppongono suoli calcarei a suoli vulcanici; habitat boschivi (circa il 21% dell’intera superficie regionale e approssimativamente 6% di quella nazionale) ad habitat paludosi; climi marittimi a climi continentali.
L’interazione di tutte queste variabili, unitamente all’intrecciarsi delle dinamiche demografiche che hanno più volte rimodellato la composizione etnica della popolazione (si pensi, una tantum, alla massiccia ondata migratoria che ha visto arrivare migliaia di contadini veneti negli Agri Pontino e Romano all’alba della loro bonifica) non ha mancato di produrre inevitabili ripercussioni sul campo delle attività economiche e delle sfere produttive (nonchè gastronomiche), predisponendone le direttrici di sviluppo in senso frammentario e disomogeneo. In particolar modo, trascurando l’area metropolitana della Capitale e i distretti industriali disposti in spazi assai settorializzati, il Lazio rivela una identità fortemente rurale che perdura da secoli fino ai nostri giorni. Una identità i cui contrassegni peculiari permettono di scorgere nell’agricoltura e nell’allevamento le autentiche matrici “genetiche” del suo territorio. Queste, fatta eccezione per le realtà insulari e per tratti localizzati della fascia litoranea (Civitavecchia, Fiumicino, Anzio, Formia, Gaeta) sembrano non includere in modo rilevante la pesca e la cultura marinaresca, malgrado la regione disponga di circa 360 chilometri di costa.
L’agricoltura, vera spina dorsale dell’economia laziale, fino all’epoca delle grandi opere idrauliche e, successivamente, fino al periodo delle riforme fondiarie degli anni ’50 – ’60 dello scorso secolo, è stata condotta in un regime di sostanziale auto-produzione e auto-consumo, soprattutto nelle zone più interne e di montagna. Dalla sua pratica le comunità locali hanno tratto cereali, ortaggi, legumi, vite e olivo cui, a seguito delle influenze arabe e delle scoperte geografiche, si sono aggiunti mais, agrumi, pomodori e barbabietole (Landini, 1981, p. 48). A questi prodotti “generici”, variamente distribuiti nelle diverse aree della regione, e in ogni caso comuni a gran parte dell’intero territorio nazionale, si assommano poi tutta una serie di varietà autoctone per le quali è invece del tutto legittimo parlare di tipicità locale: fagiolina arsolana, cicerchia di Campodimele, castagna di Vallerano, uva pizzutella di Tivoli, broccoletto di Anguillara, fragolina di Nemi, nocciola del viterbese, lenticchia di Ventotene, carciofo, zucchina e lattuga romanesche, ed altro ancora (Hausmann, 2007, pp. 229-232).
Condizionata lungamente dalle indisponibilità dei suoli, dalla arretratezza tecnologica, dalla scarsezza dei rendimenti e dalla obsolescenza delle strutture fondiarie, all’agricoltura sono da ricondursi gli aspetti più proficui dell’economia territoriale. Inoltre sono da correlarsi le componenti più connotative della cultura popolare con inclusione del patrimonio demoetnoantropologico immateriale (feste, rituali, giochi, proverbi, canti) e materiale (artigianato, abbigliamento, utensileria, gastronomia).
L’allevamento, simbolo archetipico e iconografico della “lazialità” già da epoca latina, sebbene nel tempo abbia visto ridimensionare di molto la sua incidenza in termini occupazionali, rappresenta ancora oggi una voce del tutto autorevole nel quadro della strutturazione del reddito regionale: sia dal punto di vista della produzione delle carni sia da quello lattiero-caseario. E se le attuali pratiche zootecniche evidenziano una palese preponderanza del settore bovino, il cui patrimonio sovrasta la classifica delle regioni italiane centro-meridionali, la pastorizia continua a dimostrare una vitalità del tutto sorprendente ed inopinata, malgrado la crisi che ne ha investito il comparto a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale. La scomparsa della transumanza, la caduta progressiva del valore della lana, il sorgere del mito della bistecca, la messa a coltura intensiva della Campagna Romana (tradizionale meta invernale delle greggi appenniniche), l’abbandono delle aree di montagna e ancor più il rifiuto umano ad applicarsi ad un sistema lavorativo gravoso e totalizzante dell’esistenza, hanno infatti innescato la cortocircuitazione di un modello economico pervicacemente intrecciato all’identità storica della regione, soprattutto in rapporto alla sua geografia interna e montanara.
Nel complesso, dalle attività di allevamento gli abitanti del Lazio hanno da sempre ricavato indispensabili fonti di nutrimento il cui utilizzo nelle gastronomie locali ha dato luogo a molteplici varietà di vivande attualmente al centro di un intenso processo di rivalorizzazione alimentare e commerciale. Si pensi all’abbacchio romano, alle coppiette di suino (un tempo di equino), alla corallina, alla porchetta di Ariccia, agli abbuoti di Viticuso e al tordo matto di Zagarolo, ma si pensi anche, ragionando in termini di derivati, al caciofiore, alla marzolina, al pecorino romano, al “pressato a mano”, al gran cacio di Morolo, alla caciotta romana (Hausmann, 2007, pp. 229-232).
Le molteplici gastronomie tradizionali del territorio laziale
Venendo ora a ragionare dei modelli gastronomici espressi dalle speciali interazioni cultura-ambiente di cui si è dato sintetico ragguaglio, due sono le considerazioni sulle quali è necessario far convergere le riflessioni: come si mangiava nel Lazio prima dell’avvento della globalizzazione e perché si sta tornando a mangiare secondo tendenze (apparentemente) tradizionali. Ciò dando per scontata la non-necessità di doversi soffermare sulle pratiche del mangiare quotidiano, posta l’ovvietà che esse manifestano sul piano dell’esperienza ordinaria. Un’esperienza che vede le nostre tavole imbandite di una gran quantità di cibi precotti, surgelati, pastorizzati, industrialmente confezionati, gustativamente standardizzati, geneticamente modificati e televisivamente garantiti. Un’esperienza nella quale, inoltre, bresaole valtellinesi, caciocavalli ragusani, pesti liguri, ventricine abruzzesi, lardi di Colonnata, tortellini emiliani, entrecotes argentine, camemberts francesi, braciole olandesi, cous cous maghrebini, concorrono a riempire gli stomaci laziali di “alterità” gastronomiche geograficamente delocalizzate e stagionalmente decontestualizzate. Innanzitutto occorre che si stabilisca uno spartiacque cronologico al di qua e al di là del quale situare i modelli alimentari della regione. Ebbene, seppure in termini non categorici, tale linea di demarcazione va individuata nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale nel quale è venuto inaugurando in tutta l’Italia il ciclo del cosiddetto boom economico.
Anteriormente ad esso ciò che sembra improntare le consuetudini culinarie è soprattutto l’angustia dei regimi alimentari comuni alla maggior parte della popolazione. In proposito, del tutto appropriata può risultare la lettura integrale di una pagina di Gabriella Ciampi (1998, p. 51) tratta dal volume L’alimentazione, che l’editore Einaudi ha voluto includere nei celebri “Annali” della Storia d’Italia:
Il vitto dell'agricoltore del monte risultava in generale
scarso e poco nutritivo; rara è per loro la varietà del cibo, e si riscontra soltanto in qualche famiglia alquanto più agiata (...) Il vitto ordinario è quasi unicamente basato sul granturco. Questo cereale, ridotto in farina, viene impastato con acqua e sotto forma di schiacciata, detta pizza, è cotto nel forno per fare il pane e servito in tutti ì pasti quotidiani. Altra farina di granturco è cotta nell'acqua, rare volte condita con sale ed olio, lardo, ricotta o verdura, e forma la polenta, la quale rappresenta la minestra giornaliera del coltivatore.
In alternativa era usata la minestra di legumi, fagioli, fave, ceci, mochi ed a proposito del moco la commissione rilevava che esso, assieme alla cicerchia, «rappresenta l'ultima qualità di alimentazione, essendo riconosciuti come nocivi alla salute appena se ne faccia un uso abituale». Scarso l'uso di salumi, baccalà e merluzzo e pressoché sconosciuta la carne sia di pecora o di capra sia di suino, come pure era assente l'uso del vino fra i montanari.
Comunque sia - concludeva la commissione - l'alimentazione è sempre incompleta, sovente costituita da cibi malsani. Il grano e il granturco sono ordinariamente avariati, i legumi cattivi, il formaggio magro; e così via discorrendo. I coltivatori poveri, generalmente, dei pochi cereali e civarie che producono, vendono i migliori per raggruzzolare poche lire, e ritengono e spesso comprano per l'alimentazione loro e delle loro famiglie tutto quel che v'ha di peggio. Questo è il regime generale delle famiglie; anche più triste è quello dei braccianti.
Profondamente diversa risultava l'alimentazione in alcune zone della collina: il maggior benessere legato al sistema agricolo, il clima, la migliore qualità del terreno, davano luogo a un uso più articolato dei prodotti: niente granturco, ma frumento e poi «patate, legumi, erbaggi, sale ed al tri condimenti, come olio, lardo, sugna o strutto di maiale (...) carne bovina e suina fresca e salata (...) polli e uova, latte, latticini, formaggio, salumi, vino, mezzo vino o vinello». A questo modello ottimale, peraltro non diffuso su tutto il territorio collinare, ove pure non mancavano prassi alimentari scarse e malsane, si contrapponeva l'alimentazione in uso nel piano: qui il «vitto ordinario si basa sul granturco ridotto in pane ed in polenta», cui si aggiungevano tutt'al più «gli erbaggi».
A questa precarietà esistenziale e alla ristrettezza dei regimi dietetici denunciati a suo tempo dalle parole del marchese Francesco Nobili-Vitelleschi (1883, pp. 788-793), nel Lazio agro-pastorale ha fatto tuttavia da contraltare un apprezzabile ventaglio di ricettari strutturatisi in seno alle sue differenti porzioni di territorio. Un ventaglio che ci permette di discernere molteplici cucine locali considerabili come connotative di altrettanti “dialetti gastronomici”. Simili dialetti gastronomici espressione della cultura marinaresca, contadina, pastorale, boscaiola, valliva, montanara, lacustre, ma anche (come sopra ricordato) sabina, viterbese, castellana, romanesca, si sono ovunque caratterizzati per una fondamentale semplicità di risorse unita ad una altrettanta semplicità di procedure preparative.
Si pensi, tanto per citare degli esempi, alla cucina romanesca del quinto quarto, basata su quanto di commestibile resta della bestia macellata dopo l’asportazione delle parti più pregiate e dalla quale sono scaturiti piatti come la coda alla vaccinara, la coratella, la trippa in umido o i rigatoni con la pajata. Si pensi alle sagne di farro con l’aglione, che in territorio di Orvinio venivano approntate a mano con cereale locale e condite con una salsa cruda a base di aglio, olio, sale e peperoncino. Si pensi alla zuppa di ceci, baccalà e nghiacceteglie, che i contadini della zona di Cori e Priverno preparavano con l’impiego di un cavolo bluastro un tempo coltivato esclusivamente in quest’area del Lazio meridionale. Si pensi inoltre a quei particolari involtini di carne noti con il nome vernacolare di abbuoti, che in gran parte della Ciociaria si confezionavano con interiora di agnello, odori (cipolla, prezzemolo) e formaggio pecorino tenuti assieme dalle budelline dello stesso animale.
Ebbene, per molte di queste specialità, tiene a rimarcare Corrado Barberis, la tipicità non sempre e non necessariamente è da riferirsi (2004, p. 61)
all’impiego di quei prodotti che noi oggi definiamo “tipici”, in quanto l’uso più diffuso che si riscontra è semplicemente quello di prodotti del territorio di cui non può essere decretata una tipicità poiché genericamente comuni. Ad esempio, il polentone con la ventresca si avvale di due ingredienti - la farina di mais e la ventresca - la cui tipicità non è riferita solamente alla zona del piccolo comune di Orvinio, bensì riguarda tutto il territorio nazionale. Un discorso analogo interessa l’acquacotta della Maremma laziale, simile a quella in uso in Toscana e con numerose e piccole varianti, legate al tipo di erbe usate per prepararla.
Per altre ricette, prosegue il sociologo, il marchio di tipicità è invece da ritenersi pienamente giustificato dall’impiego di prodotti esclusivi di una zona geografica ed estranei ad altre: come è il caso della zuppa che nell’Alta Valle dell’Aniene viene preparata con il “fagiolo cioncone”; o della bazzoffia chenell’Agro Pontino viene cucinata con carciofi e lattuga esclusivi di questa specifica area del Lazio. Il più delle volte, tuttavia, la tipicità è da ritenersi come un mero “valore aggiunto” che le politiche di marketing attribuiscono a taluni piatti, o a taluni alimenti, con il solo scopo di favorire la promozione pubblicitaria di un territorio o di un marchio alimentare . Un valore aggiunto che, tra l’altro, non non sempre e non necessariamente può trovare un riscontro positivo nelle esperienze gustative dei palati cittadini. Considera al riguardo Michela Zucca (2007, pp. 228-229):
Pensiamoci bene: in realtà, che cosa si cerca quando si compra un prodotto “tipico”? Per che cosa si è disposti a pagare di più? La questione del gusto, nella maggior parte dei casi, scade in secondo piano. Perché un alimento prodotto secondo le regole tradizionali, normalmente non piace al consumatore che abita in un contesto metropolitano e oramai da tempo ha perso ogni contatto col territorio. Perché, di solito, il cibo che veniva (e in molti casi ancora viene) consumato “in campagna” è troppo saporito; i suoi colori e i suoi sapori sono troppo forti; è troppo ricco di grassi e di sali. Un salame fatto in casa senza l’uso di conservanti e stagionato il tempo debito in una cantina umida, si riempie di muffa, diventa marrone e spesso non riesce ad essere neppure annusato da chi non è abituato; molti cittadini devono, letteralmente, imparare a digerirlo, e ci mettono mesi, settimane in cui devono imporsi di superare il disgusto. Poi non riescono più a mangiare il “negronetto del supermercato”, senza sapore e senza profumo: ma prima devono sforzarsi. La stessa cosa avviene col pollo ruspante: chi è abituato ai gallinacei frolli da togliere dal cellophane e infornare (in mezz’ora si mangia!), pronti in due mesi a furia di ormoni e senza muscoli perché passano la loro breve e sfortunata vita senza razzolare mai, è infastidito dal fatto che quelli nostrani devono cuocere per minimo due ore prima di essere commestibili, la loro carne non è bianca e comunque rimane dura e stopposa e si fa fatica a masticare. Stessa cosa con l’insalata dell’orto, o peggio con gli spinaci, che, a differenza della verdura cresciuta nelle colture idroponiche (che non ha mai visto né terra né letame) deve essere accuratamente pulita, anche perché si corre il rischio di trovarci dentro terra e lumache, che quando finiscono nel piatto fanno veramente schifo, perché si vedono bene, non come i residui di concimi chimici antiparassitari anticrittogamici demuffenti che sono invisibili e che fanno “solo” venire il cancro.
Modelli dietetico-alimentari a confronto tra esperienza del presente ed idealizzazione del passato
Assai spesso, nelle pubblicazioni di gastronomia redatte ad uso localistico-promozionale viene riferito che “un tempo” nel Lazio si mangiava in maniera del tutto diversa (sottintendendo migliore) rispetto ad oggi. In proposito, viene enfatizzato come la cucina tradizionale fosse di gran lunga più genuina, più naturale e più gustosa di quella che si prepara nelle case e nei ristoranti del nostro tempo. Ma le cose stanno davvero nei termini riportati? Gli alimenti di cui una volta si faceva uso nel viterbese, nel reatino, nel frusinate, nelle zone dell’Agro Romano e Pontino erano veramente più sani e più autentici di quelli che caratterizzano le abitudini gastronomiche quotidiane?
In effetti, nell’ultimo mezzo secolo, molto è cambiato nel modo di nutrirsi della popolazione: sono cambiati gli ingredienti-base, sono cambiati i procedimenti di preparazione (le ricette), sono cambiati i tempi e i modi del mangiare, sono cambiati perfino i valori e i significati attribuiti ai cibi e alle bevande. Tuttavia ciò non vuol dire che oggi nel Lazio si mangi in maniera meno equilibrata (sottintendendo peggiore) di quanto non si facesse in passato. Anzi, sotto certi aspetti, si può ritenere che gli stili alimentari siano notevolmente migliorati rispetto a 50 o 60 anni fa, quando le tavole di casa erano carenti di molti importanti prodotti necessari ad un corretto sviluppo fisico dell’organismo. Certo, oggigiorno l’eccessivo uso di zuccheri, di grassi animali e vegetali, di additivi artificiali per favorire la conservazione o la qualità estetica dei cibi espone chiunque al rischio di contrarre pericolose malattie quali l’obesità, il diabete, l’ipertensione, o alcune forme di tumore che colpiscono soprattutto l’apparato gastro-intestinale. In passato, però, il benessere fisico della persona non si può dire che fosse maggiormente garantito da come che si mangiava. Ed infatti, malattie come lo scorbuto, il rachitismo, il gozzo, la pellagra, il cretinismo, la diarrea cronica causavano problemi non meno gravi per la salute di quanti non ne procurino al presente panatine, hot dog o big mac consumati in eccesso in ogni momento della giornata. Questo perché, sebbene è vero che la maggior parte della popolazione mangiasse in maniera meno elaborata, di fatto si alimentava in modo non sempre completo dal punto di vista nutrizionale. Basti pensare, tanto per fare dei comuni esempi, che il pane fresco di giornata che oggi si compra nella sua varietà bianca e raffinata una volta costituiva un lusso riservato esclusivamente ai cittadini o ai membri delle classi più agiate. Nei paesi, nelle zone di campagna e soprattutto nelle aree di montagna si faceva invece uso di pane grezzo fatto con miglio, segale, veccia e perfino ghiande; un pane nero e pesante che saziava senza nutrire e che veniva preparato una volta a settimana nei forni pubblici che ogni paese o quartiere cittadino metteva a disposizione dei suoi abitanti.
Basti pensare che il pesce fresco, ad eccezione delle persone più ricche o di quelle che abitavano in prossimità del mare e dei laghi, quasi mai veniva consumato nelle tavole degli operai, dei contadini e dei pastori. Questi tutt’al più potevano permettersi qualche sarago essiccato o qualche piccolo pezzo di baccalà conservato sotto sale.
Basti pensare che l’olio di oliva, formidabile riserva di elementi primari dal punto di vista dietetico, solo raramente faceva la sua comparsa nei pasti quotidiani come condimento delicato di pietanze o contorni; al suo posto, dominavano incontrastati strutto, sugna e lardo di maiale i quali, benchè gustosi e saporiti al palato, costituivano un vero attentato per il cuore e le arterie.
Basti pensare che i piatti a base di carne si consumavano solo nelle ricorrenze più importanti come la Pasqua, il Natale, il carnevale, le feste patronali, o in occasione dell’uccisione del maiale. Inoltre, nelle rare volte in cui venivano serviti, consistevano quasi sempre in porzioni scadenti dell’animale macellato quali trippa, coratella, nervetti, cervello, zampe o coda; mentre fettine, polpe e bistecche erano di norma destinate alle tavole dei pochi fortunati che potevano permettersele.
Ma in passato, a rendere ancora più squilibrato e insalubre il modo di alimentarsi di gran parte della popolazione, hanno contribuito anche due altre circostanze di rilievo tuttora vive nella memoria delle generazioni più anziane: la scarsità cronica del cibo e la monotonia ricorrente dei menù culinari. Ciò vuol dire che, fino alla metà circa dello scorso secolo, non soltanto nel Lazio si mangiava male e poco, ma si mangiavano anche e sempre le stesse cose. E, sebbene delle varianti potevano riscontrarsi tra zone pianeggianti e montuose, tra contadini e pastori, tra cittadini e borghigiani, tra estate e inverno, tra tempo feriale e periodo festivo le abitudini alimentari erano quasi ovunque le stesse. In particolare, il modello gastronomico più diffuso era quello che prevedeva due pasti principali al giorno, mattina e sera, realizzati con l’uso di farina di granturco, patate, verdure di campo e molte varietà di legumi: fagioli, lenticchie nonché ceci e cicerchie. Questi ingredenti-base, che raramente includevano carne, latticini, uova o insaccati, venivano ogni giorno lavorati dalle massaie per ottenere polente, minestre, focacce e zuppe variamente aromatizzate con odori di ogni tipo per sopperire alla scarsità di olio, sale e condimenti di altro genere. I piatti, poi, mai colmi e mai sufficienti a saziare la fame, venivano da tutti consumati in famiglia stando seduti attorno ad una tavola e badando accuratamente che nulla andasse perso o sprecato.
Questa situazione di precarietà alimentare, come si è evidenziato nel precedente paragrafo, si è prolungata fino agli anni ’50 del Novecento. A partire da tale periodo cronologico, infatti, tutta una serie di cambiamenti profondi che hanno riguardato l’economia nazionale hanno reso possibile il passaggio della società italiana, e laziale, da un modello di tipo agro-pastorale arcaico ad uno di tipo moderno ed industriale. Ciò ha significato maggiore ricchezza per le famiglie, maggiore utilizzabilità di denaro e, di conseguenza, maggiore disponibilità di beni: compresi quelli relativi alla sfera del cibo e dei generi alimentari. Simile disponibilità, dovuta anche allo sviluppo dei sistemi di trasporto e all’introduzione di frigoriferi e congelatori, ha fatto sì che non solo in ogni luogo del Lazio si potessero avere generi alimentari prodotti in altre zone della regione o al di fuori di essa (si pensi agli hamburger, al Kebab, al sushi), ma ha fatto anche sì che ogni persona potesse permettersi il lusso di mangiare carne, pasta e pesce a volontà, fino ad oltrepassare la soglia del fabbisogno. Si è così giunti da una parte a contrapporre il malnutrimento con l’iperalimentazione, l’inedia con l’obesità, la gastronomia locale con il cibo globale; dall’altra, invece, a guardare con ricordo sempre più nostalgico e malinconico a quegli abbuoti, a quelle pajate, a quelle acquecotte e a quegli stringozzi che, malgrado la televisione voglia farci credere il contrario, i palati dei nostri nonni hanno più desiderato che realmente assaporato.
Il revival del cibo locale come “fabbrica del territorio”
Nel Lazio, gastronomie e ricette “tipiche” come quelle appena richiamate, e come moltissime altre che qui non è possibile elencare, si trovano attualmente al centro di un rinnovato interesse collettivo dopo aver conosciuto per diversi decenni un inesorabile processo di rimozione culturale. Un processo che ha avuto inizio al di qua di quello spartiacque cronologico sopra ricordato (boom economico) e che è stato internamente segnato dallo spopolamento del mondo rurale e montano, dall’inurbamento massiccio nelle grandi città industriali, dalla diffusione di strumenti di conservazione alimentare in grado di assicurare la disponibilità delle derrate al di là dei periodi e delle aree di produzione, dall’accesso massiccio delle donne nel mondo lavorativo e dal conseguente cambiamento delle modalità di preparazione/consumo dei cibi.
Il concorrere di siffatti fattori (Di Renzo, 2006, p. 56)
se in una prospettiva più generale ha innescato l’irreversibile declino della cultura contadino-pastorale tutta improntata all’insegna della precarietà esistenziale e della limitatezza delle risorse, nell’ottica delle pratiche alimentari ha comportato una ragguardevole trasformazione delle specificità gastronomiche tradizionali e un brusco arresto nella trasmissione dei saperi culinari popolari. Un arresto cui ha fatto da corollario non solo la perdita di consuetudini secolari scaturite attorno al cibo (uso di materie prime, modalità di preparazione, tempi e luoghi di consumo) ma anche l’affermarsi di una differente propensione dei gusti. Questi hanno progressivamente conosciuto un processo di omologazione che ha ristretto sempre più lo spazio dei sapori e degli standard alimentari locali, considerati sinonimo di un mondo percepito come “inattuale” e dal quale si avvertiva la necessità di prendere la maggior distanza possibile per ciò che rappresentava (miseria, sottosviluppo, arcaismo), o che dimostrava di non saper garantire (abbondanza, benessere, modernità).
Quindi, come spesso accade quando i processi acculturativi si fanno troppo spinti ed unidirezionali, il bisogno di non perdere “se stessi” (o di ritornare ad esserlo), ha attivato negli ultimi decenni un crescente movimento contrappositivo teso ad invertire la dinamica dei fenomeni omologativi in direzione di un recupero culturale capace di restituire un senso di identità forte da mettere in gioco nella dialettica globale-locale. Simile operazione di recupero, se in termini generali si è venuta concretizzando nel promuovere fenomeni di risveglio folklorico e di “invenzione” della tradizione (Clemente, Mugnaini, 2002) in termini più consoni ad un discorso alimentare ha dato luogo a forme di revivalismo gastronomico volto a riscattare gusti, sapori e consuetudini del mangiare “come quelle di una volta”: si pensi al diffuso fenomeno delle botteghe del gusto, degli agriturismo, delle sagre gastronomiche o dei pranzi romani, medievali, rinascimentali.
E così nel, nel Lazio come nel resto dell’Occidente post-moderno, “genuino”, “tipico”, “casereccio”, “autentico”, “fresco”, “naturale” stanno assumendo sempre più la dimensione qualificativa di un modo di mangiare coerente con le istanze della tradizionalità e dell’equilibrio tra uomo, salute e ambiente. Ora, se questa affermazione da una parte corrisponde a verità (una zuppa di farro è pur sempre da ritenersi un alimento filologicamente-dieteticamente-ecologicamente preferibile ad un “doppio cheeseburger”), dall’altra rischia di indurre molti a cadere nell’equivoco, o nell’(auto)inganno, che mangiando cibi e piatti locali si possano far rivivere sapori “autentici” di cui si avverte l’infelice mancanza. Nulla di più fuorviante.
A ricordarcelo è lo stesso Vito Teti (Ibidem, p. 110), uno tra i maggiori esperti italiani di antropologia dell’alimentazione:
un piatto tradizionale, collocato all'interno di un "insieme alimentare" non accessibile in passato, assume oggi un diverso valore dietetico, simbolico, rituale. È come se un'antica parola e un'espressione dialettale venissero inserite e adoperate all'interno di un'altra lingua. Non è sufficiente citare i proverbi per far rivivere le culture tradizionali; né è sufficiente proporre desuete ricette per resuscitare il senso e il gusto della cucina del passato.
Non basta dunque consumare i “frascarelli”, le “fregnacce” o il “pangiallo”, magari in una fraschetta di Ariccia, in una hostaria di Sutri o in una taberna lungo l’Appia per poter sostenere di aver mangiato l’”autentico” come «solo un tempo si faceva». Né basta riesumare vecchi tegamini o polverose giare seppellite in soffitta per illudersi di poter condividere le “schiette” esperienze gustative dei nostri nonni. Ciò in quanto, insiste Teti (Ibidem, p. 110), esiste una notevole differenza «tra [il mangiare] le "erbe", magari scondite, come piatto unico di un'intera giornata e [il mangiare] le "erbe" come contorno all'interno di un ricco ed elaborato pasto». Così come esiste una altrettanto significativa differenza tra il
mangiare qualche volta i salami, cibi di lusso e delle grandi occasioni, e l’averli sempre a disposizione all'interno di un regime alimentare in cui domina contemporaneamente anche la pasta, la carne, il pesce, il pane bianco, i dolci, la frutta e vino a volontà.
Una ricetta o un cibo della tradizione gastronomica agro-pastorale possono anche essere mantenuti in uso, o fatti rivivere: il mondo intero che li ha partoriti certamente no.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
AA.VV., Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, IX. Relazione del commissario Marchese Francesco Nobili-Vitelleschi sulla quinta circoscrizione,1883
J. Andre, L’Alimentation et la cuisine a Rome. Ouvrage publiè avec le concours du Centre National de la Recherche Scìentìflque. Paris, Klincksieck, 1961.
B. Antomarini, M. Biscuso (a cura ), Del gusto e della fame: teorie dell'alimentazione, Roma, Manifestolibri, 2004
C. Barberis (a cura), “Identità e tradizione gastronomica del Lazio”, in Quaderni di Informazione Socioeconomica, n. 10, 2004
A. Boni, La cucina romana: contributo allo studio e alla documentazione del folklore romano. Roma, Edìz. della Rivista Preziosa, 1930
P.Cadonici, Cibo, costume e dintorni: riflessioni sui gusti alimentari e disgusti comportamentali dei nostri giorni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.
P. Camporesi, Alimentazione folclore societa, Parma, Pratiche, 1980.
A. Capatti, M. Montanari, La cucina italiana. Storia di una cultura, Roma-Bari, Laterza, 1999.
A. Carbone, G. Dono, M. Gioia, “Indagine sui prodotti agricoli tipici della Regione Lazio”, in Quaderni di Informazione Socioeconomica, n.3., 2000.
G. Ciampi, “L’alimentazione popolare a Roma e nell’Agro Romano”, in Storia d’Italia. L’alimentazione, Annali 13, Torino, Einaudi, 1998.
P. Clemente, F. Mugnaini (a cura), Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci, 2001.
M. Cresta, L' uomo, il cibo e il territorio: elementi di ecologia e geografia dell'alimentazione, Vibo Valentia, Monteleone, 1995.
F. Dei, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002.
E. Di Renzo, “Il dialetto a tavola”, in La nuova ecologia, maggio, anno XXVI, n. 5., 2006
E. Di Renzo (a cura), Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, Atti del X Congresso AISEA, www.aisea.it., 2006
E. Di Renzo, “Effetto sagra. Recupero di gastronomie e sapori”, in AA.VV., Storia del Lazio rurale. Il Novecento, Roma, Arsial, pp. 306-321, 2005a.
E. Di Renzo, La cultura dell’olio nel territorio della Sabina, (DVD, colore, 18‘)Regione Lazio - Assessorato al Turismo, 2005b.
E. Di Renzo (a cura), Strategie del cibo. Simboli, pratiche, valori, Roma, Bulzoni, 2005c.
E. Di Renzo, A.Manodori Sagredo, Convivio. Luoghi, riti e radici dei prodotti agroalimentari della Provincia di Roma, Catalogo dell’omonima mostra fotografica, Roma, Società Geografica Italiana, 2005
J. L. Flandrin, Il gusto e la necessità, Milano, Il Saggiatore, 1994
J. L. Flandrin, M. Montanari, Storia dell'alimentazione, Bari, Laterza, 1997
M. Harris, Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, Torino, Einaudi, 1990.
C. Hausmann, “Roma, romano, romanesco: il paniere agroalimentare di Roma tra tradizione e innovazione”, in F. Salvatori, E. Di Renzo (a cura), Roma e la sua campagna. Itinerari del XX secolo, Roma, Società Geografica Italiana, 2007
L. Jannattoni, La cucina romana e del Lazio, Roma, Newton Compton, 1998.
L. Jannattoni, I1 ghiottone romano. Il breviario del laico a tavola sulle rive del Tevere. Milano, Bramante, 1965
P.G.Landini, “Geografia della regione”, in Guida d’Italia. Lazio, Milano, TCI, 1981.
G. Malizia, La cucina ebraico-romanesca in oltre cento ricette tradizionali. Roma, Newton Compton, 1995
A. Marescalchi, Storia dell'alimentazione e dei piaceri della tavola, Milano, Garzanti, 1942
M. Montanari, La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa, Roma-Bari, Laterza, 1997.
L. Moulin, L' Europa a tavola: introduzione a una psicosociologia delle abitudini alimentari, Milano, Mondadori, 1993
V. Ragusa, La vera cucina casereccia a Roma e nel Lazio. Roma, I.E.D.E.P., 1978
L. Rappoport , Come mangiamo: appetito, cultura e psicologia del cibo, Milano, Ponte alle Grazie, 2003.
G. Rebora, La civilta della forchetta: storie di cibi e di cucina, Roma-Bari, Laterza, 1998.
N. Russo, L’ambiente rurale laziale, Roma, Grafica Rispoli Editrice, 2000
F. Salvatori, E. Di Renzo (a cura), Roma e la sua campagna. Itinerari del XX secolo, Roma, Società Geografica Italiana, 2007
A. Segre, A.Grossi, Dalla fame alla sazieta, Palermo, Sellerio, 2007.
M. Sentieri, Cibo e Ambrosia. Storia dell’alimentazione mediterranea tra caso, necessità e cultura, Bari, Dedalo, 1993
P. Sorcinelli, Gli italiani e il cibo. Appetiti, digiuni e rinunce dalla realtà contadina alla società del benessere, Bologna, Clueb, 1995.
V. Teti, Il colore del cibo, Roma, Meltemi, 1999.
O. Zanini De Vita, Il cibo e il suo mondo nella campagna romana, Roma, Alexandra Editrice, 2002
M. Zucca, “L’illusione dell’autenticità: cibi tipici e piccoli paesi alpini”, in E. Di Renzo (a cura), Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, Atti del X Congresso AISEA, www.aisea.it, 2006
Effetto Sagra:
gastronomie di piazza nel Lazio rurale contemporaneo.
Premessa
Al viaggiatore che, in un qualunque fine-settimana estivo, si trovasse a transitare nelle piazze principali di Orvinio, Picinisco, Rocca di Papa, Vallerano, Campodimele o di una qualsiasi altra località del Lazio rurale, si prospetterebbe allo sguardo una realtà dai contorni così identificati: strade interdette al traffico in prossimità di aree rese temporaneamente pedonali; autovetture in sosta continuata lungo i percorsi di accesso ai centri storici; atmosfera di festa e di effervescenza collettiva vivacizzata da musiche di accento popolare; piazze e corsi gremiti da animate tavolate indugianti nel consumo di castagne, o polenta, o zuppe, o cocomero, o vino; padiglioni fugacemente allestiti dove solerti abitanti del luogo, divenuti per l’occasione cuochi, camerieri, vivandieri, dispensano senza sosta cibi e bevande a comitive di forestieri in procinto del proprio turno di degustazione. Tutto questo, ed altro ancora, sono le sagre gastronomiche, i rinomati appuntamenti culinari dei weekend fuori-porta che spingono stuoli di gitanti a calcare le strade dei borghi di provincia con lo scopo di assaporare piatti e ricette di dichiarata tradizione locale.
Eredi probabilmente delle antiche cerimonie con le quali in passato si usava accompagnare la consacrazione di edifici di culto mediante fiere, mercati e consumo collettivo di cibo, le sagre rappresentano oggi uno degli eventi ludico-popolari di maggiore consenso partecipazionistico cui aderiscono numerosi abitudinari della cosiddetta vacanza “mordi e fuggi”. Rappresentano, inoltre, una delle modalità più ricorrenti con cui la società urbana si rapporta al mondo delle tradizioni folcloriche, fruendone quella che ritiene essere la sua componente culturale più autentica e rappresentativa.
Le presenti riflessioni, nel quadro di una prospettiva di ricerca di impostazione socio-
antropologica, si propongono di porre in luce alcuni elementi di conoscenza volti a restituire spazi di significatività all’odierno fenomeno delle sagre laziali, cogliendone le eventuali relazioni che intercorrono con il tempo calendariale, l’ambiente, le società e le economie locali al cui interno risultano funzionalmente collegate. Nello stesso tempo, si prefigge di far trapelare la contestualizzazione rurale e periferica del loro svolgimento, esplicitandone la fondamentale assenza dagli schemi comportamentali in uso negli ambienti cittadini. Ciò non di meno, posta l’entità della domanda turistica che sono in grado di attivare, si prefiggono di mettere in risalto il modo in cui le sagre giochino un ruolo determinante nella promozione e nella valorizzazione delle aree più marginali della regione, facendo spesso da volano ad economie devitalizzate dall’accentramento produttivo circoscritto a ben limitati distretti del territorio laziale.
Tutto ciò tenendo debitamente conto delle implicazioni che questi eventi esprimono al cospetto dei recenti dibattiti scientifici scaturiti attorno ai temi del folclore, del suo senso attuale e delle sue possibili strumentalizzazioni commerciali messe in atto dai modelli di cultura dominante. Modelli che, nell’esaltazione mass-mediatica dei valori tradizionalistici, e nella riproposizione di abusati clichè romantico-ottocenteschi, conducono spesso ad una distorsione prospettica del mondo rurale/contadino: esaltandone i soli aspetti ludico-esteriori e celandone le numerose problematicità sociali ed economiche.
Breve profilo socio-antropologico delle sagre
Nel Lazio, così come nell’intera geografia regionale italiana, le sagre gastronomiche costituiscono un fenomeno collettivo di recente affermazione. Un fenomeno complesso e sotto molti punti di vista controverso che, non potendosi sbrigativamente riguardare come un succedaneo della festa “paesana” consueta, occupa un ruolo di primissimo piano nelle moderne pratiche di fruizione dell’universo folclorico. Sebbene alcune vantino uno spessore storico dotato di una certa significatività, la quasi totalità di esse colloca la propria nascita in epoche cronologiche del tutto recenti. Al loro fortunato radicamento, inziato a partire dagli anni ‘70 dello scorso secolo e proseguito con ritmi esponenziali nei decenni successivi, ha contribuito una molteplicità di fattori tra cui spiccano con evidenza:
- il superamento di una economia agraria di sussistenza volta essenzialmente all’autoproduzione e all’autoconsumo familiare;
- la derivata maggiore disponibilità di risorse alimentari da destinare alla redistribuzione collettiva e alla vendita;
- la più ampia flessibilità lavorativa che si accompagna alla possibilità di usufruire di maggiore tempo libero da destinare al divertimento e allo svago;
- la generalizzata e diffusa disponibilità di mezzi di spostamento ad uso privato e personale;
- la più rilevante utilizzabilità di denaro da assegnare allo svolgimento di bisogni di non primaria necessità;
- il rinnovato interesse, iniziato a partire dalla fine degli anni ‘60 anni, verso il mondo del passato e il conseguente affermarsi di revivalismi culturali tendenti a contrastare l’egemonia dei modelli sociali urbanocentrici;
- la conseguente esaltazione dei localismi identitari a scapito dei globalismi alienanti e deculturativi; una esaltazione che, tradotta nei termini del discorso alimentare, ha prodotto una rivalutazione (mass-mediatica) delle gastronomie tradizionali ed etnico-regionali a scapito di quelle seriali, industriali, macdonaldizzate.
Alla luce di tali presupposti, le sagre si configurano come realtà ibride e multiformi situate a cavallo tra l’istituto della festa popolare tradizionale (in specie le ricorrenze patronali) e il fenomeno della mini-imprenditorialità a carattere “dilettantesco” e - in prevalenza - non lucrativo. Realtà che, nella riproposizione di scenari e atmosfere tipiche della “civiltà” contadina, perseguono essenzialmente (ma non solo) l’accaparramento dei flussi turistico-vacanzieri specie di provenienza extraterritoriale ed urbana. Obiettivo, questo, il cui raggiungimento viene spesso ricercato mediante un business che non sempre tiene conto della coerenza con le tradizioni gastronomiche autoctone: come dimostrano le diffuse sagre della birra, le generiche sagre della bruschetta o le numerose degustazioni di prodotti agroalimentari “fuori-stagione” e “fuori-territorio” che attualmente vengono allestite in differenti luoghi della regione.
Sagre e territorio a confronto: alcuni prospetti statistico-fisionomici.
La casistica delle sagre laziali prospetta un ampio ventaglio di offerta alimentare che riflette solo in parte le diversità produttive degli ambienti fisici e le tradizioni gastronomiche del passato storico. Quest’ultimo, contrassegnato da una fondamentale semplicità di risorse e da un’altrettanta semplicità di ricette adottate nel prepararle, si rivela segnato da una profonda “crisi della memoria” cronologicamente situabile a cavallo tra gli anni ’60-’70 dello scorso secolo:
da quel momento, infatti, i piatti che, per lunghissimo tempo, avevano costituito l’alimentazione base di gran parte della popolazione, scompaiono progressivamente dalla cucina quotidiana, fino ad essere, nella maggior parte dei casi, relegati ad ambiti o ricorrenze particolari […] all’interno di cui confluisca ancora questa cucina, che viene sentita come retaggio e patrimonio del passato , della quale si conserva il ricordo ma che già da tempo ha smesso di far parte dell’alimentazione quotidiana. Non va inoltre sottovalutato il fatto che, a partire appunto dagli anni ’60, il numero delle donne lavoratrici sia progressivamente aumentato, fino a costituire un importante cambiamento nelle abitudini familiari e nell’organizzazione della società
A determinare siffatta crisi della memoria collettiva, che secondo Corrado Barberis «non fu soltanto un cambiamento di mestiere ma un ripudio complessivo del passato», hanno agito fattori concomitanti quali:
l’abbandono di massa delle campagne e dei piccoli centri da parte delle nuove generazioni a vantaggio delle grandi città, dove le tradizioni tendono a scomparire più rapidamente, o lo sviluppo e la diffusione dei cibi surgelati, che hanno fortemente modificato le abitudini alimentari, e garantito la disponibilità dei prodotti indipendentemente dalle stagioni e dai territori di produzione.
E sebbene diverse sagre cerchino oggi di contrapporre un deciso argine ai fenomeni di deculturazione alimentare, l’avvenuta modificazione delle abitudini nutrizionali, l’incidenza pervasiva dell’impresa turistica e la globalizzazione dei gusti e dei consumi sembra trovare in molte di esse dei riflessi del tutto significativi.
Nel Lazio, le sagre gastronomiche corrispondono ad una tipologia di eventi difficilmente inventariabili nell’ambito di una classificazione unitaria. Ciò dipende dal fatto che, aldilà di una fisionomia comune che le identifica, costituiscono una realtà caleidoscopica dai tratti dinamici ed eterogenei. Così, mentre alcune chiamano in causa un coordinamento di tipo amministrativo-locale, altre manifestano contrassegni spontanei e popolari. Mentre alcune esigono significativi investimenti economico-finanziari e complessi apparati logistici che ne supportino l’allestimento, altre implicano impianti organizzativi di semplice attuazione alla cui cura attendono comitati appositi di cittadini volenterosi. Mentre alcune trovano svolgimento nel corso delle tradizionali feste patronali, arricchendone il cartellone delle manifestazioni ludico-evasive, altre (la maggioranza) costituiscono eventi “laici” dal carattere concorrenziale-sostitutivo delle feste stesse. Mentre alcune rinviano ad una origine più che decennale altre manifestano una genesi del tutto recente. Mentre alcune perseguono la promozione di un prodotto alimentare o di una ricetta culinaria di carattere tipicamente locale, altre si limitano a proporre l’offerta commerciale di generi gastronomici di più ampio consumo. Inoltre, mentre alcune esprimono un evidente segno di continuità temporale e di fissità calendariale, altre vengono allestite in maniera saltuaria e non necessariamente cadenzata.
Pressochè tutte, invece, aldilà delle singole variabili rilevate, sono accomunate dalla regola di far corrispondere all’offerta di cibo il pagamento di una somma più o meno consistente di denaro da destinarsi ad impieghi di carattere diversificato. Impieghi che possono riguardare sia l’autofinanziamento delle attività statutarie delle associazioni che le allestiscono, sia la realizzazione di opere di pubblica utilità (rifacimento dell’arredo urbano, allestimento di parchi-gioco per bambini, restauro di chiese e palazzi) sia la partecipazione a campagne di raccolta fondi per attività sociali e umanitarie.
Complessivamente nello spazio dell’intera regione risultano in esercizio ben 650 sagre, corrispondenti ad una media di 1,6 eventi per ogni comune. È evidente che si tratta di un valore numerico del tutto teorico che non tiene conto delle differenti situazioni attestate sul territorio; il riscontro operato sul terreno, infatti, ha permesso di documentare casi differenziati di località che organizzano fino cinque o più sagre l’anno e altri che ne organizzano una sola o nessuna.
In generale, l’offerta gastronomica vede il primato assoluto delle castagne: delle 650 sagre segnalate, infatti, ben 41 sono riservate al consumo di questo diffuso frutto autunnale. La ragione di un così elevato valore è da rapportarsi all’ampia estensione boschiva (il coefficiente di boscosità è pari al 27% della superficie totale) che ricopre una parte significativa del territorio collinare e di media-montagna della regione, specie quello situato in corrispondenza dei Monti Cimini, degli Affilani, del Cicolano, della zona tra S. Vito Romano e Bellegra e dei Castelli Romani. Lo scorporamento dei dati permette di assegnare 21 sagre alla provincia di Roma, 9 a quella di Rieti, 5 a quella di Viterbo, 4 a quella di Frosinone e 3 a quella di Latina. Permette inoltre di attribuire lo svolgimento di 21 eventi nel mese di ottobre, 18 in novembre, 2 in dicembre e 1 in gennaio.
All’offerta di castagne fa immediatamente seguito quella della polenta, con 32 casi complessivi rilevati. Si tratta di un piatto tipico soprattutto del periodo ottobre-marzo, con punte massime nei mesi di dicembre e di gennaio (sebbene non manchino due casi in agosto). Condita con aggiunta di ragù di pecora, funghi porcini, spuntature di maiale e salsicce, la polenta è presente in 13 sagre nella provincia di Frosinone, 11 in quella di Roma, 6 in quella di Rieti e 1 in quelle di Latina e di Viterbo.
Alla polenta, fanno immediatamente seguito le bruschette, di cui sono state evidenziate nel totale 31 sagre. Questo alimento a base di pane abbrustolito, olio e aglio strofinato, viene proposto sia nella sua forma più semplice, sia insaporito con tartufo, pomodorini, verdure, legumi e altri generi di condimenti che tuttavia si discostano da una originaria tradizione contadina. Di sagre della bruschetta se ne contano 13 nella provincia di Roma, 7 in quella di Rieti, 5 in quella di Frosinone e 3 nelle province di Viterbo e Latina. A ruota seguono tutti gli altri generi alimentari e culinari, disposti in base ad un ordine decrescente (vedi Tab.1) che vede al fondo della graduatoria l’offerta di piatti tradizionali di matrice strettamente locale: gli abbuoti a Viticuso (FR), il ciavarrotto a Formia (LT), l’acquacotta a San Martino al Cimino (VT), i bucatini all’amatriciana ad Amatrice (RI), la sbroscia a Marta (VT), le sagne di farro con l’aglione ad Orvinio (RI), la zuppa di fagiolo cioncone a Vivaro (RM).
Ragionando in termini di ripartizioni amministrative (vedi Tab.2), il 31% delle sagre trovano attuazione nella provincia di Roma, il 26% in quella di Frosinone, il 20% in quella di Rieti, il 13% in quella di Viterbo, mentre solo il 10% vengono allestite nella provincia di Latina. Tale disparità di valori, se da una parte è da porsi in relazione al variabile numero dei centri che ricadono nel territorio di ogni singola provincia, dall’altra è da riferirsi a precise dinamiche di natura geografica e socio-economica.
Se si tiene invece conto della calendarizzazione delle sagre in rapporto al ciclo dell’anno emerge un evidente divario distributivo che gioca a svantaggio soprattutto dei periodi invernali e primaverili (vedi Tab.3). Dall’analisi dei dati acquisiti risulta come il I° trimestre dell’anno prevede lo svolgimento di 69 sagre, con punta massima di 28 nel mese di gennaio; il II° trimestre ne prevede 91, con valore massimo di 40 nel mese di maggio; il III° trimestre ne prevede complessivamente 370, con un vertice di 290 in agosto; il IV° trimestre, infine, implica lo svolgimento di 85 eventi, di cui 64 nel solo mese di ottobre. Dicembre, febbraio, marzo e aprile risultano invece i mesi che fanno registrare il minor numero di eventi: rispettivamente 24, 17, 12 e 21 .
Simile andamento trova giustificazione in livelli di spiegazione che tengono conto delle condizioni climatiche, delle disponibilità stagionali di molti generi agro-alimentari, nonché dell’andamento dei cicli lavorativi (soprattutto urbani).
In particolare, la notevole flessione di sagre riscontrata nel periodo invernale, oltre a giustificarsi con le avversità metereologiche che incidono notevolmente negli spostamenti sul territorio, e oltre a motivarsi (parzialmente) con la scarsità di primizie, si spiega soprattutto nella particolare relazione che tale periodo intrattiene con il calendario festivo liturgico. Trattandosi infatti dei mesi interessati dalle ricorrenze del Natale, del Carnevale, della Pasqua, i tradizionali eccessi alimentari che di norma li caratterizzano fanno sì che si presti un minore interesse verso ulteriori proposte rinvianti al consumo di cibo .
Al contrario, la forte concentrazione di sagre nel periodo estivo, oltre a spiegarsi con ragioni di segno diametralmente opposto alle precedenti, si collega in maniera determinante alla maggiore flessibilità dei ritmi lavorativi e al diffondersi dei fenomeni vacanzieri. Questi agiscono concretamente sia nell’incoraggiare le gite fuori-porta, sia nell’attivare gli spostamenti turistici nelle aree extra-urbane, sia nel favorire il rientro degli immigrati nei propri paesi di origine: elevando esponenzialmente il numero dei residenti che vi alloggiano e stimolando le molteplici cerimonialtà di accoglienza.
Sempre legata alla sfera dei ritmi lavorativi, e alla conseguente maggiore/minore disponibilità di tempo libero, è la regola che “ammassa” lo svolgimento delle sagre negli spazi dei fine-settimana: soprattutto di sabato e di domenica, raramente di venerdì. Si tratta di una prassi che solo in corrispondenza del periodo luglio-agosto sembra conoscere significative attenuazioni, posta l’esigenza degli organizzatori di evitare penalizzanti sovrapposizioni tra eventi analoghi allestiti in paesi geograficamente limitrofi.
Dal passato all’oggi: casi esemplificativi di sagre laziali
La sagre, nella loro accezione di manifestazioni popolari legate al consumo collettivo (e a pagamento) di cibi e bevande, costituiscono dei fenomeni di recente affermazione nel panorama geografico del Lazio rurale e, più in generale di gran parte del territorio nazionale. Fenomeni che, se nella migliore delle ipotesi rinviano le radici al secolo di storia, nella prevalenza dei casi situano le proprie origini negli anni del “miracolo italiano”. Tuttavia, è soprattutto nell’ultimo trentennio che si è assistito ad una loro più incisiva proliferazione sotto la spinta congiunta dei vari impulsi sociali, culturali ed economici riferiti in inizio di esposizione.
Tra le centinaia di eventi gastronomici attualmente presenti nelle piazze delle cinque province, la sagra dell’uva di Marino si segnala certamente come una tra le più longeve e fortemente radicate nell’immaginario collettivo. Frequentata ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutta la regione, e dalle aree immediatamente adiacenti, questa manifestazione situa la sua nascita nell’epoca del Ventennio fascista e rivela una strettissima aderenza con gli assetti economico-produttivi del territorio, vocazionalmente designato alla coltivazione di uva da vino. Al suo allestimento concorrono diversi soggetti pubblici e privati che ne hanno assunto la gestione diretta, contraddicendo il modello organizzativo di impronta popolare che altrove rappresenta la matrice distintiva di questa tipologia di fenomeni. Del resto non potrebbe essere altrimenti, se si considera la mole delle risorse logistiche e finanziarie messe in campo per gestire la massiccia affluenza di pubblico, nonché il notevole investimento in immagine che comune e cittadinanza si attendono di ricavare dall’esito positivo della festa.
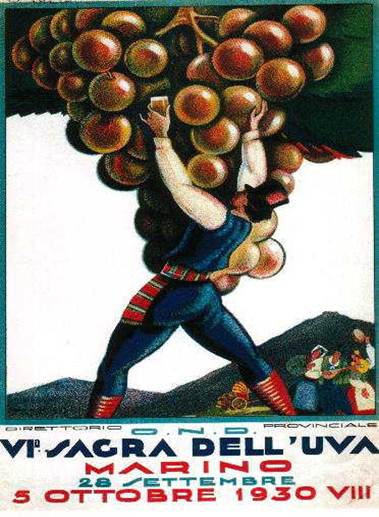
La sagra marinese, oltre a connotarsi come una delle più antiche del Lazio, si segnala anche per la sua netta apertura al business turistico che fin dall’inizio ne ha improntato la nascita. Istituita il 4 ottobre 1925 da Ercole Pellini in concomitanza delle celebrazioni patronali in onore della Madonna del SS.mo Rosario, il suo scopo originario è stato essenzialmente quello di promuovere «l’immagine di Marino e dei suoi prodotti vitivinicoli [...] tenendo conto dei servizi anche culturali che la città poteva offrire nel suo insieme [al] flusso di gitanti domenicali della capitale». Al riguardo, il modello a cui il poeta romano di origini marinesi si è voluto direttamente ispirare sono state le “Feste Castromenie”, precedenti manifestazioni popolari concepite “a tavolino” con l’obiettivo «di richiamare turisti da Roma e dintorni al fine di favorire il commercio e la vendita del vino». Tali feste, caratterizzate da sontuosi eventi culturali e di spettacolo, furono allestite nel 1904 per recuperare al crollo dell’economia locale dovuto ad una disastrosa grandinata che aveva distrutto tutto il raccolto gettando nel lastrico l’intera comunità.
Con gli stessi obiettivi di dare impulso turistico al territorio e di sostenere la produzione vitivinicola locale, a partire dal 1973 è stata istituita a Piglio (FR) la sagra dell’uva cesanese. Volta a pubblicizzare le qualità di uno dei vitigni autoctoni più importanti ed apprezzati della regione, la manifestazione ha luogo nel mese di ottobre e si svolge nell’arco di un’intera settimana. Per l’occasione i vari rioni dell’antico borgo stanziato sulle propaggini dei Monti Ernici vengono addobbati con coreografie alludenti alla tramontata “civiltà” contadina e vengono animati dalla presenza di alcuni gruppi canori che si esibiscono lungo le strade affollate di turisti. Inoltre, sempre al fine di ricreare un’atmosfera di vita tradizionale, i proprietari delle cantine invitano gli ospiti a “tracannare” il vino direttamente dalle tipiche “cupelle”, dando così piena soddisfazione a quella ricorrente ansia di folcloristico/pittoresco che una parte significativa di persone desidera attendersi da questo genere di eventi.
La volontà di rilanciare l’immagine di una località un tempo rinomata per il suo turismo balneare, e l’intento di promuovere la tipicità di un prodotto alimentare direttamente connesso all’agricoltura locale, ha portato la città di Ladispoli ad istituire nel 1950 la sagra del carciofo romanesco. Sorta in pieno periodo di boom economico, questa manifestazione si segnala attualmente come uno dei più rinomati appuntamenti fieristico-gastronomici dell’intera regione, nonchè come un valido veicolo pubblicitario con cui la città tirrenica intende dare impulso al proprio sistema produttivo locale: sia agricolo-commerciale che vacanziero. Infatti fin dall’esordio, si legge in un opuscolo di storia locale, «la manifestazione aprì ai cittadini ladispolani le porte dei mercati del nord come Firenze, Padova, Bologna e Verona […] e ebbe anche una importante funzione economica: erano molte infatti le famiglie romane che, avendo una casa, ne anticipavano l’apertura mentre altre venivano in quell’occasione affittando un appartamento o una camera». Capace nelle ultime edizioni di richiamare fino a 300.000 presenze da tutta Italia, la sagra si svolge ogni anno nel mese di aprile e coinvolge numerosi produttori agricoli che vendono in piazza i loro carciofi, crudi e cucinati. La sua preparazione è gestita in maniera verticistica dall’Amministrazione comunale e dalla Pro-Loco cittadina; inoltre, a causa degli importanti sviluppi fatti recentemente registrare dall’evento, lo stesso Ente Regione è entrato in qualità di suo sponsor ufficiale riconoscendogli lo statuto di Fiera regionale.
Di matrice organizzativa più prettamente popolare, ma sempre legata alla valorizzazione commerciale di un prodotto dell’agricoltura locale, è invece la sagra della cicerchia che si svolge a Campodimele, in provincia di Latina. Istituita per la prima volta nel 1981, la manifestazione ha luogo nel mese di luglio e consiste in un rito di piazza nel corso del quale viene distribuito il raro legume, un tempo assai presente nella cucina contadina povera. Il piatto, preparato da un comitato di circa 15 persone poste alle direttive della Pro-Loco, viene servito in zuppa con aggiunta di aglio e pomodoro e viene messo in vendita ad un prezzo convenuto che garantisce anche un bicchiere di vino. Il ricavato, recuperate le spese di gestione, viene reso ogni anno disponibile per finanziare attività di beneficenza o per realizzare opere di pubblica utilità. Gli stessi organizzatori, oltre a promuovere con vigore l’appuntamento gastronomico che richiama alcune migliaia di turisti dai principali centri del circondario e dalla stessa capitale, si sono recentemente impegnati nel fare opera di persuasione presso i coltivatori della zona al fine di incrementare la produzione del legume, attivando con successo il complesso iter legislativo necessario all’ottenimento di un marchio di qualità protetta. Marchio di qualità che, in provincia di Rieti, vede interessato anche un altro importante prodotto dell’agricoltura laziale: il marrone antrodocano.
Alla promozione di questo ricercato frutto si è voluto dedicare una specifica sagra che si tiene nel comune di Antrodoco (RI), alle falde del Monte Terminillo. Come molti altri eventi dello stesso segno che hanno luogo in ottobre nei diversi centri del Lazio montano, la sagra antrodocana si svolge in un clima di intensa spettacolarizzazione volto a richiamare l’attenzione dei turisti che percorrono le strade dei weekend autunnali. Nella circostanza, il comitato organizzatore provvede a distribuire gratuitamente un piccolo cartoccio di castagne che i partecipanti consumano in loco, unitamente all’acquisto di porzioni ulteriori di prodotto messe in vendita dai coltivatori locali alloggiati in appositi stand.
Sempre ad Antrodoco, inoltre, nei mesi di luglio-agosto hanno luogo altri due importanti eventi volti a valorizzare un prodotto gastronomico e una ricetta culinaria di schietta matrice autoctona: la sagra del pecorino e la sagra degli stracci antrodocani. Giunte quest’anno alla quarantaseiesima edizione, entrambe richiamano diverse migliaia di turisti dal Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria; inoltre, accanto alle sagre della polenta, della birra e degli spaghetti alla carbonara contribuiscono a rendere l’offerta gastronomica locale tra le più ricche e diversificate dell’intera regione.
Sulla base di questi limitati esempi, ritenere che le sagre costituiscano un fenomeno commerciale volto fondamentalmente a perseguire il marketing di un territorio o la promozione di prodotto alimentare locale rappresenta tuttavia un evidente errore di prospettiva. Più che un errore di prospettiva, un malinteso fondato su una parzialità di lettura e di analisi. Se si tiene debitamente conto delle differenti tipologie di sagre presenti in tutto il Lazio (vedi Tab.3) è possibile infatti constatare come accanto a situazioni come quelle sopra menzionate ve ne sono numerose altre che manifestano un’assoluta mancanza di referenzialità sia con gli aspetti produttivi del territorio sia con la volontà di ri-valorizzare le tradizioni gastronomiche ad esso relative.
Queste categorie di sagre, tipiche soprattutto delle aree carenti di risorse agro-alimentari autoctone e povere di ricettari culinari tradizionali - ma tipiche anche di molti borghi satelliti di città di medio-grande dimensione - sono spesso concepite con lo scopo di conferire un livello di maggiore visibilità a luoghi (altrimenti) sprovvisti di significative attrattive di tipo paesaggistico, storico-culturale, artistico-architettonico. In relazione a siffatto genere di manifestazioni, gli organizzatori sembrano non preoccuparsi affatto di offrire agli avventori prodotti gastronomici avulsi con le stagioni in corso, o con le caratteristiche ambientali delle zone di svolgimento: e così allestiscono degustazioni di vino nel mese di giugno, della salsiccia e della polenta in quelli di luglio-agosto, del merluzzo in località di montagna, o del porcino e della castagna in zone prive di idonee aree boschive.
In alcune documentate situazioni, le sagre sembrano invece rispondere al prevalente obiettivo di perseguire un business economico legato alla vendita di prodotti di cui il mercato stagionale propone un’alta domanda. È il caso delle estivissime sagre della birra e del cocomero, delle autunnali e recenti sagre del vino novello, delle invernali sagre della polenta, o delle tardo-primaverili sagre delle fave e delle ciliegie. In simili casi, non avendo le Pro-Loco e le amministrazioni comunali interessi diretti a sostenere l’iniziativa, i compiti organizzativi sono assunti in prima persona da gruppi associativi, o da comitati spontanei di cittadini, attratti dalla possibilità di realizzare agevoli ricavi da destinarsi ad attività di tipo diversificato (in genere di beneficio collettivo, più che di lucro privato).
Sagre e feste a confronto: alcune ipotesi conclusive
La moderna ermeneutica antropologica concepisce le sagre gastronomiche come un fenomeno di tradizione inventata; rilevando, nella maggior parte di esse, la mancanza di riscontrabili agganci con preesistenti tradizioni da cui farne derivare l’origine storica.
È vero. Il mondo contadino/pastorale ha storicamente conosciuto molteplici occasioni in rapporto alle quali la distribuzione collettiva di cibo ha assunto un ruolo di primaria importanza. Tuttavia è altrettanto vero che tali situazioni hanno quasi sempre costituito parte integrante di una dimensione cerimoniale strettamente connessa ad eventi di natura religiosa. Tra questi, quelli collegati al calendario liturgico e, soprattutto, alle feste patronali, hanno rappresentato l’ambito più appropriato in cui situare momenti di condivisione alimentare di natura compensatoria ( negare l’indigenza cronica), apotropaica (scongiurare i rischi per il raccolto), propiziatoria (favorire l’abbondanza di risorse alimentari).
FESTA PATRONALE |
SAGRA GASTRONOMICA |
Collocazione in una dimensione religiosa dei suoi significati e dei comportamenti collettivi |
Dimensione integralmente laica della sua rappresentazione. Raramente la sagra trova spazio in un contesto celebrativo di tipo festivo-patronale |
Destinazione sociale introflessa: la comunità si autorappresenta e celebra se stessa. |
Destinazione sociale estroflessa: la comunità si apre all’esterno per ricavare profitto e visibilità |
Eccesso alimentare come una delle componenti significative finalizzate alla compensazione e alla propizione di abbondanza |
Consumo alimentare come principale componente significativa atta a perseguire finalità direttamente remunerative |
Sospensione delle funzioni economiche e produttive |
Perseguimento di utilità economica |
Consumo rituale di un menù alimentare diversificato nel quadro di una dimensione domestica e familiare |
Consumo voluttuario di un prodotto alimentare esclusivo effettuato in ambito pubblico e collettivo |
Relazione cronologica con i cicli stagionali e il calendario liturgico |
Relazione funzionale con i cicli stagionali e il tempo vacanziero |
Rigidità del protocollo cerimoniale |
Carenza di prassi rituali di svolgimento |
Questua collettiva e fruizione gratuita dell’evento pubblico |
Impegno economico da parte di uno o più soggetti comunitari e fruizione a pagamento dell’evento |
Oggi, in un contesto storico-antropologico in cui viene fatto un ampio uso strumentale della cultura popolare, le sagre gastronomiche rappresentano sì un fenomeno di invenzione della tradizione, spesso pensato per creare immagini utili all'industria turistica; tuttavia, viste in base ad una differente angolazione prospettica, costituiscono una realtà dagli attributi assai più complessi e articolati. Costituiscono, cioè, una categoria creativa e utilitaristica di micro-imprenditorialità che, scaturendo dal basso e cavalcando il successo della domanda gastronomica di “genuina fattura”, sembra voler perseguire un triplice, ma non certamente esclusivo, obiettivo:
promuovere in forma auto-vantaggiosa le risorse produttive presenti nelle aree rurali e montane del territorio regionale, spesso compresse o de-vitalizzate dal persistente sottosviluppo che caratterizza i centri più distanti dai principali distretti industriali, commerciali e finanziari;
inserirsi all’interno di circuiti vacanzieri che, per quanto limitati ad un turismo di tipo “mordi e fuggi” e per quanto circoscritto agli spazi del weekend o del periodo estivo, sono tuttavia ritenuti in grado di attivare un indotto vantaggioso per la (ri)valorizzazione culturale ed economica dei centri stessi;
plasmare o ricostruire un’identità di gruppo, disgregata dallo spopolamento degli ambienti rurali, da negoziare nella dialettica locale-globale; dialettica al cui interno spiriti campanilistici, attaccamento alle radici e ripristino delle tradizioni giocano un ruolo primario e nient’affatto trascurabile.
Per tali diretti fini, ad organizzare sagre popolari non attendono grandi multinazionali del cibo o importanti enti pubblici, il cui impegno promozionale in campo alimentare consiste nell’allestire fiere o kermesse di maggiore risonanza mass-mediatica; nè sono professionisti della gastronomia e della ristorazione. A proporre e organizzare sagre sono fondamentalmente comitati spontanei di cittadini raggruppati in circoli culturali e ricreativi, associazioni sportive e di volontariato, centri sociali, parrocchie, confraternite, misericordie, pro-loco.
Alla luce di simili considerazioni appare del tutto riduttivo risolvere il discorso sulle sagre bollandole in termini di eventi costruiti su di una falsa memoria ad uso e consumo dell’industria turistica di massa, come spesso accade di cogliere nelle parole di alcuni specialisti delle materie demo-antropologiche. Certo, nessuno dubiterà mai che esse siano un’invenzione recente delle mode neo-folcloriche e del marketing territoriale; così come nessuno crederà mai che l’autenticità dell’offerta gastronomica sia ovunque e comunque garantita. Ciò, tuttavia, non costituisce ragione sufficiente per destituire il senso dei loro valori funzionali o per ritenerle realtà prive di una matrice identitaria popolare.
Del resto è un dato ormai acquisito che la sola profondità storica non può ritenersi come il parametro sufficiente per decretare l’autenticità di un costume o di una tradizione; così come è altrettanto noto che non tutto ciò che proviene dal passato sia da ritenersi portatore di valori folclorici tradizionali di per sé autentici. Cos’è allora che permette di considerare le sagre del Lazio contemporaneo, soprattutto rurale e periferico, come l’espressione di una cultura popolare propriamente intesa? Le parole di Alberto Cirese ne offrono un attendibile chiarimento:
la popolarità di un fenomeno culturale non dipende dall’origine e dalla forma […] dipende invece dal fatto che quel particolare fenomeno è presente (esclusivamente o almeno in modo prevalente e caratterizzante) in un certo ambito sociale, e non è presente (o è presente in modo non caratterizzante) in altri ambiti sociali che coesistono con i primi. In altre parole […] ciò che in genere fa la «popolarità» di un fatto culturale è la relazione storica di differenza o di contrasto rispetto ad altri fatti culturali coesistenti e compresenti all’interno di uno stesso organismo sociale.
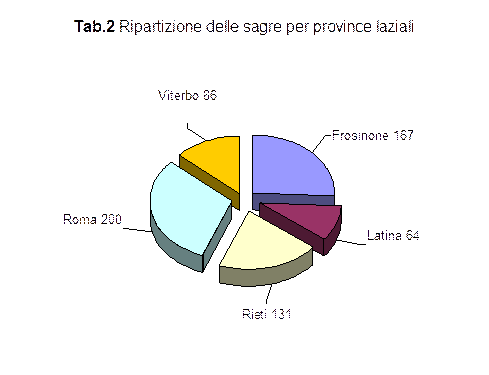

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
2004 Barberis C. (ed.), Identità e tradizione gastronomica del Lazio, «Quaderni di Informazione Socioeconomica», n. 10.
2003 Castello A., Le sagre nel Lazio, Roma, ARSIAL.
2002 Zanini De Vita O., il cibo e il suo mondo nella campagna romana, Roma, Alexandra Editrice.
2002 Dei F., Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi.
2002 Zongoli M. V. (ed.), Le vie di Bacco nel Lazio. La via dei Castelli Romani, Roma, Gangemi.
2001 Clemente P., Mugnaini F., Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci.
2000 Russo N., L’ambiente rurale laziale, Roma, Grafica Rispoli Editrice.
2000 Carbone A., Dono G., Gioia M., Indagine sui prodotti agricoli tipici della Regione Lazio,«Quaderni di Informazione Socioeconomica», n.3.
1998 Jannattoni L., La cucina romana e del Lazio, Roma, Newton Compton.
1986 Cirese A. M., Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo.
Il titolo completo dell’opera è: Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante; ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes.
Vedi Bourdieu (1979), Goody (1982), Harris (1985), Appadurai (1988), Fischler (1990), Lupton (1996), Mintz (1996), Poulain (2002), Rappoport (2003).
Queste valutazioni, e altre qui volutamente non prese in considerazione che collegano gli alimenti a scale di valori simbolici socialmente condivisi, sono il frutto di una indagine condotta dallo scrivente tra gli studenti dell’Università romana di Tor Vergata nel corso dell’a. a. 2008-2009. L’indagine è tuttora in fase di svolgimento e i risultati complessivi saranno disponibili per la fine del 2010.
Quella stessa antieconomicità e quella stessa selettività nei consumi che trovano la loro più efficace ratifica nel celebre aforisma «Tutto ciò che abbonda è vile», pronunciato dal dotto Isidoro di Siviglia con esplicito riferimento all’avversione per i fagioli, e per tutto quanto sapeva di eccessivo e grossolano, da parte delle classi dominanti del Medioevo europeo. Montanari (1997), p. 358.
Un altro esempio di culturalizzazione evincibile nelle denominazioni alimentari è quello che rinvia alle procedure di confezionamento/stagionatura degli alimenti: formaggio di fossa, canestrato, soppressata, coppiette, sottocenere, e cia discorrendo. In simile caso la dimensione della cultura che viene implicata è quella cosiddetta “materiale”. Cfr. Di Renzo (2006)
Fatta naturalmente franca la proibizione, connaturata al fenomeno di freudiana/levistraussiana memoria, del nutrirsi del cibo totemico.
Avvisa al riguardo Corrado Barberis (2004, pp. 61-62): «Sarebbe difficile definire "tipici" i piccoli pesci che rimangono incagliati nelle reti dei pescatori del lago di Bolsena con i quali si prepara la famosa sbroscia, e nemmeno possono essere definiti "tipici" gli altri ingredienti che la compongono, poiché sia le patate che la mentuccia sono diffuse comunemente in tutta la regione. Assai più diffìcile sarebbe poi stabilire la tipicità della zuppa di pesce di Nettuno, anche se il pesce che si pesca lungo quel litorale ha caratteristiche di sapore davvero particolari».
Per il DELI (Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1979, 5 voll.), il termine sagra deriva da sagro, var. di sacro, (“festa sacra”). Le prime attestazioni note di sacra risalgono al XIV secolo, ad es. al 1342, col significato di “festa nell’anniversario della consacrazione di una chiesa”. Il significato di “festa popolare con fiera e mercato” compare per la prima volta nel Boccaccio (1353), associato ad una voce ancora di diffusione chiaramente regionale (veneto-lombarda). Il recente slittamento semantico verso il significato di “festa a carattere unicamente laico e ludico, con abbondanti libagioni” potrebbe essere stato facilitato anche dal D’Annunzio, che usò sagra come sinonimo di “commemorazione civile” (ad es. La Sagra dei Mille, maggio 1915). L’uso attuale della parola, dunque, sembra porsi esattamente all’incrocio tra il termine boccaccesco e quello dannunziano.
Questo lavoro è l’esito parziale di un work in progress condotto da chi scrive nel territorio laziale nel biennio 2003-2004. I dati statistico-numerici riportati, pur nel rigore metodologico del loro reperimento e della loro trattazione, hanno valore indicativo in riferimento allo specifico arco di tempo considerato. Ciò dipende dal fatto che le sagre, pur nel quadro di una sostanziale fissità di svolgimento, sono suscettibili anno per anno di possibili modificazioni nel numero, nella collocazione calendariale e nella tipologia gastronomica.
V. Piccinin, Le fonti e il territorio, in C. Barberis (ed.), Identità e tradizione gastronomica Nel Lazio¸ in «Quaderni di Informazione Socioeconomica», n. 10, 2004, p. 25.
Alla definizione di un numero così elevato di sagre sì è pervenuti mediante un procedimento di ricerca in cui, allo spoglio delle dispersive e non sempre attendibili fonti documentarie disponibili, è stata costantemente interpolata una ricognizione diretta sul terreno volta a verificarne e aggiornarne lo svolgimento.
Tale realtà sembra assegnare una posizione di sostanziale primato soprattutto ai paesi di piccole e medie dimensioni posti in aree extra-urbane rurali e montane; laddove sia le città capoluogo sia i centri maggiormente industrializzati fanno registrare valori di gran lunga inferiori alla media rilevata.
Alle sagre della bruschetta possono essere accostate, per evidente similarità di prodotto, quelle delle panzanelle, frese e panemollo, di cui sono rilevabili complessivamente 6 casi.
Gennaio, seppure con cifre relativamente basse, è il mese che esprime il maggior numero di sagre. La ragione è da ricercarsi nella ricorrenza calendariale della festa di S. Antonio Abate, in occasione della quale in molti paesi si provvede ad organizzare la tradizionale distribuzione collettiva di cibo rituale.
Non bisogna trascurare la circostanza che nel periodo compreso tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile cade generalmente la Quaresima, tradizionalmente connessa alla morigeratezza dagli eccessi alimentari. Essendo quello delle sagre un fenomeno fortemente legato alla dimensione conservativa delle campagne, ciò fa si che in molti casi ancora si rispettino i consuetudinari precetti religiosi.
Fonte: http://www.uniroma2.it/didattica/trad-pop-a/deposito/Dispense_Storia_delle_tradizioni_popolari_2010.doc
sito web :http://www.uniroma2.it/didattica/trad-pop-a/
Autore: Ernesto Di Renzo
Storia delle tradizioni popolari
Visita la nostra pagina principale
Storia delle tradizioni popolari
Termini d' uso e privacy