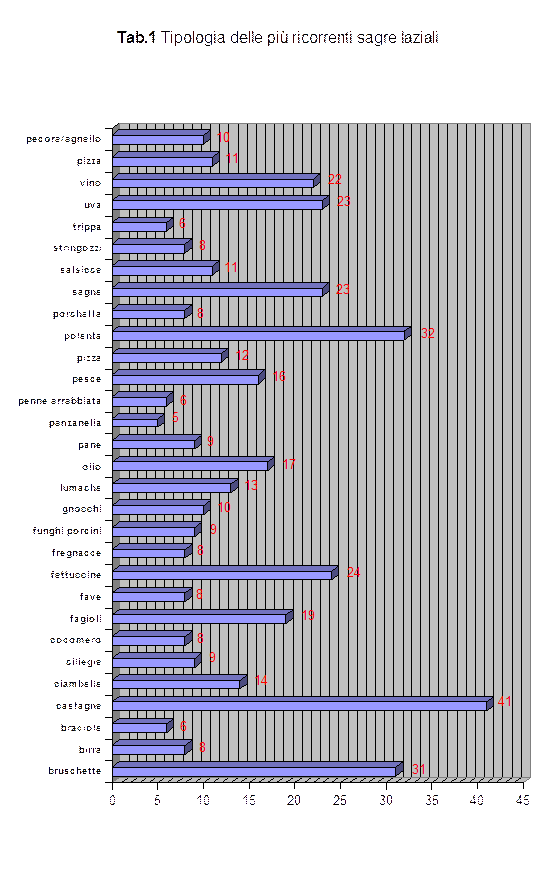Studio dei fenomeni festivi e rituali
Studio dei fenomeni festivi e rituali
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
"Dossier festa”
Materiali didattici per lo studio dei fenomeni festivi e rituali
Ernesto Di Renzo
Premesse
Le presenti pagine intendono offrire uno sguardo problematico e problematizzante sul fenomeno culturale della festa, oggetto di approfondimenti specifici nell’ambito dei moduli di Storia delle Tradizioni Popolari e di Antropologia del Turismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Intesa antropologicamente come “fatto sociale totale”, la festa si configura come un deposito di valori, comportamenti standardizzati, pratiche collettive e dispositivi simbolico-rituali che appartengono in proprio a tutte le società ed epoche della storia. Una sorta di lessico universale, dunque, mediante il quale gli uomini hanno provveduto ovunque ad organizzare i propri “calendari esistenziali” funzionalmente ai ritmi lavorativi, alle esigenze materiali dell’esistenza ed all’assolvimento dei bisogni più disparati: evasione dalla routine, sovvertimento/riconferma delle regole sociali, esaltazione delle identità particolari, rigenerazione del tempo e dei rapporti intersoggetivi, (ri)plasmazione dei valori comunitari, (ri)collocazione del presente nella storia e viceversa.
Concepiti come integrazione dei contenuti del corso monografico impartito a lezione, i saggi che compongono questo volume (tratti da fonti bibliografiche differenziate di non facile ed immediata reperibilità da parte dello studente) costituiscono una piccola ma significativa antologia di scritti che mirano essenzialmente a riflettere sul modo in cui l’istituzione festiva si inserisca oggi nell’ambito della dialettica globale-locale, sacro/profano, tradizione/modernità. Dialettica all’interno della quale concetti come quelli di innovazione, invenzione, rifunzionalizzazione, revivalismo culturale, autenticità rappresentata esperiscono tutta la loro portata di problematicità e di propositività euristica su cui si vuole invitare chi legge ad una dovuta ponderazione critica.
Ernesto Di Renzo
Le trasformazioni della festa nella modernità avanzata
Antonio Arino
II tempo della festa
Secondo la Grande Narrazione della modernità, la festa - al pari del costume, del rito, della fede - sarebbe condannata a sparire sotto "le gelide acque del calcolo egoista" (Marx), o a restare pietrificata nella "brina dell'ascesi puritana" (Weber). In effetti la modernità nacque anti-festiva, e con essa le scienze sociali, che contribuirono alla realizzazione di una critica minuziosa delle condotte rituali e della cultura popolare tradizionale: entrambe infatti - si ipotizzava - sarebbero state ostacoli nell'ingranaggio della macchina del progresso e della razionalità. Di conseguenza anche lo studio delle feste venne ridotto allo status di folklore, e identificato come una passione di nostalgici i quali - dinanzi al progresso dell' omogeneizzazione industriale, urbana e in seguito anche mediatica - intonavano i loro funerali e elevavano le loro piagnucolose lamentazioni.
Gli anni Sessanta del nostro secolo immaginarono però un ritorno a Dioniso (un dio ciclicamente redivivo), e produssero una nuova sensibilità basata sull'esaltazione del corpo, la danza, la musica, l'orgia... Senza dubbio la rilettura che questa sensibilità produsse della festa non poteva che essere distorta e selettiva: fra le tradizioni in cui essa si imbatteva nuovamente così dominava il disordine carnevalesco, ma mancava il corteo disciplinato e reverente del Corpus Christi. Dopo la ventata impetuosa e fugace del dionisismo controculturale, la festa continuò comunque a imporre il proprio riscatto, stimolata da forze diverse e assumendo aspetti molteplici. Hanno proliferato commemorazioni, campionati mondiali, festivals, centenari e ogni sorta di eventi fastosi con pubblici televisivi inauditi: prodotti di una meticolosa ingegneria culturale di massa. E insieme la convergenza fra la crìtica alle conseguenze nefaste dell'apoteosi della ragione strumentale e il fiorire delle politiche identitarie (nazionali, etniche, di genere, d'età ecc.) ha suscitato un vivace movimento di rivitalizzazione festiva. In Spagna questa grande corrente si è intrecciata col processo di democratizzazione e la nuova domanda di feste popolari. In quest'ottica gli anni Ottanta e Novanta possono esser descritti come un vero e proprio tempo di festa (tiempo de fiesta).
E proprio Tiempo de fiesta (1982) è il titolo di un importante libro curato da Honorio Velasco, che inaugurava in Spagna e per le scienze sociali il tempo della festa: sino ad allora alcuni antropologi si erano occupati della festa soltanto come pretesto per affrontare altre questioni, mentre quel libro trasformava la festa in specifico ed esplicito oggetto di indagine e riflessione. Da quel momento l'antropologia - e in misura minore la storia, la sociologia o la semiotica - iniziarono ad accostarsi alla festa come fenomeno in sé e per sé, senza più reticenze puritane né riduzionismi folklorizzanti. Con quel libro la nostra bibliografia si aggiornava, seguendo quel che già si stava facendo in Italia o in Francia da un decennio.
La massa di dati che si è accumulata negli ultimi anni con questa convergenza interdisciplinare è considerevole; oggi incominciamo a conoscere bene le feste dell'Antichità, la festa popolare medievale, le Entrées Royales (Entradas Reales), le feste urbane con le loro confraternite o le celebrazioni del furore rivoluzionario. E possiamo contare su descrizioni e analisi dei ritmi e delle pulsioni festive di culture assai diverse - dal rituale bantu, himba o ndembu sino al Carnevale di Rio, alla processione del Corpus Christi, al Palio di Siena, alle Fallas di Valentia o al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.
Tuttavia non sì è prodotta soltanto una accumulazione di dati: si è verifìcata una costante ridefìnizione della natura della festa e di alcuni concetti chiave, con un cambiamento nella scelta delle unità d'analisi, brusche conversioni epistemologiche e una diversificazione delle fonti. Così si è ridiscusso il concetto di rituale e si è spostata l'attenzione dallo studio della festa presso i popoli o comunità rurali alla festa urbana, tentando di armonizzare lo studio in profondità - basato su un intenso lavoro sul terreno - con la realizzazione di inchieste estensive, integrando sempre più i processi di globalizzazione nella spiegazione dei mutamenti locali. Ecco perché è opportuno soffermarsi su alcuni di questi mutamenti,
Pur senza rifiutare del tutto gli approcci classici di Caillois, Bataille o Duvignaud - che adottando una interpretazione essenzialista e normativa della festa la identificavano con la commemorazione effervescente di un ipotetico caos primordiale - oggi la festa viene intesa in modo più empirico e contestuale come fenomeno collettivo di gran complessità che si pone in relazione dialettica con la vita quotidiana: una trasgressione paradossale dell'ordine sociale e della sua razionalità produttiva. La festa, insomma, esprime ed afferma una dimensione chiave dell'esistenza comunitaria, che mette in gioco i registri più diversi della vita sociale: tempo senza tempo, sottratto alla durata e sospeso nell'estasi gioiosa della pienezza, essa è un'eccezione ma ciclica e ripetitiva; un'istituzione che genera spontaneità, ludica ed autosufficiente, ma al tempo stesso fonte di oscura sacralità. Nell'ambiente/tempo della festa la socievolezza si fa più intensa, poiché viene alimentato e accresciuto il sentimento di un vincolo generale che travalica le gerarchie e le condizioni sociali per attingere a un senso profondo della vita del gruppo, espresso e messo in risalto dalla ricca proliferazione simbolica e rituale. La festa è azione collettiva, coi soggetti celebranti e gli oggetti celebrati - gli uni e gli altri identifìcabili o confusi, a seconda dei contesti; essa non appartiene al dominio del razionale, eppure è impossibile spiegarla partendo dall'irrazionale. Secondo Giner essa trova i propri fondamenti nell'ambito metarazionale del carisma; come noi stessi abbiamo sostenuto in un altro contesto (Arino, 1992: 15) essa consiste inoltre in un'azione simbolico-rituale che - come la metafora - ha la straordinaria capacità di evocare e affermare una realtà inaccessibile alla descrizione diretta, una realtà che solo il gioco dei riti e dei simboli può rappresentare, insieme alla trasgressione delle significazioni usuali del nostro linguaggio e del nostro comportamento.
Sebbene nessuno identifichi la festa con il rito, saranno in pochi a non riconoscere che entro qualsiasi programma festivo abita ed opera un rito - per quanto sfumati possano esserne i tratti. Tuttavia il concetto di rito ha subito una costante deriva semantica da un uso più ristretto che include trascendenza e sacro verso una più vasta concezione, che lo omologa alla condotta formale e ripetitiva. Così se Muller, Spencer, Tylor, Frazer, Otto e tanti altri utilizzando questo sostantivo parlavano di riti e credenze, più di recente si è preferito sostantivare l'aggettivo rituale - manifestando un'insicurezza verso le caratteristiche intrinseche del rito e al contempo una dilatazione o una estensione dei fenomeni classificabili sotto questa etichetta. Gli studi sul rituale e la formulazione della teoria delle 'religioni civili' hanno di conseguenza abbracciato tematiche disparate - il "rituale" dell'aperitivo, il cambio della guardia, l'incoronazione di un principe, le regole dell'etichetta, le performances ecc. Come ha detto C. Bell
l'ampia varietà di attività che hanno finito per essere analizzate quali modelli di comportamento ritualizzato è testimonianza delle tendenze promiscue di questa corrente dì studi: aggressione e combattimento, canzone, giochi, sports, fidanzamento, corteggiamento, dramma, danza, umorismo, arte e persino lo stesso pensiero. Identificando il rituale con le funzioni comunicative formali, essa riconosce il rituale in quasi tutte o nella maggior parte delle attività (Bell 1992: 73).
Paradossalmente Bell ha reso ancora più acuta l'indeterminazione e la vaghezza della parola 'rituale' proponendo in sua vece il termine ritualizzazione - estendendo il concetto in modo pressoché infinito. E tuttavia, per quanto ampliarne le maglie della nozione, è diffìcile eludere una qualche idea o residuo di sacralità se si vuole che continui a mantenere una sua stabilità: così Maisonneuve ha proposto una definizione "inglobante e trasversale" in cui "il rituale è un sistema codificato di pratiche [...] che implica [...] una certa relazione con il sacro" (1991: 180), e anche F. Cruces, rifacendosi a Goffman (rispetto e mancanza di condizionamenti sulla persona), a Leach (organizzazione del tempo sociale), e a Tambiah (multimedialità efficace performativamente) tenta di applicare allo studio delle feste di Madrid un concetto ampio, processuale e performativo di rituale, che riconosce almeno la manifestazione di una debole sacralità - qual è quella che può rivelarsi nella costruzione del "noi" dentro il contesto pluralista e frammentato della città moderna (1995: 37 e 43-44). In questa generalizzata deriva del concetto diviene necessario cogliere i mutamenti che questa forma di azione sperimenta nella modernità. Il rito - che in altra cornice storico-culturale divenne una complessa matrice dalla quale germogliarono e si staccarono la danza, la musica, il teatro ecc. - nella modernità si concentra, specializzandosi in una ierofania fragile e diffusa: la costruzione e riproduzione di molteplici identità, che scongiurando il caos istituiscano un cosmo significativo che ne consacri il senso - anche se ormai profano; in sintesi, il rito mira alla creazione di fiducia e sicurezza ontologiche.
Ma lo studio ed il pieno riconoscimento dello statuto epistemologico della festa ne ha determinato anche uno spostamento, o piuttosto una ricostruzione. Così mentre le feste rurali di una comunità compatta e omogenea come può essere quella di un paese - che possono svolgersi nella piazza pubblica o in occasione delle sagre religiose essendo vissute da una comunità identificata, chiusa in sé e che in sé si riassume - cessano di avere l'interesse e il rilievo che era stato attribuito loro, le ricerche si sono piuttosto via via orientate in una duplice direzione: quella dello studio dei fenomeni di rivitalizzazione, e quella della festa urbana.
Sebbene il concetto di rivitalizzazione sia ancora problematico, tuttavia ha ottenuto una sorta di consacrazione scientifica con il libro edito nel 1992 da Boissevan (Revitalizing European Rituals), che raccoglie diversi studi sulla sorprendente intensificazione delle feste vissuta dal mondo industriale e particolarmente dall'area mediterranea nel corso degli anni Ottanta. Dal nostro punto di vista il termine rivitalizzazione può avere una qualche utilità, se lo utilizziamo per designare l'ampio ventaglio di mutamenti che negli ultimi anni hanno suscitato non solo un recupero (una riproposta1, seguendo il lessico italiano) di rituali che languivano ma anche l'invenzione di nuove celebrazioni, inducendo altrettanti cambiamenti nei significati, nei soggetti coinvolti e negli interventi di mediazione culturale.
G. Bravo (1984) ha ipotizzato una relazione fra pendolarismo e festa per spiegare questa rivitalizzazione nel mondo rurale italiano; il pendolarismo va qui inteso come un movimento di va e vieni, o un percorso che unisce distinte formazioni sociali copresenti storicamente; una percentuale crescente di individui può così selezionare e sfruttare le condizioni preferite in ciascuna di tali formazioni - ad esempio lavorare in città e al tempo stesso mantenere le proprie radici sociali e i vincoli più stretti nel mondo rurale. I soggetti pendolari della modernità avanzata sono i principali organizzatori di feste tradizionali recuperate dalla comunità, trovando in esse orientamento e fiducia per vivere in un universo mutevole e poco sicuro. Nella stessa direzione hanno condotto le proprie ricerche R. Grimaldi (1987), P. Grimaldi (1993) e A. Artoni, mentre in un altro versante — pur senza condividere il citato impianto euristico - G. Centelles (1995) ha di recente realizzato una ricerca monografica sui pellegrini del Catì giungendo a conclusioni simili, ed evidenziando fra l'altro l'influsso che esercitano sulla festa locale gli sguardi esteriori (turisti, televisione) o semi-esteriori (studenti e emigranti che ritornano).
Ma il fulcro dell'interesse si è spostato più nettamente allorché si sono presi come unità d'analisi i grandi centri urbani: com'è accaduto con varie tesi di dottorato che - a partire da una prospettiva storica ampia (Arino, 1992, 1993) o da una prospettiva antropologica fondata su un'osservazione partecipante intensiva (Cruces, 1995) - fanno riferimento a città come Valencia e Madrid. In queste ricerche vengono analizzate tutte le feste, da quelle più grandi come le Fallas (con la loro capacità non solo di turbare la vita urbana per ben quindici giorni, ma anche di riconfìgurarla nel corso dell'intero anno, di espandersi e irradiare il proprio influsso all'ambiente circostante, di attrarre migliaia di visitatori e far nascere professioni ed attività produttive peculiari) sino alla festa civile del Due di Maggio a Madrid (istituita di recente come festa autonomistica: con la sua trasformazione degli eroi locali in santi laici, con la sua formalistica cerimonialità e la sua esplicita valenza politica) o ai megaconcerti pop e rock (che completano l'offerta di festivals o settimane culturali). Nell'assumere la città quale oggetto di studio svaniscono alcuni presupposti dati per acquisiti, e diventa rilevante sia la lotta e la negoziazione fra insiemi di interessi in conflitto, sia la frammentazione e la perdita di identità dei soggetti, la pre-fabbricazione istituzionale del rituale o il carattere di liturgia civile di alcune pratiche2. Di conseguenza, questo spostamento delle unità d'analisi richiede una nuova costruzione della festa come oggetto dì studio delle scienze sociali, e pone in primo piano la relazione fra la festa e la modernità avanzata o le trasformazioni della festa a seguito dell'impatto con i processi di globalizzazione.
Un terzo aspetto nuovo merita di essere preso in esame: la comparazione sistematica fra ricerche intensive e la realizzazione di indagini estensive condotte da gruppi di ricercatori che tentano di ricostruire in forma cartografica la situazione della festa in un momento e in un territorio dati. Il primo lavoro apparso è la Guìa de las Fiestas Populares de Andalucìa (1982), che sebbene sia forse stato un frutto ancora acerbo manifestava già l'esistenza di una massiccia domanda di informazione utile a molteplici scopi, e dunque segnò l'inizio dì una tendenza. In seguito apparirono il Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja (1989) e il Calendari de Festes de les Illes Balears i Pitiuses (1992), che si propongono di realizzare un inventario minuzioso, completo, aggiornato e rigoroso - senza vie di mezzo, insomma - di tutte le feste che si celebrano in un territorio predeterminato (ad esempio, il Calendari de Catalunya include qualsiasi manifestazione festiva che sia stata ripetuta per tre anni o più). Viene così presentata una specie di radiografìa o di sezione trasversale dello stato della festa in un momento storico concreto, che consente di cartografare la presenza e la diffusione di determinate celebrazioni e festeggiamenti abbozzando al contempo tendenze evolutive. Il progetto denominato Calendari General de Festes de la Comunitad Valenciana in corso di realizzazione è parte di questa iniziativa; esso vuol essere una banca dati informatica a disposizione del pubblico, incorporando una massa crescente di informazioni che la doti di profondità storica3.
La festa nella modernità avanzata
La ricerca e le analisi recenti continuano a mettere in rilievo non soltanto la vitalità ormai evidente della festa e del rituale nelle società contemporanee ma anche le loro metamorfosi, la cui radicalità richiede un approfondimento ulteriore. Con uno schema già sperimentato (Arino 1995a e 1995b), mi propongo di esplicitare e indicare alcuni di tali mutamenti e tendenze: alcune trasformazioni si riferiscono alla cronologia (data di celebrazione, programma), altre alla sintassi della festa (linguaggi), altre riguardano la sua semantica (oggetto celebrato) e infine la sua logica sociale (soggetto celebrante).
In relazione alla cronologia della festa o alla sua logica temporale, possiamo indicare la crescente coscienza della complessa intersezione esistente tra la festa e il tempo: in primo luogo interpretando la festa nella sua relazione dialettica con la vita quotidiana, nel suo carattere costitutivo del tempo sociale, e differenziando le feste cicliche da quelle occasionali, quelle che sono parte di un sistema - generando perciò un ordine nella durata della vita sociale - da quelle che esprimono e regolano soltanto la congiuntura straordinaria - simbolizzando in tal modo l'irruzione di determinati poteri, messaggi e avvenimenti. La modernità avanzata postula una distruzione dell'ordine tradizionale del tempo che si è tradotta nella soppressione dì alcune feste, nello slittamento di altre e in processi di concentrazione attorno alla festa più importante - che è spostata in periodi di vacanza. Ma il fenomeno più significativo sta nel fatto che la organizzazione locale del tempo è ormai esplicitamente integrata con ritmi e modelli universali, con l'organizzazione generale tipica della società industriale e del terziario. Per questo le date di celebrazione oscillano adattandosi ogni anno al calendario; persino i periodi dedicati alle feste maggiori - in continua dilatazione per far posto all'accumularsi di piccoli segmenti festivi che celebrano patronati di gruppi d'età, di stati (estados), mestieri e strati sociali - sono strutturati dosando in modo intermittente i festeggiamenti nel corso dei diversi fine-settimana, al punto che i limiti di ciascun ciclo festivo nella sua globalità non sono più fissi. In poche parole si disarticola il sistema di feste e si riorganizza la loro ubicazione nel calendario secondo la logica della modernità, e al tempo stesso si trasforma la sequenza interna della festa, il suo programma, la successione e l'ordine dei festeggiamenti - in altre parole la sua sintassi.
Ma la festa si intreccia con il tempo in altri sensi. Da un lato, la sua immaginaria sospensione della durata non vuol essere una abolizione, ma una consumazione del tempo; nella festa passato, presente e futuro si amalgamano con intensa inquietudine per produrre l'effetto desiderato: il richiamo persistente che persino i gesti e le azioni più irrilevanti fanno alla continuità con il tempo passato, la sottomissione al dettato imperioso della tradizione, l'evocazione dei defunti - tutto quanto è vólto senza dubbio a instaurare un fondamento solido, assoluto per il presente e il futuro della collettività, a generare fiducia e senso verso l'esistenza. Del resto un'epoca proiettata nel futuro come la nostra - modellata dal mutamento tecnologico permanente che rende obsoleti i saperi e svaluta incessantemente il passato - genera instabilità e paradossalmente seleziona e rende intangibili determinati oggetti e riti. Quanto più manipolabile diviene la storia, tanto più necessaria si fa l'instaurazione di un fondamento simbolico assoluto.
D'altro canto la scienza storica ci ha insegnato a discernere come si mescolino in qualsiasi fenomeno sociale distinte forme di temporalità: tempi ampi di permanenze secolari, oscillazioni lente vincolate a mutamenti nella struttura sociale, moti alterni e innovazioni sottomesse alla tirannia della moda. Nella festa così si intrecciano costantemente sopravvivenza e innovazione, perché la tradizione non è nient'altro che una strategia fondativa, che legittima un atto o la sua pratica riferendolo a un passato idealizzato. Alcune feste durano per secoli, attraversano formazioni sociali distinte e forse addirittura mantengono alcuni tratti formali intatti; però trasformano i propri significati e funzioni, adattandosi alle necessità dei propri soggetti che si rinnovano di continuo. Come dice Vovelle, «la festa è un'invariante che non ha mai smesso di variare».
Uno degli aspetti che dovrebbero richiedere un'attenzione maggiore da parte degli studiosi della festa nell'attualità è senza dubbio la sua sintassi, il suo linguaggio, il suo modo di articolare festeggiamenti e il tipo di articolazioni che produce. Uno sguardo alla evoluzione della festa valenciana ci consente di notare la diffusione e generalizzazione di alcuni tratti che stanno trasformando e omogeneizzando la fiosionomia di feste molto diverse; sebbene alcuni tratti non siano esclusivi della modernità, è nel corso di quest'epoca che hanno assunto una preminenza e ricevuto una consacrazione del tutto nuova: si pensi ad esempio all'esibizione vestimentaria di grandi masse organizzate in associazioni volontarie, che da luogo a un estetismo competitivo. La stessa cosa accade per la commensalità pubblica o l'organizzazione di pranzi di massa, talora a partire da più antichi rituali di carità pubblica ma nella maggioranza dei casi per pura innovazione: alludiamo qui alle feste dei Mori e Cristiani, de las Fallas, del Carnevale o della Settimana Santa - in tutte si sta verificando una dinamica simile.
E possibile segnalare altri due mutamenti relativi al linguaggio festivo - che assumono una forma meno generalizzata ma rispettano una medesima tendenza omogeneizzante: uno è il processo di addolcimento - si potrebbe dire di 'civilizzazione', nel senso che Elias ha assegnato a questo vocabolo - di quelle manifestazioni che risultano offensive per la sensibilità moderna; l'altro - in contrasto con il precedente - potrebbe essere denominato un 'ludismo promiscuo'. Ci riferiamo con questo termine alla rapida diffusione di festeggiamenti che consistono in combattimenti inoffensivi (ludomachie), nei quali dominano il contatto corporale e la mescolanza confusa e in cui i partecipanti finiscono avvolti o inzuppati dalle sostanze umide, dagli odori o dalle scintille del prodotto utilizzato come arma (si tratti di pomodori, acqua, schiuma, fuoco o polvere da sparo).
Gli attuali programmi di attività, peraltro, sono caratterizzati anche da una diminuzione della presenza quantitativa di atti rituali propriamente detti e da un'espansione dei festeggiamenti, competizioni, giochi e cerimonie. Per questo alcuni autori sostengono che la presenza del rituale nella società moderna sia ormai poco incisivo poiché soffre di uno «spostamento verso posizioni di minor rilievo» (Velasco, 1992), o quantomeno che esso risulti insignificante ai fini del mantenimento dell'integrazione nelle società capitalista (Turner, 1991: 59); in ogni caso è certa la sovrapposizione parziale del rituale con altre categorie di azione collettiva: spettacoli, attrazioni, giochi, cerimonie o festivals. Così Boissevain, nel constatare la diminuzione degli aspetti formali e organizzati dal rituale religioso dinanzi all'incremento degli aspetti ludici (mascherate, teatro, musica, fuochi d'artificio e altre manifestazioni spontanee e disordinate di strada) interpreta il rituale ed il gioco come dimensioni polari costitutive di ogni celebrazione (Boissevain, 1992: 139-140).
È un dato, tuttavia, che può essere interpretato anche da una prospettiva semantica relativa al contenuto della festa - cioè all'oggetto celebrato - come ulteriore indicatore della tendenza secolarizzatrice che opera in essa e che comporta una sostituzione della preminenza della riflessività (o autoreferenza) a quella della transitività. Parlando di secolarizzazione non facciamo riferimento a uno sradicamento delle celebrazioni religiose4 ma soltanto alla loro segregazione culturale, alla pluralizzazione dei mondi vitali, a una marginalizzazione dei significati addotti dalla istituzione ecclesiastica (non necessariamente però dei rituali che questa istituzione presiede) e dunque a un'inevitabile selezione individuale sul tipo e grado di partecipazione e coinvolgimento nella festa. La trascendenza pertanto non viene scartata a beneficio di una incondizionalità immanente, ma adesso viene piuttosto attribuita alla comunità immaginaria del "noi" locale o etnico: finché esprime questo condizionamento, la festa non perde sacralità pur trasformando contenuto e forme di celebrazione.
Infine, i mutamenti relativi al soggetto celebrante. Alcuni storici hanno denunciato la tendenza delle teorie sociologiche della modernità a enfatizzare il carattere omogeneo delle comunità "tradizionali" o preindustriali5. È vero che un certo pluralismo e frammentazione sono costitutivi di qualsiasi società, e che i dualismi coniati dalla teoria sociologica del tipo Gemeinschaft-Gesellschaft sono soltanto mere astrazioni - 'tipi ideali', coniati col proposito di meglio fissare delle tendenze. Ma sfumando queste opposizioni, possiamo sostenere che il soggetto celebrante della festa nella modernità avanzata sperimenta una trasformazione radicale e ambivalente: da un lato infatti c'è una crescente individualizzazione della forma in cui si viene implicati nell'evento festivo, e una perdita di definizione dei soggetti collettivi; dall'altro invece c'è una proliferazione associativa specializzata. In realtà, ambedue questi tratti sono connessi e si implicano mutuamente.
Nelle società premoderne in cui le relazioni sociali sono determinate dal luogo, la comunità locale costituisce un sistema ben delimitato, perché esiste una scarsa mobilità e un relativo isolamento. In contrasto con questi modelli societari, gli ambienti moderni favoriscono e vivono della mobilità continua; in essi il soggetto è spinto a scelte costanti, costruendo la propria identità come progetto derivante da riflessione (Giddens, 1994 e 1995). Il che vuoi dire che la comunità locale oggi esiste come soggetto circoscritto della festa su un piano politico fin quanto vi sia un potere rappresentativo e responsabile) e sul piano dell'immaginario (in quanto nelle menti dei partecipanti esista una qualche idea di comunione). In realtà ciascun individuo decide la propria forma di inserimento e il proprio grado di implicazione, ma il "pubblico" della festa - attori e spettatori - è dato tanto dagli abitanti locali, quanto dai pendolari e dai visitatori in situ (questi ultimi, forestieri in misure diverse) che possono "sintonizzare" la festa grazie ai mezzi di comunicazione. Essendo l'individuo moderno obbligato a scegliere, assistiamo alla creazione di forme nuove di aggregazione, che possono variare dall'aggregazione casuale di spettatori passando per le reti sociali più o meno informali e gli stili di vita, sino alle associazioni volontarie specializzate. Tutte queste modalità aggregative possono esser comprese soltanto a partire dalla elettività/opzionalità costitutiva della vita moderna. Prendiamone brevemente in esame tre.
In primo luogo, nella maggior parte delle feste moderne si è soliti contare su associazioni specifiche che agiscono come istituzioni per la organizzazione degli eventi e come centri di socializzazione per favorire la partecipazione: esse sono dunque il soggetto primario della festività. Una volta costituitesi e affermatesi tendono a organizzare attività lungo tutto il ciclo dell'anno, giungendo a colonizzare persino i momenti più significativi del calendario festivo tradizionale. In una società nella quale domina la differenziazione funzionale, esse operano da agenti specializzati in uno specifico campo di azione - la festa - anch'esso specializzato.
In secondo luogo, la centralità dell'esperienza filtrata dai media - fenomeno radicalmente moderno - costituisce un poderoso fattore di creazione di soggetti celebranti. È proprio per questo che possiamo parlare di soggetti (e comunità) "mediatici", riferendoci principalmente non tanto allo spettatore che in modo casuale e imprevisto vede nel proprio televisore le immagini seduttive di un rituale che non conosceva, quanto piuttosto a quei segmenti di audience che selezionano volontariamente la ricezione di programmi di feste e che lo fanno per provare una commozione sostitutiva sperimentando una comunione immaginaria con feste che acquisiscono così significato universale o almeno divengono rappresentative di un'etnia.
In terzo luogo, infine, l'esplosione delle politiche identitarie e la conseguente costituzione di determinate forme dì soggettività agiscono come una forza innovatrice della ritualità. Più in particolare, menzioneremo due pratiche in cui l'importanza dell'età è segno distintivo dell'identità soggettiva e collettiva: le celebrazioni di compleanni nel corso dell'infanzia - che prendono il posto degli onomastici - e le feste di pensionamento o di persone anziane - con gli omaggi ai centenari ed alle centenarie che ne derivano. Questi festeggiamenti si sono diffusi con rapidità, favoriti nel primo caso dalle scuole e dalle stesse famiglie, nel secondo dalle associazioni di anziani e dalle municipalità.
La festa manipolata, l'esperienza sequestrata
Trasformata, riciclata, alterata, l'esperienza festiva continua ad essere possibile nella modernità avanzata. Anche se si discute su come interpretare le condizioni in cui versa: conserva ancora la propria "autenticità" oppure - rinchiusa nell'universo del privato e trasformata in un mero prodotto di consumo o in spettacolo banale - vizia il proprio senso "originario" e diviene mero simulacro? E ancora, la rivitalizzazione non consisterà in una semplice folklorizzazione, programmata politicamente? In che misura la gestione culturale, commerciale e politica e la mediatizzazione dei media (ci si conceda la ridondanza) travisano i suoi significati e funzioni?
Se le feste finiranno per tradurre soltanto le ideologie del denaro e del potere di multinazionali, se l'impersonale soppianterà il dialettale, se la abilità personale sarà supplita completamente da quella degli specialisti, se la eteronomia apparirà una caratteristica inelutlabile, se la sofisticazione prenderà il posto dell'autenticità allora non vi sarà più se non un simulacro di festa, e certamente non vi sarà anche più se non un simulacro di paese: uno spettacolo doppiamente triste (Gómez, 1990: 62).
Il testo che precede riflette i timori, le riserve e anche le critiche con cui alcuni guardano alle manifestazioni della festa contemporanea. I saggi pubblicati in questo volume difficilmente avrebbero potuto evitare di affrontare questa polemica: Javier Escalera ha così proposto il concetto di "anti-festa" per riferirsi alle celebrazioni programmate politicamente e commercialmente come pseudo-feste popolari, e anche Arnaldo Nesti ha parlato della ritualità in serie o della sua standardizzazione, del festivo travolto dallo spettacolare; Salvador Giner ha insistito sul tema della distruzione (perdita della virtù e obliterazione) della festa tradizionale, della disneylandizzazione del mondo e della fabbricazione corporativa del carisma; Enrique Gil Calvo utilizza l'espressione "festa disciolta" per riferirsi alla progressiva decontestualizzazione locale e alla creazione di una sceneggiatura di tipo audiovisivo; Honorio Velasco infine decreta l'impossibilità della "festa di tutti".
Poiché la tematica è inesauribile, la polemica continuerà a lungo. E naturalmente non e necessario concedere nessun privilegio al carnevale e alla trasgressione dell'ordine nella definizione della festa per intuire che se in essa si esprimono questioni esistenziali, la modernità la danneggia radicalmente in quanto, come sostiene Giddens, «la sicurezza ontologica che la modernità ha raggiunto sul piano delle pratiche quotidiane presuppone l'esclusione istituzionale dalla vita sociale di problemi esistenziali fondamentali che pongono agli esseri umani dilemmi di grandissima importanza» (Giddens, 1995: 199). Ma questa violenta sottrazione delle esperienze esistenziali non dev'essere mai un destino ineluttabile. Se nelle cosiddette "politiche della vita" possiamo scovare tentativi per uscire dalle paludi nelle quali siamo immersi, perché mai non dovremmo pensare altrettanto di alcune tra le attuali esperienze festive? È precisamente questa possibilità che intendiamo evocare con l'espressione L’utopia di Dioniso'. il ritorno della vita, dell'esistenziale come tensione stimolante, in un tempo di amari disincanti e minacciose incertezze.
NOTE
1 [In italiano nel testo, N.d.T.].
2 Abbiamo scelto questi due studi esclusivamente in virtù del loro carattere specifico di tesi di dottorato, ma ve ne sono molti altri che illustrano anch'essi quanto andiamo affermando. Si veda ad esempio lo studio della festa nella cultura mineraria di Homobono, 1994.
3 Questo progetto è stato configurato inizialmente in Arino (a cura di), 1995, Calendarì General de Festes de la Comunitat Valenciana: 1.Festes de Estiu, Valencia: Generalitat Valenciana. In questo quadro di rinnovamento della ricerca e dello studio della festa deve anche esser situato il seminario La Utopia de Dionìsos, svoltosi nella sede di Valencia della UIMP e coordinato da A. Arino e Ph. Pialoux, da cui, con modifiche e approfondimenti, ha preso spunto la realizzazione di questo libro. L'intento del seminario era di riunire specialisti francesi, italiani e spagnoli provenienti da diverse aree e ambiti disciplinari per realizzare uno scambio tra le loro analisi e riflessioni, valutare lo stato della ricerca sul tema, render possibile la cristallizzazione delle problematiche emergenti e segnalare nuovi campi di ricerca e nuove sfide da affrontare.
4 Abbiamo tentato di precisare gli usi generali del concetto di secolarizzazione in Anay, G. - Arino, A. 1995, "Transformaciones culturales de la modernidad", in Garcia Ferrando, M. (a cura di), Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de Sociologia, Valencia: Tìrant lo Blanch: 235-259.
5 Stedman Jones afferma al riguardo: "lo storico dovrebbe astenersi dal chiamare 'tradizionale' la storia che non conosce" (1989: 80-81).
La festa religiosa nell'Europa meridionale contemporanea. Qualche riflessione per la definizione del suo statuto teorico
Francesco Faeta
Al culmine di una complessa stagione nazionale di misconoscimento, nel 1977, Furio Jesi, con quella che sembra quasi anticipare sensibilità postmoderna, in un saggio colto e brillante, pur se di debole impianto antropologico, affronta il tema dell'inconoscibilità della festa. ''Inconoscibilità della festa”, scrive lo studioso nella sua introduzione, "è porre in luce come un filone tradizionale, composito ma riconducibile ad alcuni elementi di fondo, delle cosiddette scienze umane vincolate alla cultura borghese, risulti incapace di giungere ad una conoscibilità della festa che non sia soltanto il riconoscimento dell'inconoscibilità della festa stessa" (Jesi. 1977, p. 2).
L'affermazione di Jesi sembra una sorta di epitaffio che liquida, o pretende di liquidare, una lunga e contraddittoria stagione d'interesse delle scienze sociali e, per quel che più da vicino ci riguarda, della demologia e dell'antropologia italiane. Ma, dal punto di vista propriamente disciplinare, quali sono le radici dell'inconoscibilità che Jesi denuncia? O, più puntualmente, perché malgrado i numerosi studi italiani sulla festa (e, in particolare, sulla festa religiosa), questa è rimasta un oggetto relativamente incognito, e relativamente sterile, sul piano delle conoscenze antropologiche generali?
Se prendiamo in considerazione, in realtà, il periodo che inizia subito dopo la seconda guerra mondiale e si spinge sino alla fine degli anni Settanta, periodo di fondazione o rifondazione degli studi antropologici italiani, è evidente un diffuso interesse per il tema festivo. Un demologo come Paolo Toschi aveva dedicato, nel suo monumentale studio sulle origini del teatro italiano, tale attenzione agli aspetti rituali e festivi da far storcere la bocca agli storici e ai filologi ancorati all'autorialità, alla testualità e alla forma teatrale (Toschi. 1955, poi 1976). Ernesto de Martino aveva riservato interesse quasi esclusivo al cerimoniale e al rituale e, quanto meno, nella rapida ma corposa incursione sul sagrato della chiesa dei santi Pietro e Paolo di Galatina, era entrato nel vivo della macchina festiva, evidenziandone un tratto, quello terapeutico e salvifico, rilevante (de Martino, 1961, in particolare p. 105 e sgg.). Sulla scia delle sue ricerche, Diego Carpitella aveva esplorato gli universi sonori connessi con i riti e le feste, particolarmente lucani e pugliesi. Vittorio Lanternari aveva lavorato ad una corposa monografia relativa alla festa delle feste, il Capodanno, pur se il suo interesse era volto verso popolazioni lontane dall'Italia e dall'Europa (Lanternari, 1959, poi 1976). Annabella Rossi si era occupata precipuamente di feste, più in particolare dei pellegrinaggi dei più poveri tra i poveri del Mezzogiorno continentale e, in collaborazione con Roberto De Simone, del Carnevale in area campana (Rossi, 1969, Rossi e De Simone, 1977). Clara Gallini aveva prodotto una monografia sui novenari sardi (Gallini, 1971), risultato della più interessante specifica esperienza di terreno condotta da noi (più avanti articolerò meglio, motivandolo, tale mio giudizio). Pur non traducendosi in compiute ed estese monografie, poi, numerosi studi su specifici ambiti festivi, con una feconda e originale comparazione tra materiali demologici e rilievi di terreno, erano stati avviati da Antonino Buttitta, Alfonso Di Nola, Luigi M. Lombardi Satriani, Tullio Tentori e, per quel che concerne la mia generazione, negli anni Settanta nascente (agli studi), tra altri, da Lello Mazzacane, Paolo Apolito e me stesso. Numerosi studiosi italiani insomma, dedicavano alla fenomenologia festiva attenzione, mentre iniziative di riflessione teorica e metodologica venivano portate avanti, a esempio, nel convegno di Montecatini Terme del 1978 (Bianco e Del Ninno, 1981). Ancora offrivano contributi di rilevante valore critico Valerio Valeri (Valeri, 1977, 1979 e 1981) o, poco più tardi rispetto al termine degli anni Settanta, Gian Luigi Bravo (Bravo, 1984).
Cosa mi induce, dunque, a parlare di relativa sterilità o ad affermare che la riflessione di Jesi giunge al culmine di una stagione di misconoscimento del fenomeno festivo?
Mi autorizza il modo in cui la festa, nei nostri studi, era affrontata, un modo che per certi versi si prolunga ben oltre il trentennio che in maniera più ravvicinata considero. Misconoscimento e sterilità non promanano, insomma, dalla disattenzione al tema specifico o dallo scarso rilievo degli studi prodotti (quasi tutto ciò che ho prima ricordato mi appare ancora, malgrado il tempo trascorso, di notevole spessore). Promanano, invece, dal taglio particolare che gli studi, nella loro indubbia reciproca diversità, hanno avuto; un taglio che non appare particolarmente adatto ad assumere la fondamentale valenza rischiaratrice del meccanismo sociale, nel suo complesso, propria della festa.
Certamente, in questa prospettiva, un'importanza notevole assume la debole e rapsodica pratica etnografica che è, di solito, dietro le opere italiane sull'argomento: in genere i rilievi sono relativi al giorno o ai giorni della ricorrenza, e non si estendono alle molteplici declinazioni degli apparati mi-tologico-rituali, al sistema festivo nel suo complesso e alle sue interconnessioni, alle stratificazioni dei dispositivi simbolici che operano sulla scena, alle forze sociali che si confrontano, e così via. Certe volte le communitates rituali o festive (per ricordare Victor Turner) sono viste esclusivamente nel momento parossistico (per ricordare Claude Levi-Strauss) della loro azione e l'indagine sull'universo festivo si risolve in un'indagine sulla forma festiva, quale appare nell'attimo epifanico dell'incontro con lo studioso.
Ma è, in particolare, sull'assenza della dimensione comunitaria negli studi relativi alla festa che occorre soffermarsi.
L'ho più volte scritto negli ultimi anni (Faeta, 2002, pp. 70-94; 2003), la nuova antropologia italiana, quale si rifonda nel secondo dopoguerra, non conosce la comunità e non pratica gli studi a essa relativi. E’ una scelta, buona o cattiva che sia, che discende, a mio avviso, dalla naturale linea di sviluppo delle radici demologiche e storico-culturali degli studi italiani. Non occorre, in questa circostanza, ritornare su tale questione. Qui giova notare che, disancorati dalla dimensione comunitaria, l'osservazione e lo studio della festa s'incanalano in un orizzonte particolare. La festa diviene fenomeno eminentemente culturale (segnale, di volta in volta, di una divaricazione di tipo storico-religioso, operante su vasta scala; di dislivelli di cultura e di potere d'acquisto; di una condizione d'oppressione sociale, di narcotizzazione e di rivalsa simbolica; di una differente semiotizzazione dei fenomeni culturali che le sono sottesi; di processi acculturativi e di dinamiche etnocide; della persistenza, in contesti sociali mutati, della "tradizione"). E, proprio a causa del carattere eminentemente culturale dell'approccio (che taglia via, lo si sarà notato, il processo di riflessione di tipo sociale che da Emile Durkheim in poi, passando per Van Gennep, Evans-Pritchard, Lévi-Strauss, Gluckman, Turner. l'antropologia ha condotto), la festa subisce derive teoriche di tipo ideologico, normativo, totalizzante. E per via di questo taglio, della mancata adesione alla linea di riflessione sociale, radicata in concreti laboratori d'analisi, dell'antropologia italiana che, da un lato, ci si può interrogare su cosa sia, in assoluto, la festa (mentre è trasparente come le feste costituiscano agglomerato di idee, pratiche, comportamenti distinti e diversi e come, in analogia con la nozione di parentela, la nozione di festa mal contenga, al riparo della sua rassicurante etichetta, realtà antropologiche difformi); che, dall'altro, si snocciolano, via via, le idee di festa pre-cristiana, di festa agraria, di festa mediterranea, di festa tradizionale, di festa inventata, di festa turistica, di festa come mero emblema identitario, di festa come luogo di moratoria sociale, di festa come palcoscenico idillico, che hanno animato, e animano ancora, tanta parte dei nostri studi.
Il tutto su di uno sfondo a forte predominanza rurale e contadina, una predominanza, ancora risultato di un approccio di tipo culturalistico, avallata ed enfatizzata, comunque, dai quadri ideologici del riformismo marxista. Quadri ideologici che, è persino superfluo ricordarlo, ebbero nel nostro Paese, negli anni che stiamo considerando, duratura e profonda influenza.
Un'attenzione alla connessione festa-comunità avrebbe reso evidente, da un lato, la mutevolezza fenomenologica e strutturale della festa, dall'altro, la complessità sociale del paese e della piccola città periferica (penso, in particolar modo al Mezzogiorno, che meglio conosco), l'articolazione di classe e di fazione, la compresenza sul palcoscenico di molte forze sociali diverse dai contadini poveri e dai braccianti (protagonisti indiscussi dell'attenzione antropologica e progressista italiane, lo ribadisco, con un tratto marcato che non esiterei a definire, con un certo grado di adesione teorica al modello proposto con la nozione di orientalismo da Edward Said - Said, 1995 -, ruralistico).
Ho prima promesso che avrei meglio motivato, all'interno del quadro critico qui delineato, il mio apprezzamento per lo studio sardo di Gallini. Frutto di una pratica etnografica piuttosto estesa e complessa, esso è, in realtà, il primo studio italiano che tenta di porre in relazione la realtà festiva con il suo background comunitario (cinque novenari, lo si ricorderà, cinque paesi). E, nel far ciò, ancora la dimensione epifenomenica (pur se epifanica) dell'evento festivo a dinamiche sociali durature e profonde.
Ma occorre, a questo punto, affinchè possa meglio chiarire la mia proposta di riflessione critica intorno alla festa religiosa europea, affrontare brevemente il nodo comunitario intorno a cui sto girando.
Propongo innanzitutto di sostituire il termine comunità (che ho sin ora usato in conformità alla terminologia dell'epoca), un termine comunque su cui già allora, con concreto riferimento al Mezzogiorno italiano, ci si interrogava perplessi1, con quello di località. La comunità presuppone, in effetti, una lettura olistica e autoreferenziale dei luoghi che, com'è noto, i luoghi spesso non hanno, o non hanno coscienza di avere. La località, invece, che non è mai una realtà essente ma il frutto di un diuturno processo di costruzione, è un movimento di aggregazione, in risposta alla complessa estraneità del mondo; un luogo al cui interno si riconosce, in ottica solidaristica e/o antagonistica, la legittimità di un processo di edificazione e mantenimento dei confini, di costruzione di norme comuni e di un ethos collettivo, di un'intimità culturale (Herzfeld, 2003), al fine di sottrarsi all'indifferenziata datità globale e di fondare pratiche sociali di tipo egemonico e gerarchico. Si sarà ben compreso il debito appaduriano (Appadurai, 2001) di questa mia definizione, così come pure gli ampi margini di libertà che mi sono concesso (basti pensare al mio scivolare volentieri sulla distinzione tra località e vicinato, cripto-idealistica a mio avviso, operata dallo studioso).
Nell'ottica testé ricordata, la realtà locale è culturalmente e socialmente composita e giustapposta e ospita, al suo interno, anche (ma non soltanto) quegli strati e quelle formazioni che siamo soliti definire, con margini di approssimazione sempre crescenti, popolari e contadini. La località, dunque, non è sede privilegiata ed esclusiva delle forme folkloriche di vita e pensiero, come spesso è invalso nei nostri studi che hanno visto una dicotomica contrapposizione egemone-subalterno, centro-periferia, città-comunità contadina (occorre dire, a margine del nostro discorso che proprio dalla meccanica identificazione tra dimensione locale e folklore [assai marcata negli anni Cinquanta-Ottanta], ha avuto origine la risposta locale in termini di messa in scena culturale della propria diversità [anni Ottanta-Duemila], che è fenomeno tutt'ora in atto. Una messa in scena, operata all'insegna di rivendicazioni identitarie, contro la schiacciante realtà globale, che ha il merito di segnalare come tra studiosi di antropologia e nativi delle diverse località si sia verificata una curiosa convergenza, culturalisticamente orientata, che occulta o mette in mora i reali meccanismi sociali).
Con perfetta coincidenza con Appadurai, questa volta, la località va prodotta e mantenuta. Essa, ricorda lo studioso, "è una conquista sociale sempre in pericolo in quanto intrinsecamente fragile [...] e necessita di un'attenta manutenzione che la protegga da una serie di pericoli" (Appadurai, 2001, p. 232).
La località è, dunque, realtà interclassisticamente composita e faziosamente articolata, ed è terminale, più o meno organico (in senso gramsciano), di sistemi più estesi di tipo comprensoriale, regionale, nazionale, sopranazionale. La località è teatro di una permanente conflittualità sociale, tesa a detenere le chiavi del terminale e ad amministrare i flussi di risorse da e per il centro; la località è, con Pierre Bourdieu (Bourdieu. 1983 e 2003), il campo di interazione formale tra attori sociali coalizzati in gruppi più o meno estesi e articolati che si candidano, implicitamente o esplicitamente, quali amministratori.
La località è, ancora, il luogo di concreto coagulo delle istanze, dei bisogni e degli umori di un aggregato nazionale ed è il contro altare, territorialmente centrato, di quell'istanza diffusa e sfuggente che è lo Stato moderno. Studi interessanti hanno avuto il merito, in tempi recenti, di chiarire i nessi di coincidenza e opposizione che legano, in modo assai complesso, realtà locale, nazionalismo e statalismo e di evidenziare come, di volta in volta, la località ripeta o contraddica la nazione pur se in una costante ottica di complementarità (Faubion, 1993, Handler, 1988, Herzfeld, 2003, Palumbo, 2003, ad esempio). Assai minor attenzione rispetto all'argomento si è avuta nel (e sul) nostro Paese, al fine di comprendere le peculiarità nazionali, all'interno di un sistema contraddistinto da un debolissimo senso dello Stato, da una pressappoco inesistente coscienza nazionale, da radicati localismi e da estese consapevolezze civiche, da parte delle masse. Ma, soprattutto, da simmetrici sentimenti e atteggiamenti promananti dal livello istituzionale. Un Paese, insomma, in cui (al di fuori del periodo fascista) lo Stato non ha mai avuto bisogno di giustificarsi e fondarsi, se non nelle mere pratiche di potere e di organizzazione del capitale, in cui le retoriche nazionalistiche hanno avuto una funzione pleonastica, e le città, i paesi e i villaggi sono state le vere patrie.
Bisogna ricordare inoltre che, mentre il centro (la grande città, la metropoli, la capitale, anch'esse località, ma di tipo particolare, che ai nostri fini espositivi non mette conto definire), è sempre amministrato oggi, in Italia, dalle alte borghesie, la località decentrata o periferica può essere amministrata da quei ceti, quei gruppi, quelle fazioni che sono in grado, di volta in volta, di meglio rappresentare il legame di organicità con il centro (indipendentemente, dunque, dalla loro appartenenza di classe). In questa prospettiva la località può essere sede, espressione compiuta, specchio di un'egemonia popolare. Questo non vuoi dire, però, che i processi di messa in scena della cultura popolare (per ricordare Nestor Canclini - Canclini, 1995) siano agiti soltanto in quelle località che vedono un'egemonia popolare o da quelle forze che alla cultura popolare si richiamano. Assai spesso, al contrario, i processi di folklorizzazione della località sono posti in essere da uno o più gruppi colti, coesi o in conflitto, e costituiscono una delle armi a disposizione per confrontarsi in una logica egemonica. Manipolare forme di cultura popolare, inventare le "tradizioni", riferirsi a un passato mitizzato e reificato; operare affinchè tali manipolazioni e invenzioni si radichino nel vissuto, animino l'immaginario, muovano sentimenti ed emozioni locali appare oggi, nella realtà postmoderna, periferica e marginale, una delle più importanti operazioni possibili ai fini del conseguimento dell'egemonia politica e sociale: e in tale operazione i gruppi che si confrontano per il potere, siano essi colti o popolari, posseggono un raffinato, pur se a volte inconsapevole, know how.
Una realtà sociale complessa, dunque, quella locale italiana e, in particolare, meridionale. Ho già espresso le mie perplessità per la connotazione ruralista dell'antropologia italiana (un conto, naturalmente, è studiare i contadini, un conto è studiare il mondo come se altro non fosse che contadino e come se l'antropologia altro non potesse fare che studiare i contadini). Sulla scorta di una sociologia elementare della realtà contemporanea, la piccola località periferica del Sud conserva certamente al suo interno un ancora avvertibile sostrato rurale e una caratterizzazione contadina, ma si è fortemente modernizzata, urbanizzata, terziarizzata: è a tale entità, dunque, che occorre oggi guardare. E del resto, anche in prospettiva storica, è opportuno ricordare che quando si va a sondare, documenti archivistici alla mano, la consistenza sociale dell'unità locale, la si scopre molto meno contadina di quanto l'abbiano disegnata demologi e antropologi, e percorsa da linee di frattura complesse e articolate.
Dentro il contesto locale (suo strumento di costruzione e mantenimento) sta la festa e, per quel che più da vicino ci riguarda, in particolare, la festa religiosa; per Io meno in quelle aree periferiche dell'Europa meridionale che sto tentando di disegnare per grandi linee, avendo come riferimento le mie esperienze di terreno nella Calabria contemporanea e come termine di comparazione studi, indubbiamente assai diversi tra loro e per orientamento metodologico e per taglio critico, uniti comunque da una marcata sensibilità per i processi di elaborazione simbolica, per la realtà locale e le sue articolazioni sociali e istituzionali.
Senza contesto locale, senza radicamento spaziale e sociale, dunque, la festa è realmente inconoscibile e la sua lettura oscilla tra esercizio classificatorio, astrazione filosofica, metafisica dei sentimenti per approdare poi, esausta, sul solido terreno della rimasticazione neofunzionalista. Non è un caso che le grandi festività nazionali, religiose o laiche che siano, almeno che non si embrichino nelle dinamiche locali (come, a esempio, nel caso della Settimana Santa nel Mezzogiorno italiano, in Castiglia o in Andalusia), restino feste mute, vissute in famiglia o in contesti chiusi specialmente delegati alla loro celebrazione, senza operare sul piano comunitario e senza interagire con il corpo sociale complessivo. Anche quando siano festività nazionali, civili, o inerenti un vastissimo universo cristiano, in altre parole, esse devono localizzarsi affinchè si metta in moto il meccanismo sociale collettivo e. sul piano euristico, se ne possano apprezzare dinamiche e processi.
Quest'ultima affermazione merita un'ulteriore messa a punto. L'attenzione per la dimensione locale che qui propongo non deve far dimenticare, anche per quel che concerne il più specifico scenario festivo, come essa sia terminale, l'ho ricordato prima su di un piano generale, di sistemi ben più estesi. Gli orizzonti mitico-rituali, gli apparati simbolici dell'Europa cristiana, particolarmente di quella cattolica e riformata, sono ovviamente estesissimi e propongono, attraverso agenzie religiose potenti, centralisti-che e capillarmente diffuse, significati e pratiche ampiamente condivisi. Temi quali, a esempio, la configurazione dell'Aldilà, la morte e la resurrezione del Cristo, non soltanto sono diffusi nelle medesime forme canoniche in Spagna come in Francia, in Sicilia come in Piemonte, quanto portano nel vivo delle realtà locali logiche di senso, istituti sociali e pratiche tendenzialmente universalistici. Se si guarda, tuttavia, la festa sul versante di questa generale condivisione, se si punta, a esempio, sul carattere forzosamente unitario del culto, ben poco sarà possibile cogliere dell'effettiva dimensione antropologica dell'evento. Occorre avere attenzione, dunque, alla struttura globale e planetaria del fenomeno religioso, e alle ampie logiche di potere e d'intelligenza politica che vi sono sottese, ma occorre soprattutto affrontare la declinazione locale di temi e istituti estesi. In tempi relativamente recenti, del resto, e pur con molti distinguo e molti prudenti radicamenti nella macro-dimensione, questa esigenza è stata avvertita anche dagli storici. Giovanni Levi, a esempio, tra coloro che hanno mostrato attenzione per la valutazione critica delle istanze locali, scrive: "purché si consideri il modo di incapsulamento nella società complessa la dimensione della comunità è ancora assai utile per verificare le reti di relazione che han caratterizzato la società italiana" (Levi, 1979, p. 729).
Ma vediamo più ravvicinatamente alcuni tratti dell'interazione festa-località. Porterò allo scoperto, in questa fase, l'opposizione cultura-società che, in filigrana, è percepibile in tutto il mio discorso.
A un primo sguardo, avendo come specifico riferimento le aree periferiche del Mezzogiorno italiano, appaiono oggi dominanti gli schemi culturali-stici relativi alla messa in scena della dimensione locale. Questo è il paese della tal festa, ed essa è celebrata al fine di mantenere un'identità culturale minacciata dalla realtà globale, secondo la logica identitaria classica, aggiornata agli scenari della postmodernità, del noi versus mondo. In questa prospettiva la festa appare il luogo privilegiato di manifestazione e affermazione di quella condizione di intimità cultuale, già ricordata, efficacemente descritta sul piano nazionale, per la Grecia moderna, da Michael Herzfeld.
In realtà, scavando più in profondità, s'intravede che dietro tale facciata, al di là di un complesso intreccio di motivazioni variamente modulate, che agiscono sul versante interno ed esterno della località, e che largamente contribuiscono al suo processo di produzione, emerge, viene alla ribalta, la partita di potere che si gioca per l'egemonia locale e, quindi, per il controllo delle risorse di medio termine e dei canali di raccordo locale-globale. La festa è, insomma, in questa prospettiva, uno degli strumenti per la lotta politica e va a costruire il campo d'interazione di attori sociali antagonisti, in competizione per l'egemonia. Una più realistica interpretazione della festa, dunque, deve superare la prospettiva culturalista, quella della mera messa in scena, per attingere a una prospettiva antropologico-sociale (che considera secondari, anche se non irrilevanti, i processi di messa in scena e punta alle interazioni economiche e politiche che sono loro sottesi). Si noti bene, però: quanto ho testé detto non vuoi dire che la messa in scena sia una finzione o un epifenomeno; essa è in relazione assai netta con la costruzione degli ordini sociali locali. Malgrado il parere contrario di taluni nostalgici del buon tempo antico, non viene mai mostrato al mondo un guscio vuoto e il processo di rappresentazione culturale della località avviene contestualmente con quello di creazione sociale degli ordini e delle gerarchie interne. Direi anzi che il primo giustifica l'altro e viceversa.
In questa seconda prospettiva, un valore ermeneutico decisivo gioca la definizione del frame significativo (nel senso batesoniano del termine - Bateson, 1988) della festa, degli attori sociali che devono istituzionalmente garantire tale frame, al fine di consentire il dispiegamento delle tensioni conflittuali, delle spinte egemoniche, delle attività di mediazione (senza le quali, la località cesserebbe di esistere, erosa dalle sue interne contraddizioni). È proprio tale frame anzi, la sua permanente possibilità di essere modulato, che garantisce alla festa la sua centralità come strumento politico. In via d'ipotesi l’attività di creazione e mantenimento di questo frame può ancora essere ascritta al livello culturale.
Ma tutti gli elementi rituali messi in scena, e che agiscono sul piano normativo e sociale e si dispiegano compiutamente nel contesto festivo, possiedono una loro densità simbolica che, quanto è maggiore, quanto più assicura l'ampiezza e la complessità del gioco sociale. Dunque, la complessità della realtà sociale locale è tanto maggiore quanto maggiore è il dispiegamento di elementi di chiara impronta culturale, quali sono quelli simbolici. Nel gioco sociale, insomma, si manipolano elementi culturali; e quanto più lo spessore di tali elementi è ampio, tanto maggiore sarà la prospettiva del gioco stesso e delle attività di manipolazione e mediazione. Così, l'analisi etnografica e antropologica, per sortire il suo effetto, deve nuovamente attingere al livello simbolico e alla sua complessa formazione storica.
Una conferma assai pregante, in questa direzione, mi sembra venire dalla vetustà della festa. Perché, nei contesti locali, si gioca pesantemente la carta dell'antichità della festa? Perché, d'altro canto, effettivamente, una festa "antica" sembra assolvere più efficacemente il suo ruolo nella costruzione e nel mantenimento della località?
Perché l'allargamento dello spessore temporale della festa significa ampliamento della sua densità e stratificazione simbolica, e questo consente maggiori possibilità di gioco e un più ampio numero di giocatori. Perchè, inoltre, chi si aggiudica le chiavi della profondità temporale e della sua plasmazione, acquisisce inedite possibilità di manipolazione del frame festivo, conseguendo un vantaggio considerevole sui suoi avversari e, per così dire, possedendo un'arma in più. Vi è, insomma, una relazione di continuità e funzionalità assai marcata tra manipolazioni del tempo, strategie simboliche e politiche locali.
Un solo concreto e brevissimo esempio in proposito vorrei fare, tratto dal terreno in cui sono, ormai da molti anni, impegnato.
A Nocera Torinese, nel versante tirrenico della Calabria centrale, nell'ultimo giorno di Quaresima, all'interno e all'intorno di una solenne processione funebre, si celebra un cruento rito di flagellazione che, oltre a essere emblema identitario, serve a costruire, attraverso l'offerta simbolica del sangue a parenti e amici, reti di potere tra officianti, che agiscono sul piano sociale e determinano processi d'ascesa e di egemonia politica.
Bene, il rito di flagellazione in questione viene accreditato, da parte di molti tra i nativi, di un'origine medioevale: esso sarebbe diretta, e ininterrotta, emanazione dei movimenti di disciplinati dell'Italia centrale che presero avvio nel 1260 ed ebbero, com'è noto, influenza decisiva sullo sviluppo del teatro religioso, della poesia, della stessa lingua italiana. Occorre precisare che, in realtà, le grandi devozioni medioevali dell'Italia centrale non ebbero alcun seguito nel Mezzogiorno italiano, anche per una decisa e attenta opera di prevenzione posta in atto, in sintonia con quel generale atteggiamento di ripulsa per il fenomeno che permeò la cultura e il mondo ghibellini, dal re Manfredi, allarmato per il sostrato civico, urbano, campanilistico del movimento, quanto per i suoi tratti millennaristici e catari. I più sensibili alle ragioni della Storia, dunque, anche sulla base dei rilievi di studiosi nativi o provenienti da fuori, datano il rito al tardo Seicento, ancorandolo alle devozioni controriformate, sviluppatesi in ossequio alla logica an-tiereticale e di neoevangelizzazione dei missionari delle Indias de por acà. Essi ipotizzano, inoltre, una possibile discontinuità temporale delle pratiche di penitenza.
Personalmente ho avuto attendibile riscontro di queste ultime tesi, avendo rinvenuto prime attestazioni archivistiche relative alla flagellazione locale soltanto in documenti del XVII secolo e avendo potuto apprezzare, nell'arco di quattro secoli, momenti di suo splendore e miseria, di sua presenza e assenza.
Al di là delle ragioni della Storia, tuttavia, il confronto tra i due gruppi d'opinione, tra i loro leaders (intellettuali e storici locali, politici di basso e medio livello), tra i concreti attori che calcano il palcoscenico rituale (portantini del gruppo statuario che è al centro della processione e flagellanti, soprattutto) non è meramente erudito, come potrebbe a prima vista sembrare. Perche ancorare il rito al Medioevo significa spendere sul piano locale una serie di contenuti pauperistici, millennaristici, augurali, catartici, mentre accettare e marcare un'ascendenza controriformistica significa porre l'accento sull'intensità della fede personale, sulla macerazione e la mortificazione, sull'ortodossia e sull'accettazione di un'idea gerarchica delle devozioni. Inoltre, un'ininterrotta continuità significa una potenza che sa trasmettersi nel tempo e di generazione in generazione, mentre l'idea di interruzione postula la capacità di ricreare istituti e forme ex novo. Due modelli diversi del credere, del patire, del celebrare, insomma, due differenti regimi di discorso. E, quel che può apparire paradossale è che oggi - non mi sembra, però, sulla scorta dei documenti in mio possesso, che le cose siano andate sempre così - la fazione più trasparentemente inventiva, quella dunque meno relata al piano di una effettiva valutazione evenemenziale, appare propensa a spendere sulla scena locale valori connotati dal punto di vista progressivo e della solidarietà sociale, mentre gli altri si fanno portatori di istanze indubbiamente più arretrate e individualiste. I primi, tuttavia, appaiono anche come tradizionalisti, rispetto alle forme rituali e festive, mentre i secondi mostrano una più aperta disponibilità rispetto al loro mutamento e alla loro evoluzione. Alle due durate del tempo storico della flagellazione, ai due quadri ideologici, ai due orizzonti simbolici del rito e della festa corrispondono, insomma, strategie di manipolazione politica difformi e, per molti aspetti, antagoniste. Ma è l'esistenza stessa di uno spessore temporale da poter manipolare, da poter tirare come la classica coperta troppo stretta, insomma, che in ultima istanza garantisce la possibilità stessa del gioco e dei giocatori.
Le considerazioni intorno alla vetustà della festa ci guidano ravvicinatamene a comprendere che se assumiamo i criteri di sua lettura che ho prima riassunto appare del tutto improbabile la nozione di tradizionalità (con i suoi ambigui corollari di riproposizione, riproposta, reinvenzione, etc., nel nostro ambito di studi così in voga).
Una festa non è mai tradizionale. Non lo è al giorno d'oggi, in cui essa ha assunto la centralità nei processi di manutenzione della località che abbiamo visto, ma non lo è stata nel tempo passato, come le prospezioni degli storici (o come i rilievi archivistici) ci consentono di comprendere con chiarezza. Basterà evocare, qui, il carnevale di Romans (Le Koy Ladurie, 1981). O pensare, per la regione che io studio, a esempio, ai tumulti festivi dello Spinetto di Serra San Bruno (in provincia di Vibo Valentia), negli anni Trenta e, poi, Sessanta dell'Ottocento, documentati negli atti processuali presenti presso l'Archivio di Stato di Catanzaro: qui le dialettiche festive, imperniate sulla contrapposizione violenta di vicinati diversi, su una guerra di santi e di simulacri, si evolvono in chiave politica, innervandosi cruentamente, anche in vista dell'arrivo di Garibaldi, nel conflitto tra Napoletani e Italiani.
Una festa presenta certamente al suo interno elementi consuetudinari ed elementi che promanano dalla tradizione canonica (ecclesiastica o laica che sia), ma è il frutto della interazione politica tra codice rituale, libera interpretazione degli attori festivi, presenza e volontà performativa del contesto locale nel suo complesso, sguardo del mondo, modulazione del frame significativo (per cui medesime azioni possono assumere significati dì volta in volta diversi), come del resto, sia pur in un'ottica critica piuttosto diversa dalla mia, ha efficacemente ricordato, anni or sono, Paolo Apolito (Apolito, 1993).
Nel contesto modulato e flessibile che ho richiamato, una posizione centrale assumono le relazioni intercorrenti tra rito e festa. Anche queste relazioni, tuttavia, non possono a mio avviso essere definite, in modo rassicurante, una volta per tutte. È la declinazione della vicenda locale che suggerisce quali rapporti intercorrono tra i due ambiti. Se Pietro Clemente, a esempio, poteva sostenere, tempo fa, sulla scorta di sue osservazioni di terreno, che il rito definisse ''rapporti rigidamente formali fra officianti e partecipanti e [avesse] finalità simboliche specifiche, [mentre] la festa che lo contorna[va] si presenta[va] come meno rigida e meno finalizzata" (Clemente. 1981, p. 56), nel paese prima evocato, Nocera Tirinese, accade esattamente il contrario. Qui, mentre la festa si svolge con una rigorosa formalizzazione che vede un controllo, esercitato in particolare dal già ricordato gruppo dei portantini, delle norme, delle pratiche e persine dell'ethos, nel rito di flagellazione che la anima sono possibili, all'interno del frame significativo stabilito di anno in anno, una miriade di soluzioni diverse, in un'estrema libertà formale e sostanziale che ha il compito di selezionare, come ho accennato, attraverso la libera scelta e la competizione, un'aristocrazia maschile e di proiettarla verso un processo di ascesa sociale.
La giustapposizione e la contraddizione cultura-società relativa alla festa, per concludere, che la dimensione locale sembra oggi evidenziare, si può parzialmente risolvere, in via d'ipotesi, attraverso un approccio politico. È attraverso un'antropologia politica dei mondi locali, della loro vita materiale, delle relazioni di parentela, delle manifestazioni religiose e rituali, della festa, infine, che i nostri studi possono recuperare una qualche capacità di lettura e decodificazione degli eventi non in una prospettiva angusta, arcaica, conformistica. Da qui, la natura essenzialmente politica degli eventi e dei processi che lo sguardo antropologico accredita, di volta in volta, come culturali o sociali. Del resto, ormai molti anni or sono. Marc Augè mostrava di avere piena consapevolezza del problema quando si chiedeva, parlando del simbolo (e abbiamo visto qual è la sua funzione imprescindibile nell'ambito del contesto festivo): "se ogni linguaggio simbolico non [fosse] necessariamente politico e se ogni antropologia, quali che siano i tipi di realtà che sono al punto di partenza della sua osservazione - fatti religiosi, familiari, economici - non [dovesse] arrivare alla manifestazione dei rapporti di potere, delle modalità della loro messa in opera e del meccanismo di queste modalità" (Augè, 1982, p. 84).
II festivo di cui si parla, il festivo che si vive.
Aspetti del festivo nella cultura contemporanea
Arnaldo Nesti
Il senso della questione
La festa, in senso generale, si presenta come un evento-sintesi di gratuità e di funzionalità-gratuità in quanto implica la sospensione del lavoro, delle regole sociali connesse al vivere quotidiano; funzionalità in quanto il festivo più che un'evasione rappresenta un'interruzione della routine per garantire, per rinnovare il tempo feriale, del lavoro normale. Dovendo affrontare in modo schematico la questione della festa, si potrebbe osservare che i suoi elementi costitutivi sono: a) la presenza di un'esperienza interpersonale, b) la presenza di attività espressive a carattere simbolico-rituale, ludico-cerimoniale, e) la periodicità d) l'eccezionaiità, e) l'emozionalità, f) una funzione socioculturale. Non ritengo di stare a commentarli. Con le trasformazioni socioculturali che si sono avute, con lo sviluppo delle comunicazioni, sotto la pressione dei modelli individualisti dello spreco e della ostentazione, a parere di molti, le forme del festivo stanno perdendo il loro carattere specifico, il festivo addirittura sembra essersi eclissato. Il tempo della festa si sarebbe convertito in oggetto di manipolazione fino al punto da smarrire i propri caratteri specifici risolvendosi in una ritualità seriale, mercificata, standardizzata. Le feste non sarebbero altro che pause, vacanze, periodi durante i quali prevalgono lo spettacolare, il fracasso, l'esteriorizzazione di forme simulacriche subordinate, comunque, al primato del calcolo e di ragioni utilitaristiche. Le vacanze sostituiscono il tempo di festa rendendosi funzionali al primato del processo di accumulazione da una parte e al primato dei consumi dall'altra. Il festivo contemporaneo correlato con la spettacolarizzazione sarebbe ancorato ad un'immagine delle passioni senza passione, e troverebbe una sua perfetta rappresentazione nel catch.
Nel catch, scrive Roland Barthes, non esiste nulla se non in modo totale, non c'è nessun simbolo, nessuna allusione, tutto si da fino all'esaurimento, senza lasciar niente nell'ombra; il gesto elimina tutti i significati analoghi e presenta cerimonialmente al pubblico una pura e completa significazione (R, Barthes, 1962, p. 20).
Le feste dunque manifestazioni dì passioni senza passione, di parole senza senso, di immagini orfane?
Saggio tratto dal volume di A. Arino e L. M. Lombardi Satriani, L’utopia di Dioniso. Festa tra tradizione e modernità, Roma, Meltemi, 1997, pp. 7-21
Posizioni di questo tipo mi sembrano assai limitanti per comprendere l'effettivo mondo della vita festiva in particolare. Che cos'è, dunque, effettivamente il festivo nella società contemporanea? Come deve essere indagato e interpretato nelle società contemporanee? In queste pagine facendo precipuo riferimento al festivo così come si pratica, come si vive e non solo limitandosi ai dati della tradizione o ai tempi meramente indicati come tali dal calendario, in modo particolare nelle aree mediterranee, intendo contribuire alla ricostruzione di una mappa del festivo nei suoi caratteri fondamentali. In queste pagine cercherò di evidenziare, tenendo in considerazione i grandi mutamenti avvenuti, se e come la mappa del festivo indicata dal calendario coincide o meno con quella dell'effettiva esperienza del festivo quale viene vissuto, nei suoi dilemmi, indicando il tipo di relazione che si è andato profilando fra ciò che viene chiamato festivo in base alla logica calendariale e il festivo quale viene effettivamente vìssuto. La questione è sottile e spinosa al tempo stesso. Nella brevità dello spazio che ho a disposizione spero di contribuire, se non altro, a stimolare una ricerca quanto mai suggestiva.
Il festivo del calendario
Una lettura del calendario mette in evidenza l'ampia e articolata disseminazione del tempo festivo all'interno dell'anno. Formalmente insieme al fluire del tempo feriale ce n'é un altro fatto di giorni festivi per ragioni religiose o per ragioni storico-politiche o per ragioni civili. Alcuni hanno valore in tutto il territorio nazionale, altri in un ambito locale più o meno ampio. Nell'area mediterranea dell'Occidente europeo ci sono giorni festivi comuni correlati alla cultura cristiana: le domeniche, le festività riferite ai grandi eventi della fede cristiana, con alcune differenze sulla base delle distinte confessioni e i distinti processi di secolarizzazione. Il calendario si situa in stretta relazione con l'anno liturgico. La domenica o dies dominicus è l'”oggi con cui la Chiesa celebra il Kairòs", ossia, la irruzione del "tempo di Dio nella storia mediante Cristo" il Redentore rifiutando il mito dell'eterno ritorno delle religioni pre-cristiane e tornando ad attualizzare gli eventi fondatori, introducendo nel tempus presenteil tempus illud della salvezza.
Nella recente riforma liturgica della Chiesa cattolica romana, la domenica ha acquisito un valore primordiale proprio mentre sono scomparse feste di molti santi le cui biografìe, sul terreno della critica storica, presentavano molte lacune e lasciavano molto a desiderare.
Si è giunti così a riconsiderare un numero assai alto di famose feste relazionate a manifestazioni popolari: si pensi, per esempio, alla festa di S. Cristoforo, patrono degli automobilisti, di S. Giorgio che ha ereditato la funzione dì un dio solare che sgomina il dragone, di S. Barbara patrona degli artiglieri e dei minatori, di S. Caterina di Alessandria che ha ispirato molti proverbi relazioanati al tempo o alla vita dei campi: 'Per S. Caterina, la neve sulla collina"; "Per S. Caterina, prepara la fascina" ecc.
Nel frattempo si danno feste importanti come quella del 1° maggio relazionata con il ruolo e i diritti del lavoro della grandi masse popolari. In ogni paese c'è un distinto calendario di feste civile.
La rottura delle nette dicotomie che si riferiscono agli status socio-economici del passato, ha alterato le dicotomie connesse all'uso del tempo, ha scolorito le differenti letture dell'esperienza tradizionale dei giorni festivi.
Spesso le feste convenzionali, formali, hanno perso l'intensità e la magia che avevano in altri tempi, hanno subito un processo di disincanto. Altre se ne sono create a partire dalle domande connesse alla nuova soggettività di massa.
La rigidità delle prerogative del calendario formale da tempo si è esaurita, I criteri regolatori del festivo sono diventati molteplici. I soggetti si trovano di fronte agli stimoli di vari calendari che si correlano e si intrecciano fra di loro ed anche con quello formale della tradizione. Nel passato il calendario cristiano tendeva a costituirsi come sintesi del tempo sacro e del tempo profano, del tempo festivo e di quello feriale. Nel frattempo il calendario civile, il calendario zodiacale, il calendario sportivo e quello lavorativo indicano le distinzioni-divisioni sfasate fra di loro durante l'anno. Non c'èun calendario unico, immobile ed esclusivo. È illusorio pensare ad un calendario, tengo a sottolinearlo, che sarebbe espressivo e regolativo del fantomatico villaggio globale.
Èin atto una differenziata attivazione di significati, di eventi nella successione ciclica dei solstizi e degli equinozi, dei mesi e dei giorni, della luce e della oscurità. Le differenze scaturiscono da distinte storie religiose, politiche, economiche e civili. Anche nel bacino mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda il versante delle aree spagnole, francesi, italiane e greche, il ricco calendario festivo, ha subito profonde modificazioni. Feste secolari, talora, hanno conosciuto una decadenza netta. Penso alla festa di Santa Rosalia a Palermo. Altre hanno subito una vera e propria eclisse. Feste come quella di S. Sebastiano e di S. Paolo a Palazzolo Acreide, in Sicilia, con le sue "guerre di Santi" espressione del chiaro dualismo sociale esìstente, hanno smarrito i loro caratteri tipici. Hanno subito un collasso molte feste di quartiere, di parrocchie, di comunità locali. Si pensi a molte feste di aree meridionali, in Italia e in Francia, in seguito ai folti processi di emigrazione che hanno contratto molte popolose comunità. Si pensi inoltre alle feste dedicate a S. Antonio Abate e agli altri santi venerati nel mondo contadino - o meglio - ad un mondo profondamente trasformato in seguito ai rivolgimenti subiti dalla struttura rurale. Nel frattempo ne sono sorte altre. Si è avuto un processo di traslazione festiva nei territori di immigrazione con lo stesso coinvolgimento della popolazione nativa. Altre si sono rafforzate grazie ai mezzi di trasporto e ai mezzi di comunicazione sociale - lo dimostra il grande interesse per le feste in onore della Vergine del Rocio, nelle maremme andaluse: negli ultimi trent’anni, grazie ai mezzi di comunicazione di massa, si è creata una specifica aura intorno alla "Bianca Paloma" del Rocio, con una grande spostamento di masse, come mai era avvenuto prima, per secoli.
Il calendario della vita festiva
Quale dunque il calendario della vita festiva?
Quando si parla di feste si deve tener conto della quantità, della qualità di calendari che hanno a che fare con la vita dei soggetti. Come è noto, l'anno, formalmente, inizia il primo di gennaio con la festa di Capodanno che ha valore legale e termina a mezzanotte del trentuno dicembre, con un giorno dedicato a S. Silvestro. Fino ad alcuni secoli fa la forma dell'anno era diversa, A Firenze fino al 1749 il primo dell'anno era fissato al 25 marzo, giorno dell'Annunciazione; a Milano fino al 1797 il Capodanno era il 25 dicembre. Che il primo giorno dell'anno fosse il primo giorno di gennaio era un dato consolidato già all'inizio dell'Impero romano. Ovidio nei suoi Fasti (I, 63-294) immagina che il primo di gennaio gli appaia il dio Giano e gli spieghi i costumi propri di tale giorno. In tal giorno i romani erano soliti invitare gli amici e scambiarsi un vaso di miele con datteri e fichi secchi "perché, come le cose passano, il sapore e l'anno, tale quale cominciò, fosse dolce". L'accompagnano con degli arboscelli di alloro detti strenae1 come segno augurale.
Di fatto nelle società contemporanee del mediterraneo occidentale il corso dell'anno e di conseguenza il ciclo festivo segue altre dinamiche. La festa del primo dell'anno non è che un segmento festivo all'interno del ciclo festivo natalizio e\o, più in generale, delle feste di "fine e di principio d'anno" che vanno, in genere, dal 25 dicembre, giorno di Natale, fino al 6 gennaio giorno dell'Epifania. In molti casi tale giorno è conosciuto essenzialmente come il giorno della Befana (ad esempio in Italia) o de"Los Reyes Magos" in Spagna. Il primo giorno dell'anno viene dedicato al riposo dopo le "fatiche" della notte di S. Silvestro che ricorda con la sua atmosfera orgiastica, per molti aspetti, i Saturnali romani. Il periodo natalizio rappresenta una pausa ed una sospensione del fluire del tempo nel cuore dell'inverno.
Natale rappresenta, naturalmente, il tempo centrale per la vita spirituale del credente cristiano. Intorno all'evento centrale per la storia della salvezza si snodano pratiche, riti, simboli, immaginali specifici, tradizioni. Con la secolarizzazione il fatto religioso di chiesa resta solo un dato calendariale che viene avvertito, soprattutto, in un'ottica eminentemente individualista, familista, con una forte tendenza alla destoricizzazione cioè alla rimozione di tutto ciò che è l'effettiva dimensione del rapporto sociale. La festa si risolve essenzialmente in una celebrazione all'interno dell'intimità del nucleo familiare, ed implica il rispetto della pratica del dono-regalo. "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". Con il diffuso scambio degli auguri si tende a creare un tempo festivo emotivamente pacificato, completamente diverso rispetto a quello della vita di tutti i giorni. Gesti di spreco e di sregolata prodigalità sono indizi dì un oggettivo atteggiamento sacrificale che permette quasi di sentirsi riscattato rispetto ad un comportamento ordinario fondato sull'individualismo e sul "freddo calcolo dell'ordine reale". Il sacrificio che comporta l'acquisto di regali spesso lussuosi, costosi e superflui si giustifica anche per il fatto dell'eccezionalità del gesto e semel in anno licet insanire,
Non lo si compie per compiacere gli dèi, né per aiutare il prossimo, lo si fa essenzialmente per affermare e salvaguardare la distanza rispetto al tempo della routine quotidiana. Tale Natale appare del tutto estraneo all'evento religioso.
Nell'occidente industrializzato, di fatto, il calendario reale dell'anno comincia ai primi di settembre. Allora si riaprono le fabbriche, inizia l'anno scolastico, i negozi, i locali urbani tornano al loro ritmo ordinario. La stessa vita politica riprende.
L'animazione della vita collettiva giunge al suo punto culmine nel periodo che va fra maggio e giugno, con alcune pause, come quelle invernali del tempo natalizio. I mesi di luglio e di agosto — specialmente agosto — sembrano un tempo extra-annum, quasi come i giorni in cui i pontefici latini toglievano - o ponevano a loro arbitrio - dei tempi vuoti nella cronologia urbana.
Per una mappa del festivo
Quale nome dare al festivo di oggi? "La festosità, scrive K. Kerényi, appartiene, per gli uomini inclusi nella sfera della festa, alle realtà spirituali assolutamente valide. La festosità è una cosa in sé (...) e mentre deve essere distinta dal resto, a sua volta distingue il resto, in modo assoluto".
Kerényi sottolinea con sottigliezza il valore catartico del sentimento festivo affermando che "nella festa si scopre il senso dell'esistenza quotidiana, l'essenza delle cose che circondano l'uomo e delle potenze che operano nella sua vita. Il sentimento di festività in quanto realtà dell'esistenza umana indica che l'umanità è in grado, nelle cesure temporali ritmicamente ricorrenti, di attingere immediatamente alle più elevate realtà sulle quali si appoggia l'intera esistenza" (1940, tr. it. 1951: 43-63).
La festa è il tempo in cui acquista visibilità il moto emozionale creativo che altrimenti resterebbe inavvertito. E’ eminentemente tempo di visibilità e proprio per questo profondamente diverso dalla quotidianità. Ha ben ragione chi coglie le feste come tempi speciali di epifanie, di momenti mitici ricorrenti nella vita collettiva anche una lettura di questo tipo, lascia molto a desiderare quando dissocia il tempo festivo da fattori storico-sociali. L'apporto pur importante di M. Eliade, ad esempio, oblitera la dimensione storica. A suo avviso ogni festa realizzerebbe un volo mistico, una "visione", "un balzo di tigre" nel passato dell'intera collettività protesa a stracciare la linearità del tempo, per liberare nel presente l'eterno ritorno. Nel momento festivo viene individuata l'esperienza fondamentale e decisiva del gruppo che, attraverso di esso, "si destorifica e attinge, grazie al modulo ritualmente vissuto, la realtà ultima primordiale in rapporto alla quale la realtà storica è insignificante e nullificata" (Eliade, 1975). La stessa dicotomia avanzata da M. Bachtin, a parte l'acutezza e la suggestione delle analisi, si fonda su un marcato dualismo aprioristico e idealistico: il festivo carnevalesco sarebbe, come è noto, a suo avviso, impregnato di satira dissacratrice "contro tutto ciò che è superiore"; invece l'ufficiale, l'altra medaglia del festivo convaliderebbe la stabilità, l'immutabilità e l'eternità dell'ordine esistente (Bachtin, 1982). La libertà di violare le regole di comportamento abituale non è sempre associata alla "gioia" festiva: la conflittualità sociale implica un vasto ventaglio di cause. Nella festa nessuna catarsi è attuabile per l'individuo se non entro e in virtù del contesto di socialità comunicativa e partecipativa.
La stessa morfologia non può scaturire esclusivamente da elementi esterni, organizzativi, quantitativi, localistici. Ritengo che si debba ritenere debole la stessa classificazione delle feste in tipologie per cui si danno feste laiche e feste religiose, feste egemoniche e popolari, feste arcaico-tradizionali e feste moderne in senso proprio. Il criterio di classificazione non può limitarsi ad elementi esterni, connessi ad un esclusivo tipo di società, di tempo, di calendario e di mondo della vita. Deve poggiare sulla struttura simbolica, sui comportamenti, sui gesti certamente, ma più ancora sui livelli sottesi delle intenzionalità, nel loro dispiegarsi e nei loro intrecci, dei soggetti che fanno la festa. In altre parole si tratta di fondarsi su ciò che si vede come effetto e\o correlato a ciò che si sente, si vive.
Il festivo, dunque, non può essere affrontato in modo unidimensionale, né semplicemente come una struttura narrativa, per cui dovremmo contentarci di fare un'analisi delle forme senza dar valore ai significati, perché è precisamente a livello dei significati espliciti o latenti che si può afferrare lo specifico o l'analogico. La festa spesso si presenta come mera vacanza se non addirittura come il precipitato arido, individualista, sterile di una grande storia sociale. Molte feste svelano infatti una debole socialità, subalterne come sono ad un grande super-ego.
Comunque il trend della metamorfosi del festivo contemporaneo porta all'avvicinamento, alla dislocazione ed anchealla somiglianzà. Le grandi feste si sono arricchite delle istallazioni urbane: hanno intensificato l'uso dei mass-media, dell' elettronica, della grafica, fondendo momenti attivi collaterali come i suoni, le luci, i fiori, gli striscioni, gli abiti. Regolarità e irregolarità, temporalità e atemporalità si intrecciano ma coesistono, allo stesso tempo, modi di produzione e strutture simboliche nettamente differenziati.
Sono molti i segni di un festivo vissuto come recupero di pratiche che tendono a esplorare il mondo, con una sensibilità in completamente distinta rispetto a quella della convenzionalità.
In migliaia di paesi la festa non è più quella del calendario. Di grande importanza è la tradizionale festa rurale ma sono migliaia le occasioni che inducono a fare festa, a inventare nuove feste soprattutto nel periodo estivo. Moltissime feste private come il compleanno, una festa di laurea, una promozione di carriera, un matrimonio riescono a mettere insieme, a radunare una quantità enorme di persone senza che ci siano fra i partecipanti particolari relazioni di parentela o di rapporto quotidiano. L'uomo della festa altera il tipo di relazione sociale, la precarietà di un dato presente come irreversibile e immodificabile, la istanza di superamento delle barriere dell’ordo mundi convenzionale, razionale e utilitario. I livelli di intensità del festivo variano. Non c'è sempre la festa che si svela nella sua pienezza o comunque nella sua unidimensionalità. Fra le distinte forme, il viaggio appare come quella che consente di entrare in un orizzonte in cui il soggetto trova risposte alle proprie necessità di rapporto simbiotico, in una relazione di fusione con ambienti straordinari rispetto alla routine che, se non ci sono particolari incidenti, diventano immagini di un paradiso perduto. Quali sono gli scenari del senso del festivo che si vive nella modernità? Quali i profili dell'esperienza festiva? Intendo soffermarmi su alcune particolari situazioni che rientrano in talune tipologie.
Variazioni di significato nelle "immagini speculari" di fondazione
Una prima tipologia del festivo è costituita dai casi in cui si da un rapporto labile fra l'icona, o meglio l'immagine speculare di fondazione e le icone, i simboli effettivamente evocati dai soggetti. I simboli, i miti evocati dal calendario festivo rimangono a livello formale, però si adattano a funzioni originariamente impreviste, si combinano con fini completamente estranei. Molte feste del calendario cristiano o di quello contadino hanno smarrito tutta la loro forza evocatrice originaria sia perché è cambiato completamente il paesaggio originario di cui erano espressione sia perché si è verificata una disaffezione, un cambiamento nell'immaginario e nella sensibilità collettiva. Le feste del calendario, a prescindere dalle "immagini speculari di fondazione", mantengono il carattere di tempi di eccesso-permesso sulla base, però, dì un vero e proprio processo di trans-significazione che necessita di essere re-interpretato.
Forte primato dell'evento rispetto alla norma del calendario
C'è un altro tipo di festivo che non presenta uno stretto rapporto col calendario, non implica un mito fondatore precostituito, non comporta la rigida reiterazione legata ad uno spazio temporale. La festa è un evento eccezionale che nasce e si dissolve in un tempo rapido, prende forma in taluni momenti che trasformano un luogo, una città dandole un profilo della "città alla rovescia", suscitando allo stesso tempo un clima di entusiasmo, di diversità, di eccesso legittimato. Si pensi alla situazione di talune città durante taluni spettacoli musicali: che ci sia un cantante come Bob Dylan che invita a vedere la realtà con la sua poesia spietata, visionaria, dentro gli abissi della desolazione metropolitana, in corsa nei viaggi senza meta che la cultura americana ci propone almeno dal tempo di Melville e di Mark Twain, o una cantante come Madonna, poco importa. Se il primo è un menestrello, è riuscito a portare la poesia nel consumo di massa ed appare provocante con le sue canzoni come Time they are changing o Blow in the wind, l'altra sembra rappresentare l'invito a rimanere adolescenti anche oltre i limiti dell'età, con le sue canzoni da "usa e getta". Importante è l'evento, la celebrazione dello stare insieme come tempo singolare. Una festa del genere, dal forte coinvolgimcnto emotivo, si presenta come un tempus novum, uneffettivo Kairòs che consente di trasformare un luogo in un topos dell'incanto rispetto alla diffusa condizione nomadica, di anonimato, di sperimentare il senso-desiderio della propria cittadinanza dentro un auspicato mondo alla rovescia.
Lo stesso successo di talune feste legate ad alcuni partiti politici scaturisce da un trend disviluppo autonomo e distinto dalle alterne vicende politiche, elettorali del partito. Si caratterizzano come singolari situazioni-risposte al bisogno di nuova socialità: si mangia insieme, si ascolta la musica insieme, si presta la propria opera gratuitamente. Il successo di tali feste, in modo particolare, va rintracciato, in quanto risposte pubbliche, alla necessità di insolito, di socialità, di processi di comunicazione intensa, di implicazioni emotive ben al di là della routine privata, permettendo altresì di rafforzare il senso della propria appartenenza.
Lo stesso vale per molte feste sportive. L'euforia della vittoria di importanti gare come nel caso dei campionati del mondo del calcio, travolge intere città e interi paesi ordinariamente tranquilli. Vie e piazze dopo pochi istanti dalla fine della partita vinta dalla propria squadra nazionale, vengono travolte da folle in preda ad una tempesta emotiva. Le persone più diverse appaiono visibilmente commosse; con bandiere, striscioni colorati danno vita ad uno spazio-tempo di allegria, attivando e avvalorando oggetti inutili, privi di valore, facendo ricorso a gesti insoliti come lo strombazzare il clacson, suonare infantili trombette, sporgendosi dalle macchine in modo esagitato, non di rado mettendo a repentaglio la vita.
Il tempo dei campionati fluisce non sotto la spada di Damocle, ma di una specie di barriera corallina; il tempo come un oceano si ferma, al suo interna c'è una calma piatta, una finzione di mare. Dopo, alcuni con strazio e amarezza continuano nella loro routine, altri entrano in uno stato di isteria colossale come se fossero entrati in un tempo di vacanze straordinarie e assai lunghe.
A proposito della festa sportiva in Occidente, va detto che non la si può capire senza correlarla ai processi simbolici che provoca.
L'importanza di una squadra di calcio, ad esempio, non deriva, spesso, dalla peculiarità della sua tecnica calcistica. I migliori giocatori spesso non sono che dei "mercenari" che emigrano da una squadra all'altra sulla base dei loro vantaggi economici. Spesso sono i tifosi che svolgono la funzione di dimostrare la superiorità della loro squadra. Lo stadio diventa il luogo in cui masse di uomini e di donne non partecipano solo ad una partita sportiva come se trascorressero una parentesi di novanta minuti; la partita è come un sogno collettivo in cui si reinventano e si ricostruiscono il loro mondo. La vittoria in un campionato di calcio della propria squadra, non di rado provoca una situazione di scatenamento di passioni all'interno della città fra l'esplosione di fuochi pirotenici e l'agitazione di bandiere, quasi fosse divenuta la terra dei redenti e la patria degli eroi.
Anche città note per le loro forti divisioni interne si trasformano in comunità dalla forte effervescenza collettiva. Al presente sportivo si correlano liberamente elementi storici del passato contribuendo all'amalgama della coscienza collettiva; il tempo della celebrazione tende a fondere e a reinventare passato-presente in un qui-ora, senza fine.
La forza della tradizione
Molteplice è il riferimento alla tradizione. In taluni casi il festivo tradizionale conserva intatta la forza e la vigenza originaria. «Il solitario messicano ama le feste e le riunioni pubbliche. Tutto è occasione per riunirsi. Qualunque pretesto è buono per interrompere la marcia del tempo e celebrare con festeggiamenti e cerimonie uomini e avvenimenti. Siamo un popolo rituale». Per Ottavio Paz il messicano utilizza la festa per liberarsi dalla miseria e dalle angustie che ha nel presente e che ritrova nel passato.
Il calendario del Messico contemporaneo è contrassegnato dal calendario tradizionale, da quello sincretico nabuatl-cattolico. Come il carnevale in Brasile, la festa dei morti che i messicani celebrano presenta tipici connotati, effetto della coniugazione di riti aztechi e di riti cattolici: a distanza di secoli questo giorno rende la morte una compagna delle più divertenti, facendo sfilare nelle strade e ritrovarsi nei cimiteri milioni di indiani e di meticci. Gli altari e le offerte fatte ai morti costituiscono il centro della festa e si moltiplicano nelle case messicane, come da noi l'abete di Natale. Per i messicani le offerte di cibo e dei doni hanno il potere dì fare ritornare le anime dei morti. Gli altari sono costruiti secondo le tradizioni di ciascuna regione fin dal 28 di ottobre, e restano fino al 6 di novembre. In genere tuttavia il punto culminante della festa, il Dia de muertos si situa all'1 e 2 novembre, il primo giorno sono i bambini, los angelitos che ritornano, si preparano per loro dei dolci e dei giocattoli. Il giorno dopo arrivano le anime dei morti degli adulti: a loro vengono offerti oltre ai dolci come il tradizionale pane dei morti - sono infatti chiamati così i pani a forma di ossa - tabacco, abiti preferiti, alcool. Durante questi giorni si addobbano le case con teschi, e sulla costa atlantica del paese è tradizione dedicare una giornata ai viaggiatori deceduti lontani dalle loro case. Per loro si usa mettere delle candele sugli alberi, sui loro altari si usa mettere del sale e dell'acqua simboli della vita, delle croci, delle candele e delle immagini pie. I festeggiamenti proseguono per parecchi giorni. Attorno agli altari e nei cimiteri si organaizzano danze, incontri di poesia e di teatro, si mangia e si beve. A Mizquic, che dista appena mezz'ora da Città di Messico e a Patzcuaro, nell'ovest, hanno luogo le processioni più impressionanti: nel primo caso si riprendono i rituali aztechi, nel secondo sono i Turépéchas che perpetuano le loro tradizioni. Essenzialmente pescatori, organizzano processioni sul loro lago, alla luce di torce. Dal nord al sud si organizzano delle processioni e delle veglie a loro volta, simultaneamente, macabre e carnevalesche. In senso proprio il giorno dei morti simbolizza in modo forte la cultura messicana, la coniugazione di due visioni del casino: è l'opposizione fra il macabro spagnolo e la gioia delle antiche civiltà del paese, senza che nessuna prevalga definitivamente2. Taluno pensa che alla sua base stia più che il culto alla morte il culto ai morti, se non addirittura una festa agricola deviata da cui deriva la presenza dell'acqua, dei fiori, della frutta che sono segni della vita di fronte alla morte. Quale che sia l'origine esatta della festa dei morti, in cui si piange mentre si festeggia, si teme mentre ci si fa scherno della morte stessa, rimane l'affermazione, forse la più importante della specificità messicana. In un contesto diverso, la festa corrisponde alla forza e alla vigenza effettiva della tradizione e da vita al Palio di Siena o alla Settimana santa di Siviglia.
Nel primo caso domina la logica del come se fosse prevalente il tunc-allora rispetto al nunc, al qui-ora: miti e riti dell'allora della festa costituiscono i criteri per l'integrazione e la identificazione della città e dei cittadini nel proprio status sociale. I differenti tratti del festivo oltrepassano la dimensione sincronica e consentono di entrare nel continuum della communitas rinnovando ogni volta i vincoli con un allora che mantiene una permanenza duratura, indefinitamente.
Nel secondo caso l'estetica delle tante immagini sacre, degli arazzi ricamati d'oro, delle migliaia di sculture a forma di candela, si intrecciano, nello sfondo della notte illuminata o del ciclo azzurro nelle lunghe ore del giorno, con il fervore creativo delle saette, con il fragore dei gridi, degli applausi dei presenti, coi suoni dei tamburi, delle bande, coi profumi dell'incenso e dei fiori d'arancio di primavera. La Settimana santa è un'immensa rappresentazione in cui tutti e ciascuno dei presenti, nelle varie ore del giorno e della notte, hanno un ruolo nelle distinte parti delle strade della città che fa da scenario solenne e assorto. A proposito del canto delle saette così Leonardo Sciascia esprimeva le sue impressioni in Horas de Espana: "Si esalta la bellezza della Vergine, le sue grazie, la sua Grazia. È come un canto che persegue la sua eco e lo segue nel suo scomparire".
Conclusione
Mi piace concludere con un pensiero di Rabelais: "Io non mi intendo di teorie, mi aiuto con la pratica". In questo caso la pratica della osservazione sociale insegna che non si può manipolare inpunemente il mondo della vita, la struttura del desiderio, la effervescenza popolare festiva che è polifonica, dai distinti tratti rivelatori delle diffuse contraddizioni della vita. Mi sono riferito solo ad alcuni scenari di un fenomeno assai complesso come quello del "festivo che si vive" e che pernette, come pochi altri, di afferrare nel presente anche segni, esperienze, echi, vicende storiche che, per la contraddizione della vita, si sono volatizzate come foglie al vento.
La festa si presenta, in molti casi, come il segno più netto della domanda sociale di oblìo all'interno di una situazione di smarrimento, di fuga, provocata dalla furia omologante, massificante. Allo stesso tempo si presenta anche come l'espressione della nostalgia per una saldatura, per il re-incontro, nel presente di momenti, di emozioni, di passioni, per il ritrovamento di un continuum, del temps perdu. Non di rado questa evoca l'attrazione fatale per il passato, quasi fosse esclusivamente l'età dell'oro.
La domanda di festa, altresì, si presenta, specialmente in un tempo dalle molteplici innovazioni tecnologiche, di ottundimento della moralità e di trionfo del particolare, con un restringimento non solo del sentimento di solidarietà ma degli stessi spazi di libertà, in non pochi casi, come la proclamazione della passione, quasi una richiesta primaria dei diritti della soggettività rispetto alle manipolazioni e alle degenerazioni della prassi collettiva. Non è il tempo dell'emergenza delle anime elette, ma un promemoria contro il primato di un equilibrio sociale fondato sugli interessi protetti. Il festivo reca dunque una forte valenza di metafora sociale.
Mi si permetta di concludere con due riferimenti. Il primo riguarda la celebrazione del Venerdì santo in alcune aree mafiose siciliane, specialmente durante la sfilata della processione con la Madonna Addolorata al centro. Diceva Sciascia che la lunga fila di donne nero-vestite processionanti dietro l'Addolorata, avvolte nei loro veli neri, sono il segno "del male di vivere, dell'oscuro e viscerale sgomento di fronte alla morte, del chiuso e perenne lutto dei viventi", tutto volto alla propria rassicurazione dentro la vicenda terrena. La festa dunque come riflesso singolare del drammatico stare insieme nel mondo in una terra nobile, forte e amara, al tempo dell'emigrazione forzata e della mafia.
Il secondo sì riferisce ad una città tradizionalmente detta del silenzio per la sua fedeltà al niente di nuovo, che da qualche tempo, di luglio, dedica attenzione alla musica con un festival blues. Sto parlando di Pistola, durante le manifestazioni estive dedicate al blues, Pistola, sorprendentemente, diventauna città alla rovescia: quanto sono vuote o dominate dal traffico localistico, a seconda delle ore, le strade del centro della città, altrettanto appaiono vitali, brulicanti, animate da mille bancarelle di ogni genere e da decine di gruppi musicali, da migliaia di menestrelli moderni, da migliaia di nomadi "cenciosi" appollaiati per le strade e le piazze del centro. Le regole del perbenismo borghese sono sospese; su tutto domina la musica, si incrociano singoli e gruppetti che stanno insieme per una forza vitale che li sovrasta e li penetra. La musica vola alta e tende a spezzare gli steccati politici, religiosi, culturali della routine. I variopinti tatuaggi e i coloriti capelli svelano la ricerca di identità anomale. Si è di fronte ad una liturgia collettiva che evoca, con desiderio struggente, il mondo antecedente la Torre di Babele quando tutti parlavano la stessa lingua. Malgrado la condizione di disagio, di stanchezza, in modo impercettibile, la città alla rovescia continua, resiste con la sua vita al di là della distinzione delle ore del giorno, della sera, della notte, partecipa in un coinvolgimento che è insieme acustico, visivo, motorio e che introduce l'individuo in un corpus che lo annulla e nello stesso tempo lo esalta. È qui che l'homo sentiens, l'essere arcaicissimo che vive la sua utopia al suono martellante di una ritmica ancestrale, modella veicoli per sottrarsi alla cooptazione nel gran mercato degli uguali.
NOTE
1 Cosi erano chiamate perché si coglievano in un bosco della Via Sacra di Roma consacrato a una dea di origine sabina, Strenia che portava fortuna.
2 Peraltro il tema della morte trionfa in tutti gli ambiti della cultura messicana: la canzone, U cinema, la caricatura - o nell'affresco murale il cui capolavoro resta Pedro Paramo di Juan Rulfo, un cacìque morto che regna su un villaggio fantasma.
Enrique Gil Calvo
Specialisti di varie discipline concordano nel ritenere che i processi di modernizzazione abbiano l'effetto di secolarizzare i comportamenti rituali - come le feste, delle quali ci occuperemo inquesta sede.
È però molto più discutibile l'interpretazione da dare al concetto weberiano di secolarizzazione: esso infatti può essere inteso sia come razionalizzazione - e implicare crescita, sviluppo, differenziazione e diversificazione - sia come disincanto - nel senso ristretto di dis-incanto, perdita di significato che conduce di solito alla decadenza, alla regressione e in definitiva all'estinzione. Su tale questione del resto i diversi studiosi non hanno sempre trovato un accordo.
Per quanto mi riguarda, intervengo di solito in questa polemica respingendo la tesi dell'estinzione rituale o festiva, poiché sostengo che la modernizzazione non riduce o estingue i comportamenti festivi ma al contrario li potenzia, li moltiplica ed amplifica - come mi è già capitato di affermare in moltissime altre occasioni. Non ribadirò dunque quelle argomentazioni, ma proporrò piuttosto - anche se con una qualche provocatoria ambiguità - che gli effetti di secolarizzazione della modernizzazione vadano intesi come dissoluzione festiva. A poco a poco - e nella misura in cui è contagiata dalla modernità - la festa appare al tempo stesso soggetto e oggetto di un processo di crescente dissoluzione istituzionale: nel disciogliere se stessa infatti essa da un lato dissolve le restanti istituzioni perché si diluisce in esse, dall'altro è dissolta da queste ultime.
Non si tratta tuttavia di giocare con le parole, divagando circa le possibili figure retoriche che la polisemia del concetto di dissoluzione consente di utilizzare. Preciserò pertanto cosa intendo per dissoluzione festiva affinchè non possano esservi equivoci o malintesi, facendo riferimento soltanto a tre sensi di quel concetto.
Innanzi tutto mi soffermerò su di un senso esclusivamente formale: la festa moderna tende ad adottare forme via via più plastiche, volatili, effimere ed incerte - vale a dire sempre meno solide e pertanto disciolte. Questo è dunque il senso del termine dissoluzione istituzionale che va associato alla nota opera di Marshall Berman (1988) sull'esperienza della modernità: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria.
In secondo luogo, mi riferirò agli aspetti trasgressivi, sovversivi o devianti che si associano alle esperienze festive della modernità: la festa moderna diviene sempre più dissolvente o dissoluta. Questo è il senso del temine dissoluzione festiva che appare nella nota opera di Mìchail Bachtin sulla dimensione rabelaisiana o carnevalesca da cui è generata la cultura popolare dell'Età Moderna.
Farò infine allusione al processo di crescente decontestualizzazione spazio- temperale (o disancoraggio locale] vissuto dalla dinamica storica della festa: man mano che avanzano i processi di modernizzazione, le feste locali si diluiscono in contesti sempre più ampi tendendo dapprima ad urbanizzarsi e in seguito a universalizzarsi. In tal modo esse passano da un'origine locale (e localizzata) a un destino finale via via più cosmopolita, globalizzato e multimediatico. Quest'ultimo modo di intendere il termine dissoluzione può essere ricondotto al concetto di disancoraggio o sradicamento, proposto da Anthony Giddens (1994) per definire le principali conseguenze della modernità.
La festa che si dissolve
Come è noto, Marshall berman nel suo notevole saggio sull'esperienza della Modernità (1988) muove dalla seguente constatazione storica: ciò che i sociologi investigano sotto l'etichetta di processo di modernizzazione è un gigantesco periodo di mutamento infrastrutturale. Esso immette le società che lo subiscono in un infernale circolo vizioso, che da una crescita economica accelerata genera una spirale di distruzione-ricostruzione. Questo processo devastante ha ispirato l'osservazione di Marx presa in prestito da Berman quale titolo per il proprio libro: tutto ciò che è solido svanisce nell'aria equivale a dire che persino le istituzioni più solidamente radicate - la religione, la famiglia, l'autorità o la tradizione - vengono spazzate via dall'invincibile uragano della modernizzazione capitalista.
Orbene, Berman osserva anche che i popoli sottoposti al processo di modernizzazione non lo subiscono con passiva inerzia ma reagiscono in modo innovativo, creando inediti prodotti culturali capaci di esprimere l'esperienza della Modernità ed inglobati dall'Autore sotto l'etichetta di Modernismo. Tali prodotti culturali specificamente moderni - alcuni dei quali vengono analizzati da Berman nel suo libro - sono opere d'arte, libri come il Faust di Goethe, la poesia di Baudelaire o la novellistica di Dostojewski, monumenti come il Palazzo di Cristallo, I boulevards di Parigi o le autostrade di Manhattan, ideologie come lo stesso marxismo e - perché no? - le feste moderne, come proponiamo in questa sede.
In effetti anche gli europei si difesero dai distruttivi processi di modernizzazione cui erano sottoposti mediante la creazione di feste moderne o moderniste il cui prototipo originario è offerto secondo Bachtin dalle sfilate di Carnevale. Queste feste mettono in luce tutte le caratteristiche dei prodotti culturali specificamente moderni così come sono definiti da Berman: la duplice personalità faustiana, al tempo stesso creatrice e distruttrice; la fluidità, la leggerezza senza peso e la volatilità; l'energia cinetica, la vertigine dinamica e la veloce mobilità; la ricorrenza ciclica, la continuità degli estremi e la circolarltà rivoluzionaria; lo scenario di strada, il circo urbano, la facilità spettacolare e la brillantezza baudeleriana del fango del macadam; e infine la parodia cinica, il paradosso contraddittorio e la grottesca deformità.
In un mio lavoro ho io stesso applicato questi tratti formali identificati da Berman come parte dell'estetica modernista alla festa spagnola per eccellenza: la moderna Corrida de Toros. In effetti nella corrida le opere d'arte sono generate dalla distruzione della vita del toro; il torero deve conseguire un effetto di grazia, leggerezza ed armonia utilizzando e trasformando l'impressionante energia cinetica sviluppata dal toro imbestialito; tutto lo svolgimento della festa assume forma circolare, dalla forma della plaza de toros alla sfilata dei picadores e al giro compiuto nell'arena; è lo spettabile pubblico a comandare nella plaza, che si trasforma in uno spettacolo teatrale di masse urbane vociferanti per imporre d'autorità la propria catarsi collettiva; infine, la grottesca brillantezza del traje de luces con cui i matadores si mascherano per celebrare la sfilata trionfale prima della corrida rivela la naturalezza parodica, lo specchio deformante che questo spettacolo racchiude in sé.
Ma al pari delle corridas questo stesso schema potrebbe essere applicato anche ai Carnevali moderni, o alle Fallas della stessa città di Valencia. In relazione a queste ultime, per esempio, è evidente che sono costruite unicamente per esser distrutte; che la loro distruzione si celebra mediante combustione, tramutando una originaria solidità materiale in fumo evanescente e fugace; che nella festa tutto accade in modo molto rapido, ad opera della vertiginosa grazia prodotta dall'enorme energia del fuoco accompagnato dal non meno energico dinamismo di un esplosivo spettacolo pirotecnico; che tali sacrifici si celebrano anche in pubbliche piazze - sebbene queste ultime non debbano di necessità esser circolari - dinanzi a un pubblico entusiasta di spettatori che partecipano alla catarsi; infine, che l'estetica imperante nelle ragazzate e nell'eccessiva sbruffoneria degli abiti della sfilata processionale è volutamente fallera - vale a dire volgare, scioccante, grottesca, rozza e parodica.
Molti altri esempi si potrebbero addurre, ma quelli citati qui di sfuggita sono sufficienti ad illustrare il punto cui desideravamo riferirci: secondo il paradigma di Berman, la festa moderna è un prodotto culturale che tenta di rappresentare in modo spettacolare la dissoluzione pubblica della solidità istituzionale. Per far ciò essa utilizza quali metafore specifici solidi - semplici materiali o esseri viventi, cataste di legno o tori da corsa - che debbono essere disciolti, sacrificati e distrutti in nome della giuria popolare. Ma tale solidità dìssolta nel corso della festa fa allusione inequivocabilmente all'ordine sociale: è la solidità dell'ordine pubblico a dissolversi in modo effimero ad opera della festa moderna. Con ciò entriamo nella seconda dimensione della dissoluzione festiva proposta in questa sede: la dissoluta trasgressione dell'ordine propria del Carnevale.
La festa dissoluta
È ben nota la tesi sostenuta da Bachtin nel suo famoso libro su Rabelais che abbiamo citato: la cultura carnevalesca che parodia, trasgredisce e sovverte le istituzioni più degne di rispetto costituisce l'originaria essenza della stessa cultura moderna, ove si consideri quest'ultima alla luce dei suoi migliori esponenti che ce la presentano proprio in questo modo; come Cervantes, Shakespeare o lo stesso Rabelais.
Se questo è vero, allora abbiamo il diritto di considerare il processo di secolarizzazione - secondo la tradizione weberiana espressione culturale della modernizzazione - in un senso piuttosto differente da quello abituale. Effettivamente in base alla versione generalmente accettata la secolarizzazione dovrebbe attaccare proprio le feste, facendole estinguere col passare del tempo. Per un autore come Peter Burke ad esempio (1982), fu lo stesso puritanesimo che ad opera dapprima della Riforma, poi della Controriforma cominciò a reprimere e ridurre il comportamento rituale o festivo premoderno e tradizionale, sino a farlo scomparire del tutto - o quantomeno a ridurlo alla sua espressione più limitata. In tal modo, la razionalizzazione religiosa avrebbe represso l'irrazionalismo rituale o festivo sino a secolarizzarlo completamente.
Soprattutto le feste moderne come il Carnevale avrebbero allora fatto a meno di qualsiasi contenuto religioso, secolarizzandosi. Non solo: esse avrebbero anche attaccato in modo burlesco con l’irrisione, la parodia e il disprezzo il senso stesso della religiosità. La festa sarebbe stata secolarizzante perché avrebbe snaturato, ridicolizzato, profanato e dissolto le precedenti forme di religiosità sacra: in tale prospettiva, essa avrebbe rappresentato la profanazione dell'ordine sacrale.
Eppure per dissolvere qualcosa è necessario dapprima assumere il suo contenuto, privandolo in seguito della sua forza per poterne cambiare o degradare lo status facendolo degenerare da sacro a profano; donde l'idea che la festa profana sia necessariamente risultato dell'inversione dell'antica festa sacra che verrà dissolta da essa. Per questo le feste profane e profanatici che nascono con la modernità posseggono aspetti anticlericali, antiecclesiastici e antireligiosi - vale a dire sono sacrileghe, iconoclaste e blasfeme8, provocando in tal modo la reazione antifestiva repressiva della Riforma e della Controriforma delle quali Burke parlerà nel suo libro.
Ma proprio per poter dissolvere la religiosità le feste moderne debbono anche essere ispirate indirettamente, in una o altra forma, dalle stesse cerimonie festive che esse debbono sovvertire, corrompere, perturbare o snaturare: da lì l'idea ch'esse debbano copiarle e imitarle (ma in modo rozzo, parodistico) trasportando fuori dal loro contesto i medesimi sintagmi rituali. E questa imitazione desacralizzata della festa religiosa appare tanto una provocazione deliberatamente trasgressiva quanto una manovra diversiva, che tenta di eludere la vigilanza della censura inquisitoriale evitando la fiscale repressione da essa applicata. Per questa ragione le feste profane della modernità riutilizzano in forma secolare materiali rituali tratti dalle feste religiose; e di contro, trasformano le cerimonie religiose mediante la loro ritualizzazione profana. Altrove ho tentato di mostrare, fondandomi sui dati tratti dalle ricerche di Caro Baroja, come il Carnevale stesso si costituì a partire da materiali rituali provenienti dalla dissoluzione della Passione di Cristo; ma in quell'occasione ho mostrato anche in che modo le feste della Settimana Santa furono in seguito ricostituite come feste urbane maggiori, versioni in chiave divina dello stesso materiale rituale proveniente dal Carnevale. In tal modo si stabilì una chiara identificazione simmetrica tra i due opposti estremi - quello di apertura liminare e di chiusura postliminare - che definivano e limitavano la Quaresima.
Al termine del mio articolo citato (Gil Calvo, 1994b) segnalavo anche come in fin dei conti le stesse Corridas di tori siano feste moderne il cui materiale rituale proviene dalla dissoluzione tanto del Carnevale come della Passione, che esse condensano e sintetizzano in un'unica unità sacrificale. In tal senso anche le Fallas, festa principale della Valencia moderna, mettono in scena l'esecuzione pubblica di un oggetto sacro che viene dis-solto o profanato come accade durante ìl Carnevale o la Passione: las Fallas sono l'equivalente funzionale del Carnevale o della Settimana Santa che mancano entrambi in Valencia, e per giunta la festività stessa che cade in piena Quaresima trae le proprie origini dal Carnevale.
Come ha efficacemente dimostrato Antonio Arino, infatti, i rituali delle Fallas derivano da charivarias o chiassose beffe di natura eminentemente carnevalesca. Esse hanno luogo durante la veglia della festività di San Giuseppe proprio perché questo santo si unì in un matrimonio irregolare a una giovine vergine incinta di qualcuno che non era suo figlio, ma verso cui si sarebbe comportato come un padre che dà sostentamento: è noto del resto che in età moderna le beffe chiassose sono feste destinate specificamente a burlarsi dei mariti cornuti, o di tutti i pusillanimi che - per essersi sposati con donne molto giovani, molto vecchie o molto ricche - abbiano rinunciato con disonore all'autorità maschile di rito.
Lo stesso Arino riconosce che "la collettività si incaricherà di render pubblico e dunque censurare il rapporto extramatrimoniale, il matrimonio in seconde nozze o lo sposalizio tra un vecchio ricco e una giovane povera: queste sembrano essere le prime tematiche affrontate dalle fallas” (1992: 21). Muovendo allora da tale constatazione come non ritenere che las Fallas rappresentino la incendiaria beffa che i quartieri di Valencia dedicano ad un padre-marito così irregolare come San Giuseppe? Viene anzi da chiedersi se forse las Fallas siano una celebrazione, in tutti i sensi "focosa", della dissoluzione profanatrice della Sacra Famiglia.
La festa disciolta
L'ultima dimensione della dissoluzione festiva che riteniamo di dover spiegare è quella che deriva dalla stessa dinamica storica dell'evento-festa: man mano che i processi di modernizzazione avanzano, le feste moderne divengono sempre meno locali o localiste e sempre più globali, universali ed astratte. Questa decontestualizzazione progressiva dall'ambito locale è evidente nel passaggio dalla festa premoderna di quartiere o di villaggio alla festa principale tipica della modernità urbana, ma emerge forse con altrettanta chiarezza nell'attuale passaggio dalla festa urbana moderna alla festa postmoderna turistica e ad uso dei media, fenomeno già completamente decontestualizzato e destinato ad un consumo commerciale di portata mondiale. E proprio a questo processo di crescente sradicamento dal contesto e di graduale dissoluzione dell'evento nel villaggio globale mediatico - processo che vediamo in azione oggi, quando las Fallas di Valencia o il Carnevale di Rio sono ormai messi in scena audiovisivamente come si trattasse di Giochi Olimpici - che faccio riferimento con il concetto di dissoluzione festiva, derivato dal disancoraggio di Giddens (1994).
La festa premoderna era situata: era ancorata all’hic et nunc di ciascun contesto puntuale. Per questa ragione essa era tanto locale (contesto spaziale), quanto stagionale (contesto temporale) e posizionale (relativa alla struttura sociale): ogni comunità, ogni stagione e ogni strato sociale possedeva la sua propria e speciale identità festiva. Così nella festa premodema tutti si conoscono personalmente, sanno a quale casa (o famiglia) appartengono e che posizione occupano nella comunità - per quanto tali posizioni (o ruoli) siano destinati a dissimularsi ed invertirsi in modo fittizio durante il Carnevale.
La festa moderna al contrario è sciolta (vale a dire disciolta), dispersa: essa è fluttuante, senza punti di riferimento, radici né ancoraggio possibile ad alcun hic et nunc. Per questo essa è tanto globale (priva di una sede domestica}, quanto in-temporale (non stagionale) e di massa, dal momento che simula la dissoluzione delle strutture: è anonima, impersonale e sconosciuta. Le sue maschere di conseguenza non servono per occultare (dissimulare) o invertire (cioè sovvertire, trasgredire) una posizione sociale riconoscibile e già nota, ma piuttosto a fìngere (simulare) o a tramutare (cioè costruire, creare) una posizione irriconoscibile in una ormai sconosciuta - dal momento che il modello è ormai lo spettacolo audiovisivo di massa tipicamente postmoderno.
I critici della postomodcrnità hanno messo in luce questo tipo di fenomeni responsabili del cosiddetto effetto collage. Una volta decontestualizzata, la festa moderna adotta la forma di una giustapposizione di riti e rituali sciolti o disciolti, che condividono soltanto il carattere sequenziale - proprio come accade con la pagina di un quotidiano o con la guida dei programmi televisivi. Giddens commenta così questa situazione: «forse questo effetto collage è un indizio della scomparsa della narrazione - e chissà, forse anche della dissociazione fra segni e referenti» (1994: 41).
E possibile ipotizzare che la festa postmoderna sia frutto di una dissociazione tra segni festivi e referenti sociali? Ciò equivarrebbe alla scomparsa della funzione dei rituali festivi quali riti di passaggio (Van Gennep, Turner), e in effetti l'equivalente festivo della morte della narrazione sostenuta da Giddens (con la sua sequenza di impostazione, intreccio e scioglimento) è la morte del rito di passaggio (con la sua sequenza di fasi preliminare, liminare e postliminare). In tal modo la festa disciolta o postmoderna sarebbe un continuo collage senza fine; essa anzi sarebbe priva di un principio e di una finalità, poiché non produrrebbe né senso, né una funzionalità integratrice. Se ciò si verificasse, tutte le più fosche ipotesi relative alla dissoluzione festiva verrebbero confermate; ma non è necessario che tutto questo accada.
Di fatto, se osserviamo l'evoluzione storica dei processi di modernizzazione vediamo che questa inarrestabile de-localizzazione istituzionale manifesta due dimensioni diametralmente opposte. Questi processi si originano effettivamente da una dispersione di unità locali indipendenti tra loro, che poco a poco si vanno collegando in reti di interdipendenza che le vincolano a contesti globali più ampi. Tuttavia questa crescita dell'interdipendenza tra le unità locali può essere dovuta sia alla centralizzazione politica - che le sottomette tutte, in egual misura, a una comune dipendenza dalla capitale - sia all'apertura di reti di scambio esterne - come sono i mercati regionali, internazionali o mondiali.
Ambedue le dimensioni - quella centralizzatrice e quella della globalizzazione o apertura verso l'esterno - coesistono sempre simultaneamente, ma alle volte una predomina a detrimento dell'altra. In tal modo il processo storico di modemizzazione presenta due fasi chiaramente differenziate: durante la prima (costruzione dello Stato-nazione) predomina la centralizzazione politica, che dissolve l'autonomia delle comunità locali autosufficienti; durante la seconda (rivoluzione industriale, creazione di mercati, complessità dell'economia mondiale) predomina la globalizzazione, in cui i legami d'interdipendenza dissolvono il potere sovrano di ciascuna capitale politica.
Del resto entrambe le fasi della dinamica storica sono riflesse nell'evoluzione della festa moderna. Il primo periodo di centralizzazione politica destinato a dissolvere le autonomie locali consegue la propria manifestazione festiva mediante l'istituzionalizzazione della Festa principale urbana, che durante L’Ancien Regime celebra l'alleanza sacra fra Trono e Altare: l'esemplo più caratteristico è la festa barocca e controriformista del Corpus Christi, con l'effetto collage della giustapposizione fra strati sociali che sfilavano in spettacolari processioni o in parate che coinvolgevano la vista e l'udito.
Orbene, proprio come la Festa principale dell’Ancien Regime - quale fu quella del Corpus Christi durante la prima modernità - dissolse l'ordine feudale e corporativo premodemo dal potere diffuso mediante la sua autoritaria opera di centralizzazione politica, qualcosa di simile ma dall'esito opposto accadde quando alla Festa principale dell’Ancien Regime successe la moderna festa urbana - commerciale, borghese e democratica. È questo, ad esempio, ciò che è accaduto nel decisivo passaggio dalle Corridas aristocratiche alla moderna tauromachia a piedi, di cui erano protagonisti drappelli di professionisti pagati ingaggiati per far divertire il pubblico delle città: questo passaggio - avvenuto alla fine del XVIII secolo - rappresenta sì un esempio di dissoluzione festiva ma anche di innovazione istituzionale, visto il potere di richiamo globale esercitato dalle moderne corride (Gil Calvo, 1989).
Qualcosa di analogo è possibile concludere dallo studio di Arino (1992) sulla progressiva istituzionalizzazione delle Fallas -la moderna Festa principale valenciana che nel corso del secolo XIX sostituì l'antica Festa dell’Ancien Regime basata sul Corpus Christi. Anche in questo caso possiamo osservare lo stesso trionfo dei cittadini a piedi sui nobili a cavallo, che vinse tutte le opposizioni mosse dall'autorità ecclesiastica, ed anche in questo caso abbiamo un eccellente esempio non tanto di chiusura centralizzata quanto piuttosto di apertura verso l'esterno, visto il potere di richiamo globale esercitato dalle Fallas valenciane.
Sembra perciò che non dobbiamo temere particolarmente l'attuale dissoluzione festiva postmoderna, con la sua caratteristica de-identificazione locale e la sua apertura verso l'esterno: infatti è probabile che ciò che va perso in radicamento locale sia guadagnato in termini di potere di richiamo globale (sebbene tale richiamo sia ottenuto attraverso i media audiovisivi). In fin dei conti, un processo assai simile di dissoluzione festiva fu quello che accompagnò la fondazione dapprima ellenistica, poi latina della cultura mediterranea: e non è forse la festa mediterranea per sua stessa natura aperta, globale e cosmopolita - vale a dire disciolta nell'universalità umana?
Festa di tutti, festa per tutti
Honorio M. Velasco, Francisco Cruces e Angel Diaz de Rada
Moderne tradizioni festive
Una delle raccolte di saggi sugli eventi tradizionali più citata negli ultimi tempi - il cui contenuto è riassunto abbastanza bene dal titolo: L'invenzione della tradizione (Hobsbawn e Ranger, 1983, Tr. it. 1987) - mostrava gli effetti devastanti della manipolazione politica esercitatasi sui fragili rituali. Il vecchio concetto di "tradizione" era allora già talmente deteriorato che fu facile distruggerlo: troppe volte invocato come giustificazione di determinati atti sociali, si era via via logorato sino ad esser deprezzato e disprezzato soprattutto nelle società moderne, che assunsero il mutamento piuttosto che la stabilità come proprio tratto definitorio. L'atteggiamento anti-ritualista tanto in voga nel corso degli anni '60 e 70 aveva scalzato le fondamenta dei rituali, denunciandoli quali forme vuote, prive di senso, vanamente sostenute dalla "tradizione". Il passo seguente nel processo di demolizione doveva di necessità volgersi contro il concetto stesso di "tradizione", dissolvendone la consistenza - e il solvente non poteva essere altri che il concetto di "invenzione". Svanita in tal modo la memoria storica - attività fatta sempre di ricordi e oblii ed elemento essenziale della tradizione - ci si accorse che quest'ultima era risultato di un costrutto intenzionale: il suo scopo era ricondurre incessantemente a un tempo indeterminato prodotti sociali che appartenevano a un periodo ben definito e spesso recente, attribuendo poi a un soggetto globale (collettivo ma anch'esso definito) quelle che in realtà erano mere creazioni individuali o elaborazioni di gruppi di potere. La tradizione, così gelosa dei ricordi, si mostrava dimentica del tempo storico e degli agenti sociali che l'avevano prodotta.
La scoperta che le radici tradizionali dei rituali erano frutto di invenzione li ha sviliti, proprio come un'immagine religiosa di cui si affermi che in origine non era nient'altro che un pezzo di legno. Dopo l'opera di smascheramento di Hobsbawn e Ranger non si è più potuta invocare la tradizione come suggello che legittima il rituale, e la sua efficacia simbolica è definitivamente tramontata.
Se il libro di Hobsbawn e Ranger si iscrive ancora nella corrente anti-ritualista che ha caratterizzato molte società occidentali nel corso degli anni '60 e 70 un'altra interessante raccolta dì saggi sui rituali festivi - quella di Boissevain (1992) - giunge alla conclusione che fenomeni come la secolarizzazione, l'industrializzazione, la razionalizzazione della produzione, la mobilità, i mass media, le diversissime forme di divertimento e intrattenimento, le riforme liturgiche del Concilio Vaticano II - ai quali potremmo aggiungere l'opera demistificante di Hobsbawn e Ranger - non sono riusciti a distruggere i rituali festivi nelle società occidentali. Nel corso degli anno '80 e '90 il fenomeno più notevole che riscontriamo è piuttosto quello contrario: la proliferazione delle feste, il loro risorgere o la loro rivitalizzazione.
Da questo punto di vista è oggi possibile ritenere che l'invenzione di tradizioni non solo non è terminata con la fine di queste ultime, ma anzi ne ha promosse di nuove. Le persone che assunsero atteggiamenti anti-ritualisti nel corso degli anni '60 probabilmente furono le stesse che contribuirono nel corso degli anni '80 a inventare tradizioni o a "recuperarle": non sono pochi infatti i vecchi combattenti della controcultura degli anni '60 che durante gli anni ‘80, dai loro posti di gestori dei pubblici affari, hanno iniziato ad occuparsi della partecipazione cittadina ai festeggiamenti previsti per le località ove risiedono. (In realtà neppure le manifestazioni della controcultura di allora erano diverse da abbozzi di rituali o - come avrebbe detto Victor Turner - da fasi liminoidi di un processo rituale). Alla fin fine non sembra difficile riconoscere che ogni festa è una tradizione inventata, né appare insensato designare come tradizione un rituale festivo originatosi soltanto due o tre anni addietro; ma poiché vi sono pochi dubbi circa il fatto che le invenzioni non mancano neppure nelle società cosiddette "tradizionali", esse appaiono come interessante e paradossale caratterizzazione del processo della tradizione che in ogni rituale vive l'esigenza di esser durevole.
Le differenti modalità del processo di rivitalizzazione - come il recupero, la ri-tradizionalizzazione e, ironicamente, l'invenzione stessa - possono essere spiegate invocando fattori simili, con opportune correzioni, a quelli utilizzati per annunciare la scomparsa dei rituali festivi. Ad esempio l'emigrazione dalla campagna alla città - responsabile della scomparsa di innumerevoli rituali festivi presso le comunità d'origine - è anche causa della loro rivitalizzazione nei periodi di vacanza, una volta consolidatosi il rientro stagionale degli emigranti. La reazione all'emigrazione può spiegare anche il rafforzamento di alcune feste invernali, con cui la popolazione residente si prende in un certo senso "la rivincita" rispondendo all'invasione forzata cui è sottoposta durante l’estate da parte degli emigrati rientranti e dei turisti.
La secolarizzazione della vita sociale e il deterioramento dell'influsso della Chiesa - invocati per giustificare la perdita di alcune tradizioni e la diffusione generalizzata di un certo spirito profano nel modo di viverle - hanno oggi la funzione di mettere in luce il ruolo più importante svolto dalle istituzioni laiche e dalle associazioni "culturali"; d'altro canto però hanno sollecitato i tentativi di comprendere perché alcune rivitalizzazionì di feste religiose abbiano potuto coinvolgere una moltitudine di credenti mai vista prima - per di più senza alcuna congruenza con le cifre relative alla pratica confessionale ordinaria.
Vi sono poi altri fattori esplicativi, in particolare la fioritura delle identità collettive con base etnica e territoriale. Alcuni recenti studi tuttavia hanno insistito a tal punto sulla tematica dell'identità sociale che è necessario chiedersi se la visione dei processi rituali come processi di "identità" non abbia contribuito a dare per scontata una configurazione predeterminata del soggetto sociale della festa, senza mettere in questione le condizioni e i modi in cui tale soggetto si esprime e si costituisce, in parte, mediante la festa stessa. Lungi dall'essere un compito banale, identificare empiricamente qual’è il soggetto sociale che si realizza nelle feste costituisce il problema essenziale fra quelli suscitati dall'apparente contraddizione tra invenzione e rivitalizzazione delle tradizioni festive delle nostre società.
Stranamente non è facile smascherare le tradizioni inventate, fra l'altro perché sono solitamente avvolte da segni che vengono considerati inequivocabilmente genuini: di modo che, una volta accettatele, metterle in questione significherebbe mettere in questione il gruppo stesso. Un esempio di questo fatto è il tono storico-leggendario che accompagna discorsi festivi, che come nel caso del Due di maggio a Madrid tendono a produrre un'immagine di continuità ottenuta però mediante celebrazioni ri-create recentemente con l'avvento dello Stato delle Autonomie. Anche quando sono del tutto contingenti, queste forme festive debbono negare tale carattere se desiderano raggiungere lo status privilegiato di "Festa principale", di "Festa Grande" - vale a dire di festa degli e per gli abitanti. La tradizione (rivitalizzata o inventata) è allora il modo accettabile di negare la contingenza, come se la durata della festa fosse legata alla riproduzione sociale di quella popolazione ridefinitasi come comunità.
Di certo nell'assumere come oggetto le società tradizionali le analisi antropologiche hanno insistito sul fatto che i rituali festivi erano o "l'opera degli dèi" oppure una vera e propria costruzione della comunità - il che è lo stesso, almeno dopo la rivelazione durkheimiana. Gli studi attuali sulle popolazioni rurali perciò non possono che riscoprire l'ovvio: che le feste aggregano le popolazioni intensificandone le relazioni sociali e costituendole in comunità. In realtà questa efficacia simbolica non è affatto motore di una trasformazione, che al contrario ha già avuto luogo in precedenza: è la comunità che rende possibile la festa, sebbene talvolta sia proprio la festa rendere la comunità desiderabile.
E’ possibile nelle società urbane moderne continuare ad attribuire alle feste la stessa efficacia in relazione alla costruzione della comunità? E in che modo va intesa l'efficacia che è ancora possibile assegnare all'evento festivo? In queste società lo studio dei rituali festivi è infatti soggetto a un paradosso: è impossìbile osservarvi la comunità che in teorìa essi dovrebbero esprimere o riflettere, ma è egualmente impossibile non farlo - a meno di negare a questi eventi la qualifica di rituali. Forse sarebbe possibile riformularli come Handelman e chiamarli semplicemente "avvenimenti"? Trattandosi di società pluraliste, composte, frammentate, formate da parti in perenne movimento di aggregazione e disgregazione si rende necessario un intenso lavoro di organizzazione esterna perché sia possibile vivere la festa in qualche maniera; donde la presenza di una gestione dell'organizzazione festiva. 1
"Feste di tutti, feste per tutti" è allora la vera parola d'ordine di chi assolve alla funzione di organizzare rituali festivi in questo tipo di contesto. Ma si tratta di un motto notevolmente ambiguo, e proprio per questo facilmente accettato: esso include tanto le versioni semplici quanto quelle complesse della festa, riaffermando al tempo stesso la funzionalità del sistema di riti nelle società tradizionali e la studiata diversificazione dell'offerta nel programma festivo delle società moderne.
Sistemi di feste tradizionali: la rotazione delle cariche e il calendario come ordine del tempo.
Da Fustel de Coulanges sino a Lévi-Strauss passando per Durkheim, la categoria di sistema rituale è servita a configurare quest'ultimo come un oggetto dotato di una logica e di un senso genuini. In particolare, gli studi sulle società contadine meso-americane realizzate fra gli anni '40 e '60 in un'ottica funzionalista dalla Scuola di Chicago descrissero i rituali festivi presso queste piccole popolazioni locali come parti di un sistema. Ogni festa, nel corso dell'anno e durante gli anni, consentiva la rotazione dei membri della comunità per rivestire una serie di carichela cui terminologia (mayordomos, tenientes, handeras, correas ecc.) era stata ereditata dai colonizzatori seguendo il modello organizzativo delle confraternite tipico del retroterra spagnolo nel Secolo d'Oro. Assumere la carica richiedeva un grande dispendio di energie in attività non strettamente produttive, ma al tempo stesso permetteva di esplicitare convinzioni religiose, saldare il debito contratto con gli esseri soprannaturali protettori o conquistare un ruolo da protagonisti nello svolgimento della festa (appagando così il proprio desiderio di prestigio e integrazione). Non solo la comunità si rendeva visibile ma tutto il sistema rivelava le proprie trame, la propria consistenza. Mettendo in moto meccanismi di riequilibrio dell'eguaglianza grazie alla redistribuzione ritualizzata delle eccedenze accumulate dai gruppi familiari, la festa favoriva l'interdipendenza; la reciprocità e la solidarietà. Chi ricopriva una carica era tenuto a chiedere aiuto economico e lavorativo a parenti, amici e vicini, promuovendo in tal modo l'azione corporativa: si deve infatti sottolineare che le cariche erano al tempo stesso funzioni organizzative e ruoli rituali, che servivano simultaneamente al costituirsi della comunità ed al suo rappresentarsi.
In Spagna [così come in Italia] gli studi sui rituali festivi presso popolazioni rurali si sono concretizzati in meri cataloghi di feste, non consentendo di valutare la possibile struttura sistemica di queste ultime. In ogni caso l'idea di sistema che essi mettono in luce è differente, perché le feste sono presentate come occasioni che nel corso dell'anno consentono ai membri di una società segmentaria di assumere di volta in volta ruoli da protagonisti: feste infantili e di adolescenti; feste di uomini e di donne; feste di confraternite, di corporazioni, dì agricoltori, di orticoltori, pastori, commercianti, carrettieri; feste di strada, di quartiere e infine feste principalidi tutta la popolazione, in cui però alcune attività sono riservate di preferenza a ciascuno dei diversi segmenti. In tutti questi casi siamo dinanzi ad atti rituali nei quali la densità dell'insieme è espressa mediante la confusione, l'amalgama, il frastuono. Il sistema include a volte feste di villaggi vicini, che indicano il grado di dipendenza di una popolazione rurale da un centro economico, politico ed amministrativo, mettendo in luce la relazione che intrattiene con altre comunità prossime ad essa. Plasmando i meccanismi di articolazione di quei segmenti che sono parte dell'intera popolazione, il sistema contribuisce ad inglobare le genti locali in zone territoriali definite come unità politiche, amministrative, economiche e culturali. Inoltre, esso offre occasioni per lo scambio - attraverso l'esogamia e il consolidarsi dei mercati -, genera flussi di informazione che danno una parziale consistenza alle unità territoriali e stimola la rivalità fra popolazioni locali. Il sistema di feste descritto presso le popolazioni meso-americane era focalizzato all'interno delle comunità; quello che abbiamo appena descritto gravita invece su un ambiente esterno (quanto alle sue caratteristiche interne, esse non sono simili a quelle descritte presso i contadini della Meso-america ma presentano al massimo lontani parallelismi con esse).
Quando si parla di sistema festivo in società agricole si parla soprattutto di un ordine del tempo - vale a dire di un meccanismo in grado di regolare il passaggio delle stagioni e degli anni, di segnalare il mutamento di attività, di sincronizzare i cicli produttivi dei gruppi domestici e infine di esprimere la continuità della vita sociale attraverso la temporalità di un soggetto durevole: la comunità stessa.
Detto sistema sembra riposare su due postulati: il primo sostiene che al fluire evanescente e disgregatore del tempo la società risponde con una memoria regolarizzata mediante cicli; il secondo afferma che i processi produttivi dispersivi cui partecipano i gruppi domestici sono controbilanciati da momenti temporali vissuti concordemente, che favoriscono la solidarietà e l'interdipendenza. La dispersione produttiva e il deteriorarsi del tempo convergono, dando origine a un soggetto sociale comunitario che vive un tempo regolato e agisce essenzialmente durante le feste, rigenerandosi ad ogni ciclo per assicurare a se stesso una continuità indefinita. Nell'ambito di questo ordine le società rurali appaiono come comunità insensibili al passare del tempo - cioè "tradizionali", perché la tradizione è la forma mediante cui perdurano: agli occhi della gente gli anni e le feste passano ma le comunità restano, con e a causa di quelle stesse feste. Le comunità appaiono in tal modo entità superiori alle persone che le compongono.
Questo schema di ordinamento del tempo è enunciato in un codice religioso la cui razionalità sembra fondata su due metafore: quella del ciclo della vita e quella genealogica. La Chiesa tenta di proiettate l'idea ciclica sul fluire del tempo, utilizzando gli episodi fondamentali della vita di Cristo, di Maria - sua madre - e dei Santi: l'anno cristiano infatti è un calendario di feste in cui si commemora la nascita, la vita, la passione e la morte di coloro che la Chiesa addita come modelli di vita per i membri della società, concedendo il ruolo di protagonisti ai distinti segmenti sociali in relazione all'adempimento religioso dei loro rispettivi modelli. Questo codice soddisfa una duplice funzione. Da un lato esprime l'ordine del tempo di un'istituzione universalista - la Chiesa cattolica - la cui missione evangelizzatrice può essere estesa a tutti i confini del globo; in tal modo esso aspira a istituire una temporalità universale, comune a popolazioni dì ambienti sociali ed economici diversi. D'altra parte, in questo stesso codice ogni comunità locale trova la giustificazione per differenziarsi da altre, festeggiando i propri santi patroni e intensificando la celebrazione di specifiche feste che in origine erano patrimonio comune. La Chiesa cattolica, con la vita dei suoi fondatori e dei Santi, fornisce così un codice religioso che motiva tanto celebrazioni universali, quanto locali - vale a dire "feste di tutti e feste per tutti"2.
La visione "tradizionale" del sistema di feste dev'essere considerata in modo non ingenuo, non solo perché è compatibile con altre prospettive in grado di appurare la manipolazione delle feste da parte di gruppi (come le casate nobiliari) e istituzioni (come la stessa Chiesa o gli ordini religiosi) che fomentano e istigano le celebrazioni - una manipolazione che d'altra parte può anche essere attribuita alle "classi popolari" -, ma anche perché è più durevole di tali gruppi e classi. Né si deve pensare che il carattere sistemico conduca automaticamente all'integrazione effettiva dei differenti gruppi in una comunità: il sistema può essere anzi una successione di conflitti, e ciascuna delle sue feste un pretesto in più per mettere a confronto gruppi e attori sociali disposti a competere per gli spazi pubblici, i ruoli rituali e l’appropriazione dei simboli. Anche l'integrazione può essere fittizia, e la celebrazione della festa una mera pantomima o un fugace periodo di tregua. La comunità locale non si trasforma di necessità in comunità morale esprimendo se stessa nel corso delle feste, non è un soggetto sociale già esistente e costituitosi una volta per tutte; piuttosto, è un soggetto in progress. Di conseguenza si dovrebbe guardare al sistema come al risultato di una continua negoziazione, portata avanti da gruppi e persone sulla base di mutue concessioni più o meno provvisorie (Garcia et alii, 1991).
Alcuni saggi hanno descritto le trasformazioni subite dal sistema con l'emigrazione di massa in direzione delle città e il ritorno temporaneo degli emigrati nei paesi, l'invecchiamento della popolazione residente in aree rurali, l'immissione accanto a quest'ultima di gente proveniente dalla città ma avente una seconda residenza in campagna, e altri fattori già noti. A dispetto di tutto questo, la struttura fondamentale del sistema non è andata distrutta: se infatti alcune feste minori sono scomparse, altre sono state rivitalizzate. Non solo il sistema funge ancora da "ordine del tempo" per una comunità che continua ad essere agricola, ma oggi serve anche ad articolare una nuova, fondamentale segmentazione che distingue i residenti permanenti da quelli temporanei - cui peraltro si debbono senza dubbio attribuire la rivitalizzazione delle feste e il nuovo dinamismo della comunità stessa.
Il sistema distingue attualmente due stagioni - l'estate e il resto dell'anno - o per meglio dire due stati, che possono comparire più volte nel corso dell'anno: i periodi in cui gli abitanti del villaggio e gli emigranti rientrati convivono, con in più turisti e visitatori (fine settimana, ponti, vacanze di Natale, Settimana Santa e vacanze estive); e gli altri, nei quali gli abitanti del villaggio restano da soli. Sebbene il sistema sia in qualche misura negoziato e incorpori aggiunte "civili", non ha perduto né lo schema ciclico né il codice religioso in seno al quale è stato "sempre" formulato; tuttavia esso possiede due letture chiaramente distinte: per coloro che sono rimasti, significa la continuità nel tempo, che essi assumono dunque quale ordine necessario; per coloro che vivono nelle città e ritornano di tanto in tanto in paese, tale sistema è soltanto una opzione. La nuova segmentazione della comunità implica anche disgregazione, dal momento che coloro che emigrarono "sono" del paese ma non "stanno" in esso. Costoro hanno prodotto o rafforzato i mutamenti, mentre gli altri si sono limitati ad accettarli più o meno a malincuore; assieme ai mutamenti gli uni reclamarono "feste per tutti", e gli altri accettarono perché in fin dei conti "le feste sono di tutti". Un sistema che offriva "feste di tutti e feste per tutti" poteva così esser soggetto a due letture dissociate tra loro, ciascuna delle quali aveva poi specifiche sfumature.
Sequenze e spazi della festa in un contesto di modernità
Le società urbane moderne e pluraliste non sono prive di un ordine del tempo; ma quest'ultimo non è più concepito in connessione con un sistema di feste. La distinzione fondamentale discrimina tra giorni lavorativi e non lavorativi, tempo di lavoro e tempo di vacanza; ambedue questi tempi si ordinano in due cicli: quello settimanale e quello annuale. Sebbene le feste siano regolate, la loro celebrazione è in certo qual modo opzionale: basta guardarle, semplicemente, come giorni non lavorativi. Nelle società moderne il numero di giorni di riposo è considerato una conquista sociale, ed equivale per la maggior parte della popolazione a circa un terzo dei giorni dell'anno; in tal modo uno dei tradizionali caratteri della festa - quello che le qualificava come giorni di riposo - è venuto rafforzandosi, poiché ad esso si è aggiunto un tratto di opzionalità.
In queste società la gente sente di "non aver tempo", cioè il tempo non appare ordinato in modo omogeneo. La successione tempo lavorativo-tempo di ozio è comune alle diverse attività della produzione industriale, ma la situazione è differente nel settore dei servizi come pure in molte istituzioni pubbliche e private. Il calendario è ormai un codice numerico talmente astratto da contemplare motivi di celebrazione tanto disparati quanto possono esserlo una invocazione religiosa, un anniversario istituzionale, una commemorazione storica o la semplice voglia di incontrarsi in una data stabilita. Persiste così un nucleo di feste formanti un sistema e legate al ritmo dell'anno, che distingue le stagioni tra loro e si esprime mediante un codice religioso - ricordo vago di una società che fu agricola, nella quale la Chiesa svolse un ruolo essenziale. Anche lo Stato laico segue nelle proprie feste il ciclo annuale, affidandovi il meccanismo di celebrazione della sua stessa instaurazione - intesa come irruzione d'una nuova era, che si desidera far durare all'infinito. Alcune istituzioni statali commemorano il rinnovamento annuale della loro attività ricorrrendo a un qualche tipo di celebrazione, e istituzioni pubbliche e private mettono assieme feste del ciclo annuale e feste associate al ciclo della vita comportandosi come entità astratte, che assorbono le vite dei loro membri per alimentare la propria.
Le modalità cui si può ricondurre l'opzionalità della festa nelle società moderne dipendono più dalla relazione con gruppi e istituzioni che dal fatto di suddividere la localizzazione territoriale dell'evento o al contrario coinvolgere semplicemente una parte della popolazione. L'opzionalità si esercita in modo differente nelle distinte celebrazioni: persino le società pluraliste posseggono celebrazioni quasi obbligate - ad esempio il Natale - mentre altre sono obbligatorie soltanto per coloro che debbono svolgervi una rappresentazione o assolvere ad un impegno, e sono così poco attraenti cbe parteciparvi è considerato in pratica un fatto "professionale". Vi sono tuttavia molte altre feste che la maggioranza dei partecipanti affronta come un esercizio di volontà - vincendo in tal modo persino un'inerzia di ozio passivo -, o almeno come frutto di una negoziazione nell'ambito del gruppo familiare o di pari. Questi gruppi a loro volta agiscono da soggetti dell'opzione e operano come unità disposte tanto a vivere la festa in modo autonomo, quanto ad integrarsi in un raggruppamento più ampio ma dalla vita così fragile e transitoria che può smembrarsi in qualunque momento o addirittura non riuscire neppure a costituirsi come tale.
L'opzionalità fa riferimento ad un soggetto sociale formato per aggregazione, per presenza coincidente nel tempo e nello spazio; essa allude ad un soggetto sociale più o meno regolare che affronta attività comuni in modo più o meno coeso. Tale soggetto non cessa di essere plurale né frammentato, sebbene sia riconoscibile all'interno di uno stesso spazio-tempo festivo: è anzi significativo che la festa sia considerata tale solo nella misura in cui, superata l'incertezza dell’opzionalità, vi sia una presenza massiccia di celebranti e si produca un "ambiente" festivo - vale a dire "animazione", "movimento".
La festa in atto è una situazione di rischio continuo. Nelle società rurali il principale e forse unico rischio dì fallimento della festa è di natura meteorologica; l'assenza di gente è un eventualità praticamente inconcepibile - e non è un caso che la proverbiale frase "annacquarsi la festa"sia usata metaforicamente quando la celebrazione va in fumo a causa d'una crisi della convivenza. Ma anche se arriva l'acquazzone il sistema resta indenne, e subentra la speranza di recuperare l'anno seguente una mancata celebrazione nell'anno in corso. Anche nelle società moderne e pluraliste le feste possono "annacquarsi", ma i rischi principali incombono sulle situazioni estreme nel processo festivo: da una parte, l'opzionalità dà all'evento una fondamentale incertezza, perché può condurre al fallimento della festa ancor prima che essa abbia luogo; dall'altra, una partecipazione eccessiva e superiore a quanto previsto dall'organizzazione può rendere più probabili incidenti ed imprevisti. Nelle grandi società urbane, il rischio investe sia gli avvenimenti detti da Handelmann di «presentazione» - che tentano volutamente di generare una chiara impressione di ordine prodotta da una studiata uniformità, replicabilità ed esattezza nei movimenti delle masse (parate militari, sfilate commemorative ecc.) - sia quelle situazioni indicate da Turner mediante la categoria di «liminoidi» - nelle quali il flusso dell'attività è più importante degli obbiettivi dell'azione stessa e che senza esser caratterizzate necessariamente da distruzione e disordine sono contrassegnate dalla rottura di norme e libertà da schemi. Senza dubbio, le une e le altre sono situazioni di rischio continuo: le prime, perché sono tanto più soggette a incidenti casuali o ad attentati premeditati quanto più perfetto e complesso è l'ordine che desiderano mostrare; le seconde, in quanto si generano come situazioni marginali, che favoriscono l'esperienza dei limiti e si rivelano pertanto ancor più incerte tanto per gli esiti edonistici quanto per quelli tragici. Per questo in contesti urbani la celebrazione della festa necessita sempre di un servizio di vigilanza da parte di istituzioni di controllo e assistenza.
Gli spazi della festa in queste società non sono facilmente riconducibili ad una tipologia: infatti il luogo della festa è a volte unico, a volte molteplice, talora denso e concentrato, talaltra diffuso, a volte esteriorizzato e oggettivato e altre volte invece interiore e "soggettivo". Sebbene gli studi etnografici siano ancora scarsi, possiamo comunque suggerire l'approssimativa classificazione che segue:
1. Spazi con funzioni diverse, utilizzati quotidianamente come luoghi di distribuzione e incontro. Strade e piazze (in genere centrali, ma non necessariamente situate nei centri storici) sono in questo caso spazi privilegiati dei grandi atti festivi. Esse vengono trasformate grazie ad un'architettura effimera che risemantizza quella permanente trasformandola in scenario festivo, o la configura come luogo di spettacolo distinguendo due settori: uno per gli attori rituali, uno per il pubblico degli spettatori. Le feste scorrono lungo tali percorsi, e sono concepite come itinerari3.
La strada -contrapposta alla casa, al posto di lavoro e ai luoghi istituzionalizzati - costituisce un luogo aperto, ampio ed espandibile, diffuso e molteplice, destinato al transito ed al movimento. Per strada ci può essere festa ancor prima che la celebrazione inizi, la festa può continuarvi dopo essere ufficialmente finita; in strada poi la festa si espande, muovendo dai centri in cui si svolgono gli atti rituali più importanti. Spazio aperto di incontro, aggregazione ed esibizione, la strada è il luogo principale della "festa di tutti": nella festa urbana strade e piazze possono essere considerate simbolicamente come vetrine per il potere, ma spesso sono anche luoghi in cui si riscattano appropriazioni indebite.
2. Spazi periferici in terreni che non hanno un uso specifico, siti a volte in centro ma in generale in zone non urbanizzate; si tratta di spazi estesi e aperti, in cui hanno luogo atti formali destinati a una moltitudine di persone o attività di divertimento minori - come fiere, sagre, spettacoli di circo, ecc. Questi spazi sono anch'essi parte della "strada", e nella vita dì tutti i giorni sono luoghi nei quali giocano i bambini o in cui vagano soggetti marginali: la festa consente di riutilizzarli, creandovi un "ambiente" effimero praticamente dal nulla. Per un breve periodo si trasformano in centri di intensa interazione; poi, quanto tutto è finito, mostrano i resti dello spreco, dell'euforia e dell'eccesso: lo sporco, il vuoto là dove c'era la festa. Nell'ottica della razionalità urbana, lo spostamento della festa in questi spazi periferici è una strategia dì salvaguardia del centro nobile della città, un modo per circoscrivere e limitare gli effetti nocivi della festa salvaguardando i moderati atteggiamenti borghesi diffidenti nei confronti delle feste popolari. Sono luoghi periferici per strati "liminari", lontani dai centri e dai territori di competenza esclusiva o preferenziale dei gruppi dominanti.
3. Spazi specializzati. È forse una caratteristica delle moderne società urbane il fatto di disporre di numerosi spazi adatti a fungere da luoghi speciali per celebrarvi feste o attività suscettibili dì essere integrate nella festa: sale da cerimonie per usi molteplici, teatri, auditori, cinema, stadi, complessi sportivi, plazas de toros, circoli, ristoranti, saloni di alberghi, sale per feste, clubs, discoteche, cabarets, musei, sale per esposizioni, case della cultura. . . tutti spazi chiusi che usati di preferenza o in modo esclusivo per il divertimento, il gioco, lo sport, gli spettacoli. Si tratta sempre di "locali", vale a dire di spazi architettonici fissi destinati a contenere gente e dotati di una capacità più o meno ampia ma pur sempre limitata - spazi predisposti per accogliere una popolazione suscettibile d'esser misurata, contata, prevedibile e omogeneizzata. Questo tipo di spazio implica la diversificazione della festa, composta ora da attività più o meno autonome.
La festa disgregata e programmata.
Uno schema proposto da Greimas può esserci di aiuto nel descrivere le caratterizzazioni dell'evento festivo su esposte. Greimas (1971) ha presentato il processo di transizione dalle società tradizionali a quelle moderne come un passaggio dall’etnosemiotico al sociosemiotico, tentando in questo modo di giustificare lo sviluppo nelle società moderne di specifiche forme di discorso autonomo - la poesia, la musica, la danza - che nelle società tradizionali erano inglobate entro un unico fenomeno mitico.
Il processo di autonomizzazione si riferisce non solo al progressivo disgregarsi dalla festa di attività un tempo articolate ad essa come fenomeno globale, ma anche alla visione della festa stessa come insieme di sistemi differenziati: un campo di attività formato dall'intersezione di categorie come ozio, divertimento, cultura, spettacolo, arte sport, ecc. che debbono svolgersi in spazi circoscritti e separano un gruppo di persone in esaltata trance - la minoranza in festa - dagli altri, che continuano a vivere la quotidianità. Nell'ambito di questa parcellizzazione di attività la festa si trasforma in un avvenimento opzionale, promosso con intensità variabile, per motivazioni diverse e a cadenze specifiche da gruppi eterogenei, talvolta persino in contrasto tra loro quali gruppi familiari, d'età, territoriali o professionali, collettività, istituzioni, associazioni, imprese...
Greimas inoltre mette in luce la trasformazione del carattere sacro della festa in società tradizionali nelle moderne funzioni di semplice intrattenimento e godimento estetico. Tale assunto potrebbe essere riformulato dicendo che la festa è diventata più tecnica che espressività: le attività festive funzionano come "attrazioni" che tentano di potenziare la concorrenza; l'efficacia simbolica si ottiene attraverso l'intrattenimento e lo spettacolo; la magia della festa si fonda su un complesso strumentario di arti e tecniche che richiede apprendistati laboriosi. Infine, la performance ha assunto maggiore rilievo e con essa le abilità dei partecipanti.
Una terza ipotesi avanzata da Greimas sostiene che le manifestazioni collettive siano diventate stili individuali di produzione e attività. Questa impostazione implica una discutibile dicotomia fra la dimensione collettiva e quella individuale, poiché in realtà le modalità della partecipazione sono variabili e situabili tra due ruoli - quello dell'interprete e quello dello spettatore - che pur essendo più o meno distanti non sono in alcun modo dissociati ma si rimandano l'un l'altro, si riflettono l'uno nell'altro rappresentandosi vicendevolmente. Nel contesto della stessa festa, anzi, i due ruoli si incitano addirittura tra loro per riuscire a ricrearne l'atmosfera. La festa non è un fatto esteriore rispetto alle attività che la compongono, ma è concepibile piuttosto come "ambiente": un modo d'essere vissuto al tempo stesso come "interiore" ed "esteriore" perché emerge dall'attività stessa. Pertanto più che di individualizzazione si dovrebbe parlare di soggettivizzazione della festa nelle società moderne, intesa come diversità di forme in cui si definiscono soggetti sociali previamente strutturati o, al contrario, quasi del tutto indefiniti — ma in ogni caso sempre definibili. Questo processo trova il suo compimento nella comune nozione di "pubblico"4.
E’ impossibile perciò che nelle società moderne e pluraliste le "feste di tutti" presentino l'immagine di una comunità omogenea. Questa impossibilità non è mai riconosciuta apertamente, rischiando di compromettere la festa stessa come immagine e modello di comunità; tuttavia, è compensata dall'efficace organizzazione di "feste per tutti".
Così il programma di una festa predisposto come un'"offerta per tutti i gusti" rivela in primo luogo l'estensione temporale della celebrazione: il giorno speciale della festa principale o festa grande perde di rilievo, viene diluito in una "Semana Grande" o persino in feste di tipo stagionale - "Feste di Primavera", "d'Estate" o "d'Autunno". Inoltre, il programma enumera un insieme di atti ed avvenimenti che hanno luogo in spazi disseminati per la città. In alcune occasioni - come ad esempio durante las Fallas — questa dispersione riguarda la città intera, mentre più spesso vengono disposti molteplici punti d'attrazione, dotati di spazi comuni e spazi ristretti che facilitino la distribuzione della popolazione in aggregati relativamente controllabili.
Infine, questi atti si svolgono in sequenze regolate che occupano la mattina, il pomeriggio, la sera e l'alba; la suddivisione delle attività sembra fondarsi su di una corrispondenza tra la loro natura e un determinato periodo temporale, alle volte tenendo conto anche dei ritmi di esteriorizzazione e chiusura su se stessi di vari settori sociali. Alcune attività assumono una forma più flessibile, altre debbono essere celebrate ad orari determinati: la mattina è riservata a cerimonie ufficiali, giochi o avvenimenti sportivi ed attività "culturali"; il pomeriggio consente atti minori; la notte è il momento culminante per spettacoli classificati anch'essi come "culturali" (banchetti, teatro, l'Opera, danza, concerti); l'alba è riservata al divertimento informale e sfrenato. In realtà un ordine di questo tipo è irrealizzabile se pensato in rapporto ad un individuo che passa di atto in atto; al contrario, gli atti sono considerati come se fossero indipendenti tra loro, e sono selezionati da gruppi e individui. Gli organizzatori tentano di realizzare un programma "per tutti", ma in pratica già una "festa di tutti" è impraticabile.
Il programma è dunque il risultato di una combinazione di atti tradizionali e proposte più o meno nuove, adottate in genere seguendo modelli sperimentati altrove o perfezionando esperimenti precedenti; a quanto pare essi possono coesistere senza grandi contraddizioni, poiché la festa è anche pratica di anacronismi tollerabili.
La festa programmata è qualcosa di paradossale, poiché il programma deve rendere possibile l'opzionalità: se individui e gruppi di una società che è pluralista negli interessi e nei modi di vivere la festa debbono trovarvi una qualche soddisfazione, esso deve anche opporsi alla loro decisione opzionale di inibirsi o negare la propria partecipazione all'evento. Il paradosso può anche esser formulato così: non è possibile leggere attraverso le feste la comunità che in teoria esse dovrebbero esprimere o portare alla luce, ma non è possibile neppure evitare di farlo. Questo paradosso si fonda su tre presupposti: primo, la scoperta che nelle società composte da frammenti disaggregati e di consistenza estremamente variabile - dalle istituzioni che si presume durino in eterno sino agli aggregati occasionali di individui - l'efficacia simbolica della festa dipende da un principio di organizzazione dei frammenti che è di natura tecnica ed esteriore; secondo, l'utopia durkheimiana per la quale ogni festa ha bisogno di un soggetto sociale definito in anticipo, il cui modello continua ad essere la comunità - la società di aborigeni australiani come società primigenia è in effetti essenzialmente utopica; terzo, il postulato dell'efficacia simbolica della festa, capace di riì-creare (quando non addirittura di creare ex nihilo) un soggetto sociale spingendo a desiderare la necessità di una società. Per i tecnici e gli organizzatori mettere in pratica un modello di socializzazione come quello comunitario in un contesto di diversità, frammentazione e autonomizzazione in apparenza incompatibile con il modello stesso significa conservare un'efficacia simbolica, risolvere il paradosso ricorrendo alla programmazione di "feste per tutti" presentate nella retorica del discorso come "feste di tutti".
Anche per l'etnografo ormai il soggetto celebrante non è più un semplice a priori: sistemi, spazi e sequenze della festa non possono essere considerati come espressioni di una comunità omogenea e coesa. Vi troviamo infatti raggruppamenti definiti dall'appartenenza a istituzioni nelle quali vige un'ideologia localista o universalista; associazioni di volontariato di ambito locale o internazionale; gruppi e reti definiti in modo informale, suscettibili di ampliarsi o restringersi; aggregati stabili di individui; aggregati instabili o occasionali, che coincidono o sono omogenei quanto a stili ed interessi; intere popolazioni definite dalla loro appartenenza territoriale, eterogenee e senza dubbio sentite come "comunità immaginarie"; enormi gruppi di persone su scala mondiale, che si costituiscono occasionalmente attorno ad avvenimenti speciali come le Olimpiadi o le Esposizioni Universali... Infine, vi sono tutte le persone e gruppi che svolgono il ruolo istituzionale di mediatori della festa (compiti organizzativi di pianificazione, programmazione e gestione), distinti in genere da quanti partecipano alle attività festive e che anzi hanno anche la funzione di definire il soggetto sociale partecipante... L'identificazione di queste ed altre strutture sociali in relazione con la festa ci farebbe allora comprendere in che misura lo slogan "feste di tutti, feste per tutti" sia in grado di creare o esprimere realmente sensi nuovi dell'efficacia simbolica.
NOTE
1 Questo lavoro organizzativo tutt'altro che disprezzabile, come pure la consapevolezza da parte degli attori di vivere un tempo speciale che si traduce nell'esperienza di un "ambiente" - contraddistinto a sua volta in buona parte dagli attributi della "festa tradizionale'' - ci inducono a chiederci sino a che punto è necessario deformare i dati per fare piazza pulita della distinzione fra tempo ordinario e simili "avvenimenti. A meno che, naturalmente, non si sia disposti a giocare con scale di valori atte a misurare un qualcosa come "l'autenticità" della festa o la sua "intensità" - scale che d'altra parte sarebbero ugualmente applicabili nel caso delle feste tradizionali, pur se non raccomandabili da un punto di vista metodologico.
2 Questo sistema di feste inteso come ordine del tempo non è sempre sviluppato: a parte i casi di grave spopolamento o degrado economico che lo perturbano, lo indeboliscono o lo distruggono, i dati etnografici suggeriscono che esso non ha corso presso popolazioni demograficamente piccole o con una struttura sociale diffusa, dove forse la presenza dell'istituzione ecclesiastica è meno forte (ad esempio in zone del nord della Spagna); si tratta di genti che considerano come soggetto sociale di rilievo non la comunita, ma la casa o i gruppi familiari. In questi casi la celebrazione di feste non è fissa né regolare nel corso dell'anno, ma legata piuttosto all'iniziativa di alcuni e a una previa negoziazione. Se si considera un dato rilevante il fatto che presso queste piccole popolazioni i segmenti sociali diversi dai gruppi familiari non sembrano avere una grande consistenza, è possibile ipotizzare che il sistema di feste (quando viene assunto come ordine del tempo) non si limita a segnalare il passaggio delle stagioni o il mutamento di attività, ma agisce come mezzo di incontri, propiziando relazioni sociali fra raggruppamenti stabili o transitori basate sull'età, sul genere, sull'occupazione, ecc. e culminanti nel raggruppamento prodotto dalla condivisione di un territorio: la comunità, tramutatasi ormai nel contesto che da unità globale a tali incontri.
5 L. Marin (1987) ha catalogato tre tipi di feste itineranti, descritti facendo uso di categorie come parata, sfilata, processione, corteo o manifestazione, II primo tipo è l'itinerario monodirezionale con punti di partenza e di arrivo differenti, che implica un movimento irreversibile e in cui la marcia diviene riproduzione di una storia o volontà di trasformare una situazione: giungere al punto di arrivo è considerato una vittoria simbolica della collettività in movimento. Il secondo tipo è un percorso di andata e ritorno con un medesimo punto di partenza e di arrivo; quest'ultimo senza dubbio non è affatto identico ad un mero ritorno, poiché implica una rinnovata legittimazione. Il terzo tipo è un percorso circolare chiuso che crea un limite reale o ideale e lo segnala simbolicamente con un movimento continuo supposto come interni inabile.
4 II ricorso al numero di persone per individuare approssimativamente il pubblico è un indice significativo della difficoltà sperimentata dagli etnografi nel descrivere le caratteristiche essenziali dei soggetti sociali che prendono parte a questi avvenimenti. La dimensione numerica del "pubblico" è immediatamente traducibile nei termini di successo o fallimento economico della festa, ma possiede anche altri aspetti: ad esempio, le variazioni da un anno all'altro possono essere considerate indicatori di progresso o decadenza. Il numero si usa anche come modello omogeneo in grado di valutare atti di differente natura (un concerto e una corrida de toros, una sagra e una messa solenne): il modello può servire da guida per modificare la struttura o i toni di successive programmazioni, e talora si usa anche come arma di contesa fra diverse città.
Un approccio prevalentemente tecnico considera il numero un minimo comun denominatore delle feste. La configurazione del soggetto sociale attraverso il numero è volutamente omogenizzatrice, poiché mira a fare della festa un evento prevedibile interpretando l'opzionalità in termini normalizzati. Ma la dimensione numerica è anche un modo per accedere al "tutti" come aspetto di primaria importanza del soggetto sociale. Di fatto questo soggetto, inteso a partire dal modello comunitario, è definibile solo come "tutti" - definizione paradossale in seno ad una società frammentaria e praticamente improponibile se riferita ad una società in cui la grande mobilità territoriale non consente di sapere quanti membri saranno presenti all'evento festivo, né se i presenti saranno tutti suoi membri.
“Che la festa cominci!'
Banchetti, macchinari, saltimbanchi e nuove tecnologie: spettacolarizzazione e tradizione nella «messa in scena»
Luci Rami Ceci
In questo intervento non intendo mettere in discussione la tesi che esistano forti ed evidenti contrapposizioni tra idea e pratiche del festivo nel passato della nostra cultura, e forme di spettacolarizzazione che caratterizzano la maggior parte degli eventi festivi nella contemporaneità. Su questa linea è stato rilevato proprio nell'ambito del Congresso che ha dato occasione al presente contributo come ad un certo «bisogno di festivo autentico che le masse sembrano esprimere in epoca di forte dimensione comunicativa degli eventi corrisponda (in effetti) uno scarso effettivo coinvolgimento dell'individuo alla realizzazione dell'evento stesso», rispetto al passato (P. Clemente); inoltre, per ciò che concerne la motivazione e la titolarità della festa, dati emersi da una sistematica rilevazione dell'evento festivo rurale indicano come a volte il calendario festivo non faccia più riferimento ad avvenimenti legati al ciclo produttivo-agricolo (G. L. Bravo) pur presentandosi diffuse permanenze di festività rurali. Potrei segnalare altre considerazioni qui ed altrove emerse che intendono sottolineare tali differenze e parlano nei termini di vere e proprie rifunzionalizzazioni della festa1. Queste, in genere, mettono in evidenza la non-continuità tra i modelli di realizzazione, le forme espressive, l'essenza stessa del festivo nell'attuale fase attraversata, nelle società occidentali, dalla cultura della post-modernità, globale e multimediale e la festa espressione di una cultura locale sia rurale che urbana, circoscritta e ripetitiva quale è rappresentata nella tradizione europea.
Quanto intendo mettere in evidenza è, al contrario, la sostanziale continuità nelle diverse forme del festivo quale si rileva, ad esempio:
- nella tendenza a sperimentare tecnologie nuove, sollecitata dalla ricerca dello 'effetto speciale', dell'elemento della 'sorpresa',
- nel coinvolgimento e nell'interazione non soltanto fisica ma psicologico-emotiva che la festa produce tra i partecipanti,
- nella reale capacità di abbattere gli steccati sociali,
- nel rappresentare luogo di legittimazione di comportamenti, stili, mode.
In questa prospettiva appariranno quindi discutibili le 'connotazioni di classe' del festivo, spiegabili quali acquisizioni di epoca borghese e altrettanto criticabile la contrapposizione tra festa urbana e festa rurale, frutto anch'essa di una percezione ottocentesca e borghese di pensare questa relazione.
Nei contesti locali contemporanei i flussi delle merci delle società consumistiche occidentali sembrano modificare al suo interno la struttura stessa della festa che sostituisce elementi della tradizione locale - penso al caso delle bande musicali - con elementi introdotti dall'esterno, presi in prestito dal mercato e dai circuiti del loisir urbano - penso ai gruppi rockettari, alle band musicali cittadine - . Mentre, nelle realtà metropolitane, dall'avvento della cultura di massa, la festa che si realizza in molti casi con grandi raduni di gente, e molto spesso organizzata per la 'visione’ di uno spettacolo da parte di migliaia di persone anche molto lontane dal luogo dove l'evento si svolge: la 'festa come fenomeno mediatico' sembra contrapporsi nettamente alla 'festa tradizionale’, all'avvenimento festoso che si svolgeva nelle piazze delle città antiche, dei villaggi.
Eppure la città come 'specchio magico', nel quale in un'eterna dimensione di festa, sia possibile vedere tutto il passato della città nella 'messa in scena' del presente non è un'invenzione della post-modernità.
Forse, come ci ha suggerito A. Buttitta, dobbiamo pensare il festivo, in base ad una prospettiva connessionista, più nella sua relazionalità al quotidiano, che nella sua perimetralità, più nel suo rapporto con l'intero disegno dello scenario sociale nel quale si inserisce, «...che nel suo solitario risplendere di tessera di un variopinto mosaico». Questo, vorrei aggiungere, non implica affatto il disconoscimento del suo carattere di liminalità2 - il festivo è, anche per questo, il luogo ideale della sperimentazione del nuovo, della prova senza appello, della consacrazione o del flop.
Partendo da questi presupposti individuerò alcuni particolari caratteri della festa che ad un'analisi comparativa di forme espressive e di tempi di realizzazione documentano, a mio avviso, di questa sostanziale continuità di senso che alla festa deve essere attribuita, nell'ambito della nostra cultura.
Contaminazioni
Nelle più antiche forme di celebrazione del festivo troviamo elementi di contaminazione culturale, riadattamenti di modelli scenici e di rappresentazioni proprie di altre società e culture. È certamente nota l'origine etrusca3 dei Ludi romani. Questi erano divisi in tre specie, scenici o teatrali che comprendevano commedie, canti e balli, anfiteatrali, costituiti di combattimenti tra gladiatori o tra uomini e fiere e circensi, i più ricchi e fastosi, che consistevano in corse di carri. Nelle edizioni allestite dai romani questi ultimi giochi divennero un vero e proprio momento di celebrazione della romanità, infatti le corse di carri a due ruote tirati da due o quattro cavalli che avvenivano nell'area del circo, come il Circo Massimo, erano precedute da sacrifici e processioni nelle quali si mostravano al pubblico i simulacri delle divinità mentre le autorità romane intervenivano alla parata e presenziavano allo svolgimento dei giochi.
La festa urbana nella Roma imperiale costituì nell'antichità lo scenario massimo della complessità e multiculturalità degli scambi commerciali che avvenivano tra la capitale dell'impero e le città ad essa sottoposte grazie all'acquisita supremazia marittima. All'epoca del basso impero Roma non aveva meno di 12 tra circhi ed anfiteatri ma si ha notizia che, in Italia, in quell'epoca i circhi fossero diffusi in quasi tutte le regioni e i romani stessi amavano allestire circhi in tutti i paesi che cadevano sotto il loro dominio. Importavano le loro tecniche costruttive ma al tempo stesso recepivano usanze e tradizioni locali, orientali, del nord Africa, ispaniche: ne sono testimonianza teatri e circhi costruiti in Mauritania, Spagna, in Portogallo, Gallia, Germania, Turchia, Siria, Palestina, Egitto, ecc. Fu proprio Augusto ad organizzare presso il circo Flaminio addirittura una caccia di coccodrilli durante la quale furono uccisi trentasei animali.
Il gusto dei romani per l'esotico non si limitava al possesso e all'esibizione di un variegato 'bestiario' ma si esprimeva nella ricerca di oggetti, prodotti e rarità provenienti dalle colonie. Gli storici4 hanno messo in luce la tendenza di civiltà come quella romana, all'acquisizione di beni voluttuari dai paesi stranieri, come la seta cinese o le perle della penisola arabica o l'ambra dai paesi germanici o, ancora, il carminio e l'alabastro dalla Siria e dalla Palestina. Ho avuto modo di illustrare5 come l'incremento di questi beni esotici contribuì alla diffusione di stili di vita e gusti estranei alla sobria cultura di una Roma che era stata repubblicana. I ceti sociali più abbienti proprio attraverso la riscossione dei tributi dalle popolazioni sottomesse, si nudavano liberando dai vincoli della terra e iniziarono ad accumulare la cosiddetta ricchezza mobile. Ma queste prerogative dovevano essere esibite: la ricchezza come la munificità e la clemenza dell'imperatore dovevano rendersi visibili e trovare il luogo della loro legittimazione. Questo avveniva nella cosiddetta Pompa, una sontuosa processione che accompagnava le funzioni pubbliche. Ovidio la definì aurea proprio per il carattere di maestosità che contraddistingueva il comportamento dei nobili a cavallo, dei fanti dell'esercito, dei generali, dei consoli e degli imperatori che guidavano il corteo addobbati con i loro abiti scarlatti fregiati d'oro, i loro pennacchi ed elmi.
La liminalità della festa si esprime, a mio avviso, anche nella particolare spettacolarità della parata: essa, in una esposizione temporale limitata e circoscritta, permette ai partecipanti di mostrare le insegne che indicano la loro provenienza e consente la manifestazione delle proprie qualifiche di rango. La struttura della festa, nella sua ritualità programmata, esprime una formidabile capacità di legittimazione, di riconferma. Era così nelle società cosiddette etnologiche - penso al Potlach degli indiani del Nord-America e al Kula Trade dei trobriandesi di Malinowski - e lo è oggi quando in una parata di stelle cincmatografiche la diva del momento deve apparire in una posizione ed in un contesto magico, superlativo, per riaffermare il proprio raggiunto successo.
I giochi che si svolgevano nella piazza, nei circhi consentivano l'esibizione dei personaggi-attori, gladiatori, ma anche cacciatori, atleti, ginnasti, indovini, venditori, saltimbanchi. In particolare si dovrà ricordare come ciò che consentì una totale visibilità della scena e dei suoi protagonisti fu l'innovazione introdotta con la costruzione degli anfiteatri. Questa permetteva, infatti, di ammirare l'intera area dello spettacolo in una visione tridimensionale in quanto lo spazio dedicato agli spettatori correva tutto intorno all'arena centrale. Negli spettacoli di piazza contemporanei, soprattutto quelli organizzati per gruppi rock, o nei famosi rave, il palco dove si esibisce il gruppo musicale, glistrumenti, le luci vengono spesso poste al centro della piazza o dell'area scelta per lo spettacolo proprio perché la vista e l'ascolto possano raggiungere in modo uguale ed efficace tutte le zone occupate dagli spettatori.
Multifunzionalità
II fatto che oggi le grandi città e soprattutto le piazze vengano utilizzate per allestirvi spettacoli spesso concentrati su un evento multimediale non deve apparire come un esito del processo di massificazione della cultura. Anche durante la Roma imperiale nei circhi che occupavano grandi aree del territorio urbano come il noto Circo Massimo, il Circo di Caracalla sulla via Appia ed altri non si effettuavano soltanto giochi. Nei periodi nei quali non erano indetti giochi questi grandi spazi svolgevano altre funzioni, pubbliche e religiose; il popolo vi allestiva i propri mercati di prodotti locali, di carni e di prodotti stranieri, di stoffe e spezie, creme, unguenti, colori, porpore, pelli e metalli. Gli stessi giochi una volta indetti dovevano essere preceduti da tutta una serie di cerimonie propiziatone che variavano in relazione al personaggio mitologico al quale erano destinate e al tipo di gara - corse di carri, giochi di lotta o di pugilato.
Le tecniche costruttive dei Romani erano altamente specializzate ma quello che più ci colpisce era appunto la polifunzionalità degli ambienti e delle strutture e la grande capacità di trasformazione che gli architetti dell'epoca mostravano nell'adattare uno stesso spazio per molteplici e assai diverse occasioni. Abbiamo sculture e monete di epoca imperiale romana che testimoniano di questa multifunzionalità: agli Orti Sallustiani, a Trastevere e in prossimità della Porta Flumentana in via Flaminia furono spesso allestite nei circhi addirittura delle naumachie o battaglie navali''.
Roma imperiale era una città multiculturale, porto e rifugio di genti, centro dell'Impero: la festa era la celebrazione di tutto ciò. La ricostruzione di atmosfere romane tardoimperiali nelle azzardate scenografie della cinematografia contemporanea - penso in particolare alla saga di Guerre stellari di G. Lucas con la famosa 'Corsa dei gusci' che riecheggia la leggendaria 'Corsa delle bighe' del più datato Ben-Hur di B. Cecil de Mille - non rappresentano affatto una forzatura del documento storico relativo allo svolgimento dei tornei nell'antichità. Bensì un comprensibile tentativo di leggere il futuro con chiavi di lettura a noi note e questo dimostra ancora una volta la interconnessione degli elementi costitutivi della festa e la loro transtemporalità.
In effetti il desiderio di un'ecumene globale e il sentimento di unione universale non sono stati sempre motivo fondante della festa. Gli spettacoli profani, le pantomime e le giostre furono per lungo tempo, almeno fino al XIII secolo un campo di battaglia. Anzi questi si prestarono quali arene dove sperimentare le nuove armi, lance, giavellotti, spade, nuovi trucchi, marchingegni, trappole che permettevano ad una fazione o ad un giostratore di avere la meglio sull'avversario. Il rispetto per la vita umana e la conquista dei diritti del condannato dovrebbero avere privato, per sempre, la messa in scena di eventi così drammatici come quello della morte di individui, di quel carattere di spettacolarizzazione che l'esecuzione ebbe, in Europa, fino al secolo XVI. Tuttavia è notizia certa che alla fine dell'anno passato ben 11 persone sono state giustiziate nella regione centrale cinese dello Wuhan e l'esecuzione è avvenuta alla presenza di una folla festosa ed esaltata dall'avvenimento7. Anche se negli ultimi due anni le lapidazioni a Teheran si sono diradate occorre ricordare che negli anni bui del Khomeinismo la lapidazione era uno spettacolo usuale tant'è che nel 1989 undici persone vennero massacrate all'interno di uno stadio, perché adultere, alla presenza di decine di migliaia di spettatori esultanti. Ancora oggi, nel nostro mondo civilizzato strutture che ospitano solitamente avvenimenti sportivi o al più adunanze politiche hanno costituito, all'occorrenza, lugubre scenario di massacri deliberatamente programmati per il sadico godimento di folle impazzite (Cile di Pinochet).
Queste comparazioni, forse non troppo azzardate, meritano a mio avviso qualche spunto di riflessione: cosa anima la festa, cosa spinge migliaia di persone a radunarsi per seguire un simulacro, un immagine, acclamare uno sconosciuto che si dimena al centro di uno stadio circondato da accoliti mascherati in preda a raptus musicali? Cosa attirava folle acclamanti nei circhi per assistere agli strazi di vite umane sbranate da fiere affamate o dilaniate da orribili strumenti di tortura? Una certa interpretazione antropologica ha voluto attribuire alla festa funzioni di liberazione, di trasgressione, di inversione dei ruoli: la rottura con tutto ciò che è norma, consuetudine e al tempo stesso l'ingresso nella sfera dell’imprevedibile, dell'esaltazione, dell'eccesso.
Saggio tratto dal volume di A. Arino e L. M. Lombardi Satriani (a cura di), L’utopia di Dioniso. Festa tra tradizione e modernità, Roma, Meltemi, 1997, pp. 137-147.
Con il passare del tempo, in sostanza, tutta la parte di preparazione dell'evento, le cerimonie di apertura e presentazione dei concorrenti e quelle di chiusura e celebrazione dei vincitori, ovvero la parte che oggi definiremmo più mediatica, divenne, proprio per il coinvolgimento popolare che promuoveva, l'essenza della festa stessa. Nello spettacolo di massa contemporaneo, la messa in scena dell'evento costituisce quasi sempre l'aspetto più spettacolare, più seguito, più coinvolgente per gli spettatori presenti e per quelli a distanza. Le parate di apertura e chiusura dei Giuochi Olimpici e dei numerosi campionati internazionali di foot-ball come le parate dei circhi americani, le performances elettorali statunitensi, i 'cortei storici' delle città medioevali italiane, le parate dei grandi raduni di collezionisti ormai praticati in tutto il mondo costituiscono oggi altrettante occasioni di festa. In queste, anche se tutto l'allestimento si basa su una organizzazione altamente computerizzata che lascia all'individuo singolo ben scarso livello di partecipazione diretta alla fase di realizzazione, in realtà il coinvolgimento emotivo della massa, in molti casi vero e proprio tifo, non può definirsi inferiore a quello degli antichi spettatori di tornei e giuochi circensi.
L'apparire
Emblematico di quanto l'evento festivo offra occasione di legittimazione sociale e convalida di identità culturale presso le diverse culture è il ruolo e la funzione svolti dalla danza, che si inserisce nella rappresentazione della festa come fattore scenico determinante. Ma essa, come vedremo, ha inoltre costituito da sempre un fondamentale dispositivo per comunicare attraverso la sua forte carica simbolica, valori, incentivi, intenzionalità, attenzione da parte del gruppo sociale e favori da parte delle divinità. Nella "messa in scena” della danza, fin dai tempi della danza d'imitazione animale, si sviluppa una delle più semplici figure coreografiche: il cerchio. La funzione simbolica di questa figura è evidente. I danzatori ballano intorno ad un centro immaginario verso il quale sono protesi. L'antropologo E. De Martino ci ha indicato l'enorme importanza, nel costituirsi della struttura culturale di un gruppo, rappresentata dal riconoscimento di un punto di riferimento fisso (es. il Palo degli Achilpa)8. Le cosiddette 'danze della caccia' espresse nelle raffigurazioni neolitiche in alcune grotte della penisola iberica rappresentano uomini che danzano intorno a figure di animali. Nelle danze dei pigmei africani il girare dell'uomo intorno alla donna e della donna intorno all'uomo imita il corteggiamento, istigando ad esso; al tempo stesso le danze femminili della fecondità inscenate durante i riti matrimoniali presso una tribù beduina (Bdul) nel Sud della Giordania, accompagnate da canti ritmati dal battito delle mani, si strutturano in forma circolare9. Queste, come le 'danze della guerra’ diffuse presso gli Indiani del Nord America, si configurano come danze augurali, esibite prima di qualche impresa vitale per la sopravvivenza del gruppo.
La danza ha dunque stigmatizzato fin dall'inizio atti della vita quotidiana verso i quali si intendeva far convogliare energie, influssi positivi umani e divini. È possibile quindi riconoscere alla danza, espressione di vitalità ma al tempo stesso momento celebrativo di atti importanti nella vita dell'uomo, un insieme di funzioni trasversali al quotidiano e al festivo, quella capacità di rendere eccezionale il consueto, di convogliare desideri e aspirazioni, esaltando i caratteri identitari del gruppo e raccogliendo consensi.
Nelle contemporanee società metropolitane il fenomeno delle discoteche ha prodotto l'esibizione della 'cubista', giovane e sinuosa adolescente che, abbigliata secondo i canoni della moda teen-ager del momento, volteggia su un enorme cubo di plexiglass collocato in posizione strategica al centro della quinta dove è collocata la band musicale. I fasci di luce multicolore saettano mettendo in evidenza le linee del corpo che si muove al ritmo incalzante della musica tecno, dark o semplicemente dance. L'apparire della cubista coincide con il momento clou della serata, ne sottolinea la tensione emotiva che coinvolge giovani donne scatenate dall' esprit de imitation e altrettanto giovani uomini anelanti essi stessi a rendersi protagonisti della scena; consente ad aspiranti, ancora sconosciute, future vedette - si rammenti anche il caso delle tanto chiacchierate veline televisive - di mettersi in mostra, di rivelare il loro talento in attesa di una scena più autorevole sulla quale realizzare la definitiva consacrazione.
Ma questa funzione propagandistica svolta dalla danza attraverso lo strumento dell'apparire non è certo un'invenzione della società contemporanea. Le danze augurali popolari e aristocratiche del XVII secolo ne sono un esempio. Ricorderò per tutte il ben noto ballet de la nuit nel quale il sovrano Luigi XIV impersonando il Sole si guadagnò l'appellativo di Re Sole. La predilezione di Luigi per il balletto rese il minuetto, forma di danza che si andava diffondendo in Francia in quel periodo"1, famoso presso tutte le corti europee dell'epoca: 'vedere il re ballare' rientrava in quella duplice funzione del cortigiano che, da un lato era obbligato ad essere presente a tutte le regali esibizioni, per compiacere il sovrano ed esaltarne la bravura, la leggiadria, il portamento, dall'altro guardava per imparare, per avvicinarsi almeno un poco allo stile impareggiabile del sovrano. La capacità di influenzare e di orientare i presenti che all'esibizione dei solisti si intende riconoscere ancora oggi, era allora assicurata dal fatto che tutte le manifestazioni e le cerimonie che, numerose, davano spunto alla indizione di feste, avevano un carattere pubblico ed altamente celebrativo della magnificenza e munificità del signore.
In un mio recente lavoro11 ho mostrato l'importanza che ebbero, all'indomani della riconquista delle vie commerciali dopo le guerre con l'Islam, i contatti ristabilitisi tra le signorie, gli imperi, le repubbliche marinare italiane e i paesi orientali, da quelli di lingua araba all'estremo oriente. Il commercio sempre più intenso tra le regioni dell'Europa continentale e i paesi orientali portava con sé e mostrava nelle fiere, favorite dal sistema delle franchigie, insieme ai beni voluttuari, alle spezie e alle sete, la espressività, la ricercatezza e la musicalità caratteristiche di altre popolazioni. Le corti europee affamate di novità, in prepotente ascesa, desiderose di primeggiare e di raccogliere consensi accolsero gli artisti - giocolieri, maghi, danzatori - facendoli esibire soprattutto nelle feste che per giorni seguivano i grandi eventi cerimoniali quali i matrimoni principeschi, i tornei, le investiture.
Nasceva così il 'balletto conviviale’ durante il quale le danzatrici si introducevano con le loro danze tra una portata e l'altra del banchetto nuziale. La scenografia rinascimentale delle corti inaugura la rappresentazione profana tematica che include tutta una serie di elementi scenici, coreografici e narrativi costruiti intorno ad un tema centrale che poteva essere un mito, una leggenda o un valore condiviso come la 'fedeltà coniugale’, durante i matrimoni, appunto. Qui la danza manifestava la sua connaturata potenzialità espressiva e normativa mimando sentimenti, desideri o rappresentando vicende che documentavano il tema prescelto.
A mio avviso, è proprio seguendo l'evoluzione delle tecniche sceniche di allestimento della festa e la storia del modo di porsi dei partecipanti all'interno delle diverse fasi di costruzione dell'evento che è possibile rintracciare i fattori di rottura e al tempo stesso gli elementi di continuità del tessuto narrativo della festa stessa. Un approfondimento della tematica della danza, ad esempio, ci consente di puntualizzare l'importanza che deve essere accordata al luogo di esecuzione di questa forma di spettacolo, quale parte integrante della festa. Finché la danza profana ebbe luogo nella pubblica piazza essa fu essenzialmente danza popolare. Dal 1400 con il costituirsi della cosiddetta 'Società di Corte' si operò lo stacco definitivo tra danza popolare e danza colta: la professione del perfetto cortigiano prevedeva, infatti, l'apprendimento e la pratica della danza.12 Il luogo della rappresentazione della festa è dunque fondamentale nel determinare non solo il ruolo che la danza cominciò a svolgere nell'ambito del nuovo assetto che la società si stava dando ma anche nel configurare la nuova percezione culturale che si venne strutturando dell'intrattenimento stesso. Questo diventa esclusivo e ripetibile al di fuori di una programmazione calendariale stabilita in base all'ordine delle celebrazioni rituali del ciclo produttivo e degli eventi civili. Se ne appropria una classe, quella aristocratica che, in particolare con la dinastia dei Borbone in Francia tra il XVII e il XV111 secolo ne farà strumento di potere. Le esibizioni vengono allestite nei castelli, nelle grandi sale multifunzionali dove tra le tante pratiche connesse alla vita di corte venne inserita la 'lezione di Danza' che i cortigiani e il re stesso si facevano impartire dal maestro, nuova figura, che si affiancava ai numerosi artisti protetti dal principe.
Nelle società contemporanee, la festa mediatica ha risolto questo stacco durato un paio di secoli proiettando la dimensione privata della festa e dell' orgia comunicativa nei circuiti televisivi seguiti da milioni di telespettatori (Grande fratello) e introducendo nella stessa dimensione pubblica della festa l'elemento della solidarietà, della propaganda finalizzata a scopi umanitari (concerti di beneficenza come Pavarotti & friends, ecc.).
In queste più recenti trasformazioni della festa con le quali si tende a reintrodurre l'elemento della spontaneità, dell'immediatezza nei linguaggi e negli accorgimenti scenici (i personaggi parlano, vestono e gesticolano mimando se stessi nella loro quotidianità, mentre le vedette internazionali si presentano spogliate del loro contorno scenografico abituale e dell' accompagnamento coreutico-strumentale), ritroviamo caratteri propri dei primi allestimenti scenici di corte. Lo rileviamo per l'abbigliamento, formidabile strumento di comunicazione di valori e norme di comportamento ampiamente condivisi. Nei Piccoli Appartamenti di Versailles dove Luigi XV allestiva, ispirato dalla famosa maitresse-en-tritre Madame du Pompadour, le prime rappresentazioni teatrali di corte, i costumi indossati dagli aristocratici personaggi non erano ancora costumi di scena ma facevano scena: ad esibirsi erano gli stessi cortigiani e i componenti della famiglia reale che, a rischio di vedere impedita la scioltezza dei movimenti, per l'occasione della rappresentazione, indossavano abiti di tutti i giorni ma ancora più sontuosi e imponenti.
L'elemento scenografico costituito dal costume, nella festa, costituisce in tutte le culture fattore di trasmissione di modelli culturali che, con la festa, si vogliono sostenere, diffondere o semplicemente consolidare. In Albania, ad esempio, alcune danze popolari praticate nelle più importanti ricorrenze nazionali o etnico-locali sono particolarmente conosciute ed apprezzate proprio per l'esibizione dei ballerini che indossando costumi coloratissimi e impreziositi da fili e ornamenti d'oro. Ce li descrive lo stesso Lord Byron nel suo Childe Harold’s Pilgrimage indicando come l'esibizione arricchita da una scenografia particolarmente curata contribuisca ad attirare l'attenzione degli astanti sui gesti e sulla mimica di una danza, la cosidetta Vallja, che si balla con tutte le parti del corpo.
La sorpresa
Altro elemento interno allo statuto della festa in tutte le società, più o meno sollecitato da diverse condizioni socio-culturali e ambientali nelle quali la festa si svolge è certamente quello della sorpresa. È fuori di dubbio che nelle moderne società della comunicazioni di massa la soglia dello stupore si sia notevolmente elevata: il mondo esterno ci deflagra quotidianamente sotto gli occhi e lo spettatore è ormai abituato a non sorprendersi più tanto facilmente. Nei ludi cruenti delle lotte tra gladiatori o nelle carneficine dei cristiani sbranati nelle arene romane, lo stupore e la suspence erano legati alle modalità con le quali un esito già scontato in partenza - la morte di uno dei combattenti o la straziante agonia di corpi lacerati da belve affamate - sarebbe stato realizzato. L'elemento esotico - la belva - accompagnato a quello del diverso -il cristiano - rappresentavano fattori fondamentali della 'messa in scena'.
Quando ai giuochi cruenti si sostituirono le giostre e queste andarono ad arricchire le feste civili dalle quali per lungo tempo (fino al '300) erano state separate, e quando con l'avvento delle signorie e dei principati si fecero più frequenti i motivi dei festeggiamenti organizzati anche solo per celebrare il ritorno del Signore da una battaglia o la visita di una principessa straniera, ci si dovette ingegnare per realizzare in modo sorprendente ma non violento l'elemento della sorpresa. Nel 1342 Stefano Colonna, a Roma, durante le feste di Carnevale fece riempire le tazze delle fontane in Campo de’ Fiori con cibi e ogni prelibatezza, per la sorpresa e l'entusiasmo della popolazione tutta. Ripristinò addirittura una tauromachia che venne disputata sulla piazza del Campidoglio. Nelle feste di Carnevale del 1500 Cesare Borgia fece sfilare in piazza Navona, a Roma, undici carri allegorici ispirati ai trionfi di Cesare. L'opposizione della Chiesa, che d'altro canto non ci teneva troppo a scontentare il popolo, per gli spettacoli che non avevano valore civile o religioso fu contenuta con l'espediente di sostituire le comparse con sculture meccaniche, nelle cerimonie delle processioni, nelle rappresentazioni dei Misteri e nelle realizzazioni dei cosiddetti Presepi viventi.
Il tema della sorpresa ci rinvia ai riti iniziatici presenti nelle culture delle società tribali dove frequentemente la sorpresa era costituita dalla fuoriuscita di un personaggio animato da un involucro materiale o da un oggetto naturale come la cavità di un albero o di un enorme guscio. Questo espediente scenico verrà ripreso in molte società e diventerà nel Rinascimento il momento culminante del banchetto festivo. Il banchetto, infatti, non costituiva un avvenimento legato essenzialmente al cibo ma era l'occasione per sbalordire attraverso l'uso di tutti e cinque i sensi: la vista si saziava della ricercatezza nel decorare il corpo da parte di uomini, donne, danzatori che gareggiavano nell'impreziosire i loro abiti, l'udito si deliziava nell’ascoltare melodie dolcissime, l'olfatto era soddisfatto nell'odorare profumi delicati di vivande, frutti abbondanti e petali di rose. I festeggiamenti per un avvenimento come le nozze di un principe duravano anche molti giorni e numerose persone erano coinvolte e nei preparativi e nei festeggiamenti stessi come i paggi e le damigelle d'onore. A proposito della discriminante di classe attribuita spesso alle forme del festivo è bene sottolineare che nella società medioevale e rinascimentale individui di bassa estrazione sociale venivano impiegati nella realizzazione della festa, pure non appartenendo al ceto aristocratico. Questi che non potevano sperare per se stessi in una cerimonia simile trovavano, nell'occasione della festa, motivo per uscire dal chiuso del loro ambiente, per comunicare, per fare esperienza anche se solo visiva di consumi e prerogative che non appartenevano loro ma che al tempo stesso seducevano e attiravano per la loro esclusività. Raffigurazioni e miniature dell'epoca ci mostrano contadini e popolani che danzano abbigliati per la festa, nonostante la condizione sociale imponesse quotidianamente un abbigliamento più pratico e adatto al lavoro manuale.
Al tempo stesso mi preme sottolineare che il costume di allestire sontuosi banchetti nel clima della festa non risulta essere stata una prerogativa dei regimi signorili: anche le antiche repubbliche come quella di Siena mostrano, dai documenti conservati, di aver prestato attenzione a questi espedienti per fare bella figura con gli aristocratici. Gli storici ci raccontano, infatti, che nel 1465 passò da Siena, alla volta di Napoli, Ippolita Sforza, figlia del Duca di Milano, che andava sposa ad Alfonso d'Aragona principe di Napoli. La repubblica per sbalordire la duchessa allestì un banchetto con spettacolo danzante e mentre venivano serviti dolci e marzapane apparve sulla scena una grande statua di legno raffigurante una lupa, simbolo della città. Nel suo interno cavo erano nascoste sei coppie di ballerini che ad un segnale uscirono fuori cantando e ballando.
Come ho già ricordato il periodo della festa è stato visto dagli antropologicome il momento nel quale, compiacente l'autorità, tutto è possibile, anche l'inversione dei ruoli o l'accadimento miracoloso - a Napoli, è l'evento della liquefazione del sangue del Santo a promuovere l'enorme impianto organizzativo della festa di S. Gennaro o è la stessa esaltazione popolare e la tensione emotiva che l'attesa dell'intera città suscita a fare sì che il miracolo si riproduca? - In realtà finita la festa tutto ritornava al suo posto e ognuno riconquistava la posizione che occupava prima dell'inizio dei festeggiamenti. Deve ritenersi importante, tuttavia, da un punto di vista anche pedagogico, che l'aver potuto partecipare dell'eccezionalità dell'evento, l'aver potuto vedere, sentire, godere delle stessa magnificenza della quale il principe si gloriava quotidianamente, dava al singolo l'impressione di esserne stabilmente parte. I carri allegorici, gli addobbi delle strade, gli archi di trionfo erano approntati da comuni cittadini che mettevano la loro abilità e le loro conoscenze tecniche e artigianali al servizio del principe che avrebbe da ciò tratto vanto e potere.
Nella società contemporanea, l'accesso illimitato ai mezzi di comunicazione di massa come la televisione non solo ha reso assolutamente permeabili le barriere sociali per ciò che concerne l'informazione ma, soprattutto, ha consentito l'acquisizione immateriale di beni e servizi attraverso la distribuzione globale della loro immagine. La festa mediatica viene continuativamente servita da una molteplicità di canali televisivi che al tempo stesso duplicano, triplicano l'evento che, oltretutto, può essere automaticamente registrato da sofisticate apparecchiature programmate dall'individuo per questa funzione, qualora egli non abbia la possibilità di assistervi in diretta.
Cosa potrà più sorprendere il disincantato telespettatore? Quale forma di spettacolo sarà orchestrata in modo tale da suscitare l'entusiasmo di un audience ormai abituata a poter selezionare, digitando (ma forse tra breve, (anche soltanto pensando) la rete che soddisfi le sempre più esigenti richieste? Quale trovata sarà così coinvolgente da trascinare la massa la quale, piuttosto che partecipare sembra preferisca assistere all'evento della festa dai maxischerini che ormai sempre più frequentemente trasmettono in presa diretta ciò che accade, magari anche a pochi metri dal luogo dove la manifestazione si sta svolgendo?
Un tempo era il sovrano o il signore a decretare l'approvazione di un espediente scenico o a favorire l'applicazione di una nuova tecnica di allestimento teatrale.
Ricordo come l'avvio della fortuna di Versailles come centro della vita di corte del regno dei Borboni in Francia fu favorito dalla decisione che Luigi XIV prese nell'assistere alla sorprendente festa organizzata dal suo soprintendente Fouquet nel castello di Vaux. Tutto l'apparato scenografico negli splendidi giardini all'italiana del sontuoso castello, il banchetto organizzato da quell'infaticabile e creativo Vattel maestro di cerimonie, i giuochi di luci ed acque che fecero risplendere i colori delle sete damascate che avvolgevano preziosamente le trecento dame presenti e, infine, le melodie inconfondibili del Maestro Lulli inebriarono Luigi a tal punto da indurlo a confiscare immediatamente e senza motivo tutti i beni del Fouquet e a trascinare alle sue dipendenze tutte le maestranze e i tecnici che si erano resi artefici di quella magnificenza. Ma, da quanto si racconta, un effetto scenico colpì più degli altri l'immaginazione del capriccioso sovrano: al termine della festa dal limite estremo dell'area antistante il palazzo, dove sdraiati sull'erba o accasciati su qualche chess-long si stavano addormentando cavalieri e dame sfiancati dalle danze protrattesi per tutta la notte, venne proiettata, all'improvviso, verso il ciclo una fantasmagoria di fuochi d'artificio. I guizzi luminosi apparvero così spettacolari nel creare fantastici arabeschi nel buio cupo della notte da essere ritenuti, dagli stessi cortigiani, quanto di più eccezionale e tecnologicamente avanzato si fosse mai visto fino ad allora durante una festa.
La fortuna dei fuochi d'artificio come espediente scenico è durata fino a noi e abbiamo notizia che dopo quasi due secoli dalla prima performance alla presenza del Re Sole, negli spettacoli che venivano messi in scena all'Augusteo di Roma e raccontati dalle celebri stampe del Thomas, il momento culminante non era dato né da banchetti, ne da danze, ma dai cosiddetti ‘fochetti’, ovvero fuochi d'artificio piazzati al centro dell'arena.
L'eccitazione prodotta da esplosioni, fuochi e faville accompagnati dallo schioppettio delle micce stesse o di vere e proprie armi pare essere indissolubilmente legata all'esecuzione della festa, alla sua messa in scena e, può apparire contraddittorio, anche alla fase finale della festa stessa. Pare fosse benaugurante la tradizione illustrataci da un'incisione di Hyalmar Morner per il Carnevale di Roma del 1820, che consisteva in una vera e propria battaglia di moccoletti che lungo il Corso da piazza del Popolo a piazza Venezia venivano accesi, forniti da venditori ambulanti, al grido 'muoia ammazzato chi non porta il moccolo!'. I romani festaioli si affrettavano a impadronirsi di uno di questi moccoli e lo portavano correndo avanti e indietro per il Corso dando l'impressione che la via fosse in fiamme. Si celebrava, con questo carosello spettacolare, l'ultima ora del Carnevale e il giuoco consisteva nel cercare di spegnere il moccolo del vicino in un atto di ribellione verso quell'ineluttabilità che andava imponendo la fine della festa. Nelle società nomadi di cultura islamica l'evento eccezionale, l'arrivo di una buona notizia, la nascita di un figlio vengono da sempre festeggiati con spari di fucili, diretti verso il cielo; oggi ciò crea grande disappunto e apprensione da parte dei vicini di quei gruppi che, ormai in fase di sedentarizzazione, tuttavia stentano ad abbandonare questa usanza.
A questo proposito propongo all'attenzione qualche recente rivisitazione di antiche usanze osservata all'interno di cerimonie e riti di passaggio dai più, oggi, praticati secondo modelli e dispositivi suggeriti dalla modernità. Soprattutto in ambiente urbano nelle scenografie oggi curatissime, anche ai livelli economici più bassi delle classi sociali, che fanno da sfondo a matrimoni, anniversari, ricorrenze, si è ripreso a fare uso delle candele, grandi, piccole, finemente decorate, di candelabri, antichi, di famiglia, d'argento, barocchi, o semplicemente di reggicandele, spesso in totale sostituzione dell'energia elettrica, per tutta la durata del festeggiamento. Cosa ci suggerisce questo romantico revival, se non l'idea che l'individuo postmoderno sia alla ricerca, se non di una inaccessibile autenticità dell'esperienza, ormai dispersa nella inebriante molteplicità delle modalità d'uso degli oggetti, almeno della possibilità di ricreare scenari adatti a realizzarla - ciò che era naturale diventa artificiale nella destrutturazione di un mondo codificato al di fuori di noi, da macchinari intelligenti che - quando non entrano in tilt - ci forniscono a comando luce, calore, freddo, tepore, fiamme sintetiche, pioggia artificiale, ventilazione magnetica, effetti speciali.
L'eccesso
Il carattere di liminalità della festa si rivela anche sotto la forma dell'eccesso. Nella festa sia rurale che urbana, sia antica che moderna, sia augurale-celebrativa che rituale - di investitura tutto è permesso, anzi l'eccesso nella gestualità propiziato da un abbigliamento sproporzionato, ricco di ornamenti, di orpelli suonanti è motivo di orgoglio per gli organizzatori e realizza uno dei topoi fondamentali della festa: la sua rappresentatività scenografica.
Una famosa incisione di Bartolomeo Pinelli dedicata alle maschere del carnevale romano descrive perfettamente questo desiderio di sbalordire lo spettatore con l'eccesso delle forme. Tutto è marcato, eccessivo nei tratti del disegno del Pinelli. L'abbigliamento: il nano vestito da Napoleone indossa un cappello dieci volte più grande del necessario: gli abiti delle altre maschere sembrano complessivamente di alcune misure superiori rispetto alle dimensioni delle persone, gli oggetti stessi che caratterizzano le maschere come la parrucca o il cappello, ma anche gli strumenti musicali o meccanici della festa come le grandi cornamuse o i lanciasassi sono raffigurati in dimensioni sproporzionate per poter apparire, appunto, eccessivi, attirare l'attenzione, provocare.
Dagli atleti e funamboli della seconda metà dell'Ottocento che si destreggiavano nei teatri e nei circhi delle capitali europee e occidentali alle esibizioni dei mangiatori di fuoco dello Sri-Lanka (Sama Ballet) che, inseriti oggi nei circuiti internazionali dello spettacolo folkloristico, globalizzano forme locali di spettacolo iniziatico, l'eccesso si è spesso presentato come esercizio fisico e acrobazia di saltatori, prestigiatori, cavallerizzi. I numeri eseguiti all'interno di teatri e circhi erano sostanzialmente quelli eseguiti in precedenza nelle pubbliche piazze; il circo stabile, costruito in muratura come il famoso Alibert di Roma distrutto da un incendio nel 1863, consentiva la rappresentazione di giuochi ed esercizi di difficilissima esecuzione come i numeri d'equilibrio, ma al tempo stesso affiancava alle esibizioni acrobatiche dell'arena, commedie, feste carnevalesche, balletti, melodrammi, favoriti dalla efficiente attrezzatura che atleti, ballerini e funamboli vi potevano trovare.
Per lo sviluppo delle tecnologie dello spettaeolo l'esperienza circense fu fondamentale: lo rileviamo dalle rappresentazioni acrobatiche, dalle pantomime attraverso le quali si cercava di ricostruire con portentosi accorgimenti scenici, un evento storico realmente accaduto come le battaglie, le avventure piratesche ecc. Non è un caso che alcuni discendenti della famiglia circense dei Guillaume, lavorarono anche nel primo film muto come il popolare Polidor. In sostanza II cosiddetto mimodramma militare, come la parata e il carosello storico, e i giuochi nelle arene durante le feste, rappresentò probabilmente un modello per il futuro cinema che impiegò, in particolare nella fase del muto, imponenti mezzi scenici per realizzare in modo assolutamente realistico le imponenti ricostruzioni della Roma imperiale.
Attraverso queste innovazioni, nei contenuti della rappresentazione scenica inserita nella festa, ma soprattutto nelle tecnologie che consentirono il passaggio dall'immediatezza della logica della rappresentazione alla sua riproducibilità attraverso lo strumento della macchina da presa (kinetoscope) e del proiettore, la festa, da spettacolo circoscritto in un tempo e in un luogo prestabilito in base ad un ciclo calendariale rigidamente strutturato, si avvia a diventare agli albori del XX secolo, il Greatest Show on Earth (II più grande spettacolo del mondo).
Come ci fa notare Mario Verdone il cinema non ha inventato del nuovo che raramente: il più delle volte ha assunto dalle altre forme di spettacolo i maggiori motivi di attrazione. Nella fiera, nel circo, nei teatri delle pantomime, luoghi della festa itinerante perché strutture mobili essi stessi, si elaborarono tutti gli ingredienti, dall'intreccio, alla sorpresa, all'eccesso, alla risoluzione finale che oggi ci propone la festa mediatica con cinema, fiction, lungometraggi.
Se con i film spettacolari dei primi anni del Novecento la moderna scenografia riconduce la 'messa in scena' dai teatri di posa allo spazio reale, oggi la festa viene nuovamente rifunzionalizzata trasferendo la sfera del privato nella dimensione spettacolarizzata dello scenario pubblico multimediale dove le aspirazioni di ciascuno allo svago e al divertimento trovano risposte codificate dal nuovo lessico della comunicazione visuale. Gadget, souvenir, travestitismi, tatuaggi, trucchi, veri e falsi object-cult rendono chiunque protagonista dentro e fuori della scena: tutto è scena e la festa, talvolta purtroppo una tragica festa, è ovunque.
NOTE
1 Si veda come casi di rifunzionalizzazione di rituali festivi quali il pellegrinaggio, F. Fedeli Bernardini, Il sasso, l'acqua e la foresta: Vallepietra tra natura e cultura e G. Marucci, La litoiatria nei culti micaelici: continuità e persistenze in L. Rami Ceci (a cura di) (2003). Sassi e Templi. Il luogo antropologico tra cultura e ambiente, Roma, Armando.
2 Il concetto di liminalità al quale Victor Turner fa riferimento è preso dallo studio di Arnold Van Gennep su Les rites de passage (Ediz. Nourry, 1908 ), nel quale il limen rappresenta la fase intermedia tra la separazione e la riaggregazione. Il limen, momento che indica la soglia, il vero e proprio passaggio simbolico da uno stato all'altro si adatta molto bene, a mio avviso, a spiegare la condizione di chi partecipa ad una festa, cioè di colui che entra momentaneamente a far parte di una dimensione costruita artificiosamente e che possiede spazi, tempi e regole suoi propri o verso i quali i soggetti devono essere iniziati.
3 Gli Etruschi, sostengono gli storici, fuggiti dall'Asia sotto la guida di Tirreno, avevano edificato città nell'Italia centrale e avevano introdotto, tra gli altri loro rituali, anche gli spettacoli teatrali.
4 Si vedano: F. De Martino (l977), Storia economica di Roma antica, Firenze, La Nuova Italia; J. Carcopino (1997), La vita quotidiana a Roma, Bari, Laterza; M. Petrassi (1985), Gli ori in Italia, Roma.
5 Cfr. L. Rami Ceci, Porcellane, ninnoli e martingale, ovvero l'elogio dell'effìmero, (2002) Roma, Armando, pp. 109-111.
6 Cfr. M. Verdone, Feste e spettacoli a Roma, (1993), Roma, Newton Compton.
7 La notizia è apparsa su Repubblica 27 Dicembre 2002.
8 Cfr. E. De Martino, La fina del mondo, (1977), Torino, Einaudi.
9 Cfr. C. A. Sassayannis, Rituali, spazi e cultura nella tribù Bdul, oggi, in L. Rami Ceci (a cura di,) Sassi e Templi. Il luogo antropologico tra cultura e ambiente, cit., pp. 351-371.
10 Il gusto estetico del Rinascimento fu favorevole alla danza, ma mi sembra importante ricordare che una danza come il minuetto che si impose nelle più raffinate corti europee proveniva dal popolo: ciò rappresenta un'ulteriore conferma di come il desiderio del voluttuario, dell'intrattenimento estetico fine a se stesso non è affatto, all'origine, esclusiva di alcune classi sociali.
11 Cfr. L. Rami Ceci. Porcellane, ninnoli e martingale, ovvero l'elogio dell'effimero, cit. in part. Le vie del lusso, pag. 109.
12 Domenico da Piacenza e Guglielmo Ebreo da Pesaro scrivono trattati sul tema e la danza cessa dì essere improvvisazione e spontaneità per iscriversi nel complesso delle attitudini e nel catalogo delle cosiddette "buone maniere" che distinguevano l'uomo di corte dal popolano e dal villano.
La festa tra folklore e fakelore
Paola De Santis Ricciardone
Finalmente domenica
Nell'edizione 2000 della Guida Touring, Artigianale, sapori e tradizioni d'Italia, di ogni regione è offerto un calendario festivo, Gli eventi selezionati e considerati meritevoli di menzione al turista in cerca di autenticità locali, sono "le feste più antiche e documentate della regione". Intatti nella rassegna troviamo la maggior parte delle feste monumentali italiane, dal Palio di Siena a quello di Asti, dai carnevali trentini alla Sartiglia di Oristano. alla macchina di Santa Rosa di Viterbo e così via. Vengono escluse, con pudore aristocratico, la miriade di feste che pure sono nate e continuano a nascere incessantemente a scopo promozionale: sagre, feste e fiere che trovano generalmente occasione in un qualche evento di tipo culinario, enogastronomico, merceologico. Sono feste per promuovere o vendere qualcosa: immagini di accoglienti mete turistiche, prodotti tipici del luogo (castagne, funghi, fagioli, ciliegie e quant'altro), pacchetti alberghieri, artigianato, visite nei musei, in parchi, trattorie e osterie. Tutti eventi viceversa segnalati con dovizia di informazioni nei siti Web delle province, dei comuni, delle regioni e nelle pubblicazioni commerciali per ambulanti: le feste, a prescindere dalla loro "antichità”, sono sempre occasioni di mercato; per un venditore di noccioline la festa dei fujenti della Madonna dell'Arco equivale alla "Sagra delle Fregnacce con la Persa" di Castelnuovo di Farfa. Potremmo definire tali occasioni "pseudo-eventi”, secondo la classica definizione di D.J. Boorstin (1961), profezie che si auto-avverano, promesse che si auto-mantengono: ovvero la celebrazione festiva dell'eccezionalità, della distinzione delle castagne di Soriano del Cimino crea di fatto la loro distinzione o eccezionaiità.
Nella Guida Touring anche la Barabbata di Marta, sempre nel viterbese, ha dignità di menzione. Una festa-capolavoro che ho avuto il privilegio di studiare giusto venticinque anni fa, dal 1978 al 1981 (de Sanctis R.P., 1982).
E proprio a ridosso di quegli anni assistevo ad una ingegnosa "invenzione" di una tradizione da parte dei martani. Marta ha un calendario festivo abbastanza ricco, ma sono feste, come appunto la Barabbata (il 14 maggio) o la festa di San Biagio (il 13 febbraio), che cadono in giornate non necessariamente festive. Sono eventi di fruizione locale che richiamano al massimo un osservatorio amatoriale. curioso, devozionale, di studio o di turismo culturale elitario. Quando, raramente, la Barabbata cade di sabato o di domenica il discorso cambia: migliaia di persone dai paesi vicini, da Roma e da altre province sin dall'alba confluiscono nel paesino affacciato sul lago di Bolsena per godersi le meravigliose fantasmagorie di una stage authenticity legata ad un mondo contadino non del tutto smarrito nella sostanza, ma di cui c'è già nostalgia. Per l'osservatore cittadino si tratta di una variante di quella nostalgia "immaginata" su cui si è soffermato Appadurai (1996, pp. 106-107) per cose cioè che non ha mai vissuto e che non ha quindi potuto perdere. Per il pubblico locale o limitrofo, in gran parte agricoltori, allevatori, pescatori, o comunque persone legate alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agro-pastorali, si possono rintracciare forme di ''nostalgia del presente", di cose cioè non perse completamente, come ricorda sempre Appadurai.
Dunque, i grandi sforzi, anche economici cui la popolazione di Marta si sottoponeva per le sue feste genuine, non la ripagavano appieno da un punto di vista turistico-promozionale. Mi raccontarono che un anno avevano provato a spostare la Barabbata in un giorno festivo: a parte le proteste della popolazione, pare che sia anche venuto giù un finimondo di maltempo. Ma ecco che più o meno un lustro fa entra in soccorso lo spurio folklorico con l'invenzione di una nuova festa, la "'Sagra del Lattarino", da tenersi finalmente di domenica, quella successiva alla Barabbata. In quel giorno, un gigantesco padellone, sul modello ormai classico e omologato del kitsch gastronomico finto-rustico, sfrigola i tipici pesciolini lacustri per la gioia dei gitanti domenicali, cannaiola e altri vini locali scorrono a volontà, le trattorie sono piene, gli operatori locali e ambulanti soddisfatti.
Lattarini, spinaci, focacce ed altri incubi dei Volkskundler
Naturalmente sulla Guida del Touring non c'è traccia della Sagra del Lattarino. Nelle odierne guide di taglio raffinato, la cattura dell'interesse turistico può passare attraverso l'offerta di ''attrazioni" presentate come non turistiche, autentiche, dense di storia e destinate ad un pubblico locale (cfr. MacCannell. 2001. p. 27). La strategia di inclusione ed esclusione di eventi e attrazioni da segnalare non è casuale. Essa discende in parte da forme di selezione insite inizialmente nella stessa demologia (cfr. Bendix, 1997, pp. 189-194), che ha in un certo senso fondato e costruito l'oggetto dei suoi studi sulla scorta di forti dicotomie atte a fugare ogni dubbio su quale fossero i legittimi campi di indagine per altrettanto legittime comunità di studiosi: folklore/folklorismo; Volkskunde/qffentliche Folklore (cfr. Kirshenblatt-Gimblett, 2000); tradizioni genuine/spurie (cfr. Handler e Linnekin, 1984), folklore autentico/falso.
La nozione di Fakelore risale a Richard Dorson, importante studioso americano di tradizioni popolari nato nel 1916 e morto nel 1981. Comparve per la prima volta sull’American Mercury nel 1950, come ricorda Alan Dundes (1989, p. 40). Dorson tornerà più volte su questo concetto sino agli ultimi lavori, tra cui la nota raccolta di saggi del 1976, intitolata appunto folklore and Fakelore: Essays toward a Discipline of Folk Studies. Riprendiamo da Dundes una definizione del concetto di Dorson risalente al 1969:
Fakelore è la presentazione di scritti sintetici e spuri con la pretesa che essi siano folklore genuino. Queste produzioni non sono raccolte sul campo ma sono riscritte da una precedente letteratura e da fonti giornalistiche in una catena senza fine di rimasticazioni, o persino fabbricati interamente, come nel caso dei numerosi "eroi popolari" scritti sulla falsariga di Paul Bunyan, il quale aveva, almeno un qualche rivolo di tradizione orale all'inizio del suo sfruttamento letterario (cit. in Dundes, 1989, p. 40).
Le leggendarie avventure di Paul Bunyan, caso emblematico e ansiogeno per Dorson di fakelore (vi tornerà infatti quasi con accanimento più volte nei suoi studi), sono molto popolari negli Stati Uniti. Si incentrano su una figura di boscaiolo votato a sconfiggere i cattivi e le avversità, anche di carattere naturale, che possono turbare la quiete tutta americana di laboriose e oneste comunità montane. Il gigante buono diventa eroe quasi sempre per caso, armato di sola buona volontà, generosità e propensione a lavorare sodo. La prima storia scritta su Bunyan apparve sul Detroit News Tribune il 24 Luglio del 1910, per opera di un giornalista, James MacGillivray (P.A.F., pp. 80-8I). Da lì, dato il successo di pubblico del racconto, più autori ritornarono sul personaggio creando una vera e propria saga. Qualche traccia di tradizione orale precedente al 1910, relativa ad un taglialegna grande e buono, esisteva in Pennsylvania, nel Wisconsin e in alcune aree del Nord ovest del Pacifico americano. Tuttavia la fissazione definitiva dei caratteri iconici e geografici di Bunyan, avvenne quando un pubblicitario del Minnesota, W.B. Laughead, produsse su di lui una serie di pamphlet tra il 1914 e il 1944 al fine di promuovere i prodotti della "River Lumber Company1'. E così Bunyan ebbe la sua dimora nel Minnesota, i suoi vestiti, i suoi stivali, i suoi piatti preferiti, insomma la sua cultura materiale di cui divenne testimonial per molte forme di commercializzazione, compresa, attualmente, quella turistica.
Più o meno la stessa cosa accadde a Popeye. il mitico Braccio di ferro. Creato nel 1929 dalla fantasia e dalla grafica di Elzie Segar, diede, con la sua crescente notorietà e popolarizzazione, un notevole impulso alla produzione di spinaci e alla loro commercializzazione in scatola. Alcune statistiche segnalano che dal 1930 al 1936 negli Stati Uniti la produzione di questo vegetale salì del 33%. E per ringraziarlo di questo, Crystal City nel Texas, che si auto-definisce "la capitale mondiale degli spinaci”, gli ha eretto un gigantesco monumento colorato proprio di fronte alla stazione di polizia. Altri monumenti a Popeye sono disseminati negli USA e si possono segnalare ricadute performative con organizzazione di feste, soprattutto a Chester nell’Illinois città natale di Segar, ovvero i cosiddetti Popeye festivals a scopo turistico-promozionale.
Anche la tradizione di Bunyan ha avuto le sue ricadute di carattere festivo. In numerose comunità montane del Minnesota e in tutto il midwest si celebrano (ma anche altrove, come ad esempio in alcuni campus universitari), specialmente in ottobre, feste chiamate "Bunyan-land”per attrarre turisti, dove si cucinano cibi del tipo "Paul Bunyan flapjacks", gigantesche focacce dolci, oppure si fanno gare campagnole, tipo corse nei sacchi ecc. Da tempo sono nati poi dei parchi di divertimento a tema, incentrati sui racconti e i personaggi della saga di Paul Bunyan. Sono delle specie di agriturismo disneyficati, situati nei boschi, con aree sportive e di gestione del tempo libero per bambini e adulti. In questi parchi, come il Paul Bunyan Center situato nell'area dei Brainerd lakes nel Minnesota, ci sono hotel, residence, parchi gioco, negozi di souvenir legati al personaggio e visi celebrano occasionalmente numerosi Paul Bunyan festivals. Anche in Italia alcuni casi di fakelore a scopo commerciale, con invenzione di favole popolari per vendere pasta e quant'altro, furono studiate da Lombardi-Satriani (1973).
Insomma si può dire che, al di là degli anatemi di Dorson, il fakelore rischia di funzionare più e meglio del folklore.
Dundes (1989, pp. 42-44), si impegna laboriosamente a provare la inadeguatezza del concetto di fakelore, dicendo che in fin dei conti gli studiosi del folklore sin dall'inizio hanno avuto a che fare con tradizioni spurie. I canti di Ossian ad esempio raccolti da James Macphcnson nel 1765, suscitarono dubbi sulla loro adesione alla tradizione orale gaelica persino in David Hume. Ugualmente i procedimenti di "abbellimento" e di manipolazione delle fonti orali delle fiabe, ampiamente dimostrati dagli storici, farebbero virtualmente dei fratelli Grimm dei produttori di fakelore. Duiides (1989, p. 53) sostiene dunque che condanna e riprovazione non servono a nulla e suggerisce di indagare le radici storico-culturali ed economiche della fortuna del fakelore e delle motivazioni sociali e politiche che possono soggiacere a ciò che Hobsbawn (1983, pp. 3-17) ha chiamato l'invenzione della tradizione. Falsa o vera che sia, una tradizione, se ha una presa sociale, deve essere studiata seriamente.
Attribuzionismo ed expertise antropologica
Tuttavia Dundes non decostruisce sino in fondo la distinzione elaborata da Dorson. In un certo senso, come Hobsbawn, sembra voler accettare che da qualche parte ci siano "tradizioni non inventate", vero folklore e quant'altro. Anche se invita a non demonizzare lo spurio e il falso e a studiarli con impegno e serietà.
Come già accennato, la ricerca di spartiacque tra puro e spurio, tra genuino e contaminato, tra autentico e falso ha, di fatto, accompagnato la crescita e il destino istituzionale del nostro campo del sapere. In qualche modo sembra riverberarsi anche oggi in alcune fortunate formulazioni recenti. Come quella celebre dei "nonluoghi", alla quale Augè (1992) oppone ancora una volta una nozione di località autentica, radicata, frutto di differenziate strategie etniche di domesticazione dello spazio. Ma tutto può essere relatizzato e molto può dipendere dalle situazioni e dai punti di vista: come ha sottolineato Ritzer (1993, p. 84), per il turista americano in terre lontane il passare sotto l'arco "familiare” di un McDonald’s, può significare un temporaneo e confortevole rientro a casa.
Anche in Italia le preoccupazioni per la contaminazione - o impazzimento - dei "frutti puri", per rimandare all'espressione utilizzata da Clifford ( 1988), sono presenti sin dagli albori della formazione della nostra comunità scientifica. Da Tommaseo (1832, p. 16) che si ribella contro le "canzonucciacce scipite" che circolavano a Cutigliano, "nido de' rispetti antichi'', a Pitré, a molti collaboratori dell'Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari. Caterina Pigorini-Beri nel 1880 vedrà con sospetto persino l'alfabetizzazione degli strati contadini italiani, che potrebbe inquinare i costumi popolari ancora allora percepiti come "incolumi" e ''schietti''. E per restare sulle feste, la Pigorini-Beri teme che il "villan rifatto", impari sulla carta stampata che la polvere pirica che utilizza per i mortaretti del Corpus Domini possa essere impiegata per fini ben più "cruenti e spaventevoli".
In antropologia, la vocazione all'expertise dell'autentico etnico-folklorico si è nutrita per decenni di una ricca metodologia su basi filologiche: una sorta di attribuzionismo sui generis molto più visibile in campo storico-artistico, come nel caso della scuola di Roberto Longhi (1954).
Sull'autentico, come luogo ideale o retorico in cui situare la legittimazione dell'oggetto di studio e contemporaneamente della comunità scientifica, c'è un dibattito più che decennale nell'antropologia contemporanea. Nella generale "crisi della rappresentazione" che pervade da tempo i nostri campi del sapere, circolano ormai molteplici nozioni di autenticità, soprattutto in relazione al moderno consumo dell'autentico generato dall'industria turistica. Si può ricordare qui il generoso tentativo effettuato da Shaul Kelner (2001) di fare un certo ordine tra orientamenti oggettivisti, costruttivisti, essenzialisti. antiessenzialisti, esistenzialisti, emergenzialisti e così via.
Riassumendo, gli antropologi delle ultime generazioni, tendono in qualche modo a connettere l'autentico, che non può essere un concetto astratto e slegato dai suoi usi sociali, storici o scientifici, con la questione invece fondamentale dell'autenticazione. Il terreno dell'autenticazione è sicuramente un luogo di riflessione più idoneo e meno sfuggente per essere analizzato storicamente, perché mette in ballo i produttori di saperi come i soggetti che di volta in volta elaborano le regole del gioco linguistico che genera autenticità etnica, folklorica, estetica e così via: "I folkloristi non scoprono, costituiscono; e la relazione fra ciò che costituiscono e il reale, non è quella della verificazione" (Barbara Kirshenblatt-Gimblett, 1988, p. 3).
L'attribuzionismo nella storia dell'arte è anche legato al mercato, l'expertise infatti è strategica e necessaria per vendere l'opera. Qualcosa di analogo è successo anche nell'antropologia. I nativi americani hanno dovuto subire per secoli il patronage di filantropi, antropologi, antiquari e collezionisti sulla loro cultura materiale, sulle loro cerimonie, sulle loro danze, perché non si distaccassero da standard etnici di "autenticità" Navajo, Hopi, Zuni e quant'altro (Mullin, 1995, p. 178 e sgg.). Un'autenticità che da un lato veniva intesa paternalisticamente come leva per valorizzare e promuovere le culture native agli occhi dei turisti americani, dei commercianti, dei collezionisti. Dall'altro, la struttura rigida dei canoni di expertise, talvolta addirittura costruiti a tavolino sulla scorta di testimonianze archeologiche del tutto ignote agli stessi nativi (Wade, 1986, p. 246 e sgg.), metteva a nudo il gioco paradossale dell'autenticazione antropologica dei secoli scorsi. Infatti l'attribuzionismo etnico-folklorico non può andare sempre in parallelo con l'attribuzionismo in campo storico-artistico; se di un quadro di un artista scomparso si può documentare ragionevolmente la falsità ("non è un Picasso"), altrettanto non si può fare di un manufatto, di una festa, di una cerimonia messi in atto da genti vive e vegete. A meno di non voler cadere nei paradossi di sostenere che quel souvenir fatto da un artigiano Hopi non è Hopi, che la tal festa di Marta non è martana.
Autoattibuzionismo
Fortunatamente per tutti noi, martani, Hopi ed etnie di studiosi, si è compreso che le nozioni molteplici di autenticità, quand'anche se ne riesca a fissare qualcuna per qualche mese o anno, sono in continuo transito. Pertanto, ciò che magari un tempo veniva percepito come inautentico, turistizzato, spurio, non genuino, può tranquillamente subire un processo di ridefinizione e divenire "autenticità emergente" (Wang, 1999. p. 355, cit. in Kelner, 2001, p. 2). Molti oggetti destinati al cosiddetto consumo delle identità come i souvenir, ieri considerati ciarpame nativo e rigidamente esclusi "da ogni seria considerazione a causa di prestabiliti rigidi criteri di autenticità" (Phillips. 1998, p. IX), oggi finiscono nei musei e godono di nuovi statuti di definizione e interpretaziune.
Tuttavia, per Barbara Kirshenblatt-Gimblett (Franklin. 2001, p. 214 e sgg.) nessuna delle nozioni di autenticità, anche le più obsolete ed ''essenzialiste", sembra mai svanire del tutto. Antropologi e demologi se le vedono ricomparire come ectoplasmi del passato nelle guide, nelle aspettative dei turisti, nell’offentliche Folklore, nei musei locali, nelle feste e nelle sagre paesane, nelle mostre, nelle pubblicazioni degli eruditi locali, nelle politiche degli assessorati alla cultura, nelle promozioni commerciali e quant'altro.
Insomma, la conoscenza demologica, come ogni altra forma di sapere è uscita da tempo dalle parrocchie della comunità scientifica. Entrando nel sociale più allargato, comprese quelle comunità e località studiate, le sue tesi, modelli e concetti si sono trasformati in azione. Una volta in libera circolazione, gli studiosi non hanno più controllo sui loro costrutti. E se da decenni, poniamo, il taglio frazeriano di lettura della ritualità popolare è stato abbandonato, non significa che esso non continui a esercitare un certo fascino narrativo (da grande narrazione ritrovata) in molti di coloro che elaborano discorsi sulle proprie tradizioni festive. Ed è comprensibile: fra le narrazioni antropologiche, è difficile che trovino soddisfacenti usi locali gli attuali tormentoni antiessenzialisti, sulle identità deterritorializzate, sull'autenticità folklorica come costrutto retorico, gioco linguistico e così via. E quand'anche ci si inventi dalla sera alla mattina una bella sagra paesana a fini turistici, è meglio strizzare l'occhio alla Cerere di Frazer e di Paolo Toschi piuttosto che alle tourist bubbles di John Urry (cfr. MacCannell, 2001, p. 26).
Ma gli utenti locali dei saperi antropologici non sono sempre così ingrati e irriconoscenti nei confronti della comunità scientifica. Seppure in Italia non si è ancora consolidato quel forte settore accademico che negli Stati Uniti si denomina Public Folklore (Kirshenblatt-Gimblett, 2000), tuttavia demologi ed antropologi hanno il loro da fare con musei locali, nazionali, assessorati alla cultura, con la conservazione e catalogazione dei beni, con convegni di studio locali, con la preparazione di operatori nel turismo culturale e così via.
Ma talvolta ci sono delle domande ulteriori, come se l'antropologo fosse una sorta di tutore sacerdotale delle conoscenze locali. In uno scenario che vede indebolire narrazioni e saperi legati al folklore, il ruolo dell'antropologo come dispensatore di forme di expertise localmente utili, può essere ad esempio catturato appieno nel caso raccontato da Thomas Hauschild (1992). Professore di Antropologia all'Università di Tubinga, ha compiuto studi sul campo in Basilicata. Nei suoi soggiorni a Ripacandida negli anni Ottanta del secolo scorso, si trovò a raccogliere informazioni intorno alla festa del Santo patrono, San Donato. E i ripacandidesi, vedendo il suo interessamento e riconoscendogli appunto il ruolo di tutore dell'autentico in quanto antropologo, gli offrirono di far parte del comitato dei festeggiamenti, accanto al prete, agli esponenti della pro-loco, alle confraternite e così via. Lui accettò, naturalmente con la scusa dell'osservazione da un punto di vista estremamente privilegiato. Si trattava infatti di avere la fortuna di entrare in una di quelle chimeriche back regions culturali (MacCannell, 1976, p. 92) tanto agognate da turisti e da antropologi.
Le feste possono essere intese come "ribalte" (front regions), o anche retroscena (back regions) seguendo la fortunata distinzione di Goffman (1959. p. 127 e sgg.), sui quali si mettono in scena diverse e anche contraddittorie forme di "autenticità" locale. Per MacCannell (1976, p. 91), la ricerca della "vita vera" è il penoso calvario (più che pellegrinaggio) dell'Uomo Moderno che sente sfuggire l'attaccamento al lavoro, al vicinato, alla città, alla famiglia che un tempo chiamav a “suoi propri. Nella decomposizione di significati condivisi e del senso di appartenenza, egli avrebbe, sempre per MacCannell, ''sviluppato interesse per la 'vita reale' degli “altri".
Un calvario che in realtà sembra non portarlo da nessuna parte. Tutti sembrano tramare perche non raggiunga il suo obbiettivo. L'industria turistica e le comunità locali mettono in scena ormai non solo "ribalte", ma anche i più perversi "retroscena" (back regions) proprio per dargli "la sensazione di essere penetrato al di là di un falso fronte" (Kelner. 2001, p. 2). La prognosi e infausta:
L'idea qui è che un falso retroscena può essere più insidioso di una ribalta, cioè una demistificazione inautentica della vita sociale non è semplicemente una bugìa, ma una superbugia, del tipo di quelle che sgorgano con sincerità (MacCannell, 1973, p. 599).
Ci sono molte cose che non convincono in questa idea della trama a danno del povero "uomo moderno" che non riesce più a situarsi da nessuna parte e che tenta invano di riscaldarsi al tepore delle autenticità altrui. E molto più verosimile che nel gioco dei finti e veri retroscena, finte e vere ribalte (se pure possano essere considerate dicotomie accettabili), non c'è etnia, gruppo o persona al mondo che non vi resti in qualche modo imbrigliato, più o meno consapevolmente.
L'imperfetto folklorico
La ricerca della ''autenticità" non è solo una chimera di folkloristi, antropologi o turisti. Si può concordare che la nozione transiti e che sia variamente costruita sulla scorta di accorgimenti retorici o strategie culturali differenti. Ma è una chimera condivisa, a livello locale, etnico, politico, sociale, personale. La cifra del folklore-Volkskunde non è il disincanto, quanto piuttosto, oggi più che mai, l'orgoglio. Se il tempo della scrittura etnografica è il presente, come sostiene Fabian (1983), il tempo della demologia è l'imperfetto e non a caso. Quel "c'era una volta", o "un tempo si soleva" su cui spesso si aprivano le descrizioni degli usi e costumi popolari più "incolumi" da sempre considerati specie in estinzione, sono diventati oggi parte integrante delle narrazioni locali sul proprio folklore.
Per parlare dell'imperfetto folklorico, cambieremo scenario e ci sposteremo dalle paludi antropologiche alle ridenti praterie a cavallo fra l'Iowa e il Nebraska negli Stati Uniti.
Nell'agosto del 1997 ero in cerca di surmodernità nella riserva della Nazione Umonhon (Omaha), Cercavo di fare una visita ragionata del grande Casino che i nativi sono riusciti a costruire nel loro territorio, dopo una lunga battaglia legale con il governo federale. La maggior parte dei croupier erano nativi, come pure i venditori di souvenir nel gift-shop, e qualche (non molti) giocatore. Erano vestiti all'occidentale, con le loro divise aziendali se lavoratori, con i loro jeans o altri abbigliamenti standardizzati se avventori. Cominciai a parlare con la ragazza della reception del Casino. Non ero alla ricerca di nessuna "indianità" verace, volevo solo sapere se poteva mettermi in contatto con qualcuno che mi parlasse di dati ufficiali, battaglie legali, rapporti manageriali con gli altri casino (in special modo con quelli di Las Vegas), numero di Omaha impiegati nell'impresa, e cose del genere. La ragazza sembrò capire subito che specie di avventore fossi, genere antropologi, giornalisti, sociologi ed altri ficcanaso. Dopo aver tentennato un pò con risposte laconiche mi chiese perché mai stessi a perdere del tempo con lei e mi disse di andare subito, anzi di tutta fretta, a Macy, il villaggio principale della Riserva, dove lei stessa vìveva. Come era possibile: io volevo restare nella front-rcgion e lei mi spediva a casa sua? Non capivo, ma obbedii.
Dopo un percorso in auto di pochi chilometri interrotto da cartelli che indicavano che ci si stava addentrando nei territori della Nazione, e dopo aver incontrato - con una certa emozione - la fabbrica del tabacco Omaha, con il suo rosso e leggendario logo, arrivai a Macy. Un villaggio con costruzioni basse, dignitoso anche se a tratti trasandato. Più mi avvicinavo alla piazza principale e più mi sembrava di avere le traveggole. Vedevo decine di persone che confluivano a passo svelto verso un grande spiazzo, donne, uomini, bambini, anziani. La cosa per me surreale è che erano tutti vestiti all'imperfetto, ovvero nei loro tradizionalissimi costumi, con tanto di piume, trecce, mocassini, pettorali d'osso e tessuti colorati. Sulle prime pensai che stessero girando un film. Tutti sorridevano, mi invitavano ad affrettarmi e mi indicavano la strada. Alla fine ci fu il disvelamento. Ero stata gentilmente consigliata di assistere al 193° Pow-Wow della nazione Umonhon che si teneva a Macy dal 14 al 17 agosto del 1997. Per la modica cifra di cinque dollari entrai nell'arena festiva, mi fu fatto dono di una spilla di metallo stampato di commemorazione (che conservo gelosamente) e di un inserto del giornale "The Umonhon Traveller" interamente dedicato al Pow-Wow. I sentieri sterrati che conducevano al grande spiazzo dove si sarebbero svolte le danze erano pieni di bancarelle, alcune che vendevano souvenir, artigianato nativo più o meno commerciale, altre CocaCola, hamburger e cibi yankee di uso consueto. A ridosso e tutto intorno allo spiazzo c'era un accampamento costituito da una grande distesa di tende, del genere canadese, moderne, ma "indiane'' a tutti gli effetti, perché dentro c'erano gli ospiti, rappresentanti delle tribù vicine e lontane, che partecipavano ai Pow-Wow con i loro gruppi di danzatori e di suonatori.
Al centro dell'arena, sotto un padiglione sormontato da potenti amplificatori, un gruppo di suonatori di tamburi aveva già cominciato a scandire quel genere di ritmi che graffiano l'anima a tutti quelli che sin da bambini nei film western sono sempre dalla parte degli indiani. Intorno migliaia di spettatori divertiti e plaudenti, bianchi pochi, qualche decina in tutto, alcuni chiaramente facenti parte di gruppi familiari misti, con bambini nelle tipiche ''culle a slitta". Poi cominciarono le danze, quelle tradizionali fancy degli uomini, quelle del Grano Verde, quelle tradizionali fancy dei ragazzi, delle ragazze e delle donne e così via. Vidi che ogni gruppo che entrava nelle sezioni di danza recava un numero e cosi mi resi conto che certi posti riservati di tribuna erano per i giudici. Si trattava insomma anche di una gara per i migliori danzatori, con premi varianti da 1500 a 100 dollari. Il premio più alto era riservato al primo classificato fra i gruppi over 46 che interpretavano le danze Tradizionali degli Uomini. La corrispettiva sezione femminileprevedeva invece un premio di 500 dollari inferiore (significherà qualcosa?).
Feste e guastafeste
Complessivamente fu uno spettacolo di godimento superbo e di grandissimo valore educativo, anche per chi, come me, sa solo qualcosa di libresco sulle culture native americane e nulla di etnomusicologia e di danze tradizionali. Che si trattasse di una staged authenticity non vi era ombra di dubbio, data la grazia performativa e la condiscendenza con cui guerrieri, danzatori, musicisti, astanti e venditori si facevano fotografare e filmare da chiunque, parenti, amici, yankces, turisti e persino da una antropologa italiana finita lì per puro caso. Ma è difficile pensare a questa "autenticità messa in scena1' come a un qualcosa che non abbia significato e funzione per gli Omaha stessi e i loro ospiti. Nei giorni del Pow-Wow ho visto persone orgogliose dei loro abiti, fiere delle loro abilità performative, ho visto migliaia di nativi che si divertivano ed applaudivano, genitori emozionati nel vedere le loro bambine danzare perfettamente con i loro abiti tintinnanti.
Nella letteratura specialistica si tende generalmente a considerare i Pow-Wow come forme recenti e spettacolari di cerimonie, una sorta insomma di fakelore fortemente inquinato dal meccanismo teatrale e dall'elemento competitivo delle gare a premi.
Tara Browner è professore associato di Etnomusicologia e di Studi Amerindi presso l'università della California a Los Angeles, insegna e studia le musiche e le danze native ed è lei stessa una danzatrice e percussionista. Nel suo recente volume dedicato al Pow-Wow nel Nord America scrive con molta chiarezza:
Alcuni studiosi, come Weibel-Orlando nel 1991, hanno fornito una caratterizzazione dei Pow-Wow come delle restituzioni inautentiche di un passato glorificato, simulazioni sensa referenti culturali interiori, elaborati teatrini etnici dove gli Indiani costruiscono una idealizzata identità e la presentano all'esterno. In Pan-Indianism in Native American Music and Dance, James Howard riassume questo atteggiamento con la frase "Meglio Pan-Indianoche non Indiano" (Browner, 2002, cap. I).
Quindi, al di là della metanarrazione storico-filologica sulle origini del Pow-Wow su cui si può anche concordare, sta di fatto che oggi i nativi come gli Omaha, a prescindere dalla "cornice" teatrale o di gara utilizzata, usano narrazioni totalmente differenti per ciascuna delle singole danze facendo sempre riferimento a qualcosa di molto radicato, antico, "autentico". Nell'inserto di giornale che mi hanno dato, si può leggere delle origini della Men’s Grass Dance che loro fanno risalire ad un episodio di guerra intertribale con i Lakota, e altre narrazioni simili. E anche le trasformazioni delle danze di guerra nelle attuali nuove versioni sono raccontate in una forte vena di radicamento etnico:
Sui finire dell'Ottocento, quando i popoli nativi americani non furono più in guerra, la Danza di Guerra cominciò ad assumere un significato completamente, nuovo. Attraverso gli anni è diventata un modo di richiamare profondi, radicati sentimenti e tradizioni. Un modo per trasmettere il senso dell'orgoglio nella cultura nativa americana alle nuove generazioni (The Umonhon Traveller. 10 luglio 1997).
Tutto questo insomma sembra avere molto a che fare con l'essenzialismo della vecchia antropologia. Ma se a loro piace, qualche giorno dell'anno, rappresentarsi all'imperfetto e rintracciare così una cifra di autenticità nel passato, non sarà certo qualche antropologo a guastare loro la festa.
La festa di sant'Antonio abate a Collelongo:
tradizione e innovazioni
Gabriella Marucci
Collelongo è un piccolo paese della Marsica, posto a 915 metri di altitudine, in prossimità della piana del Fucino. La sua storia è antica, come dimostra il vicino sito archeologico di Amplero, dove sono stati ritrovati vari tipi di ceramica lavorata, alcuni dei quali, di provenienza danubiana, costituiscono la traccia tangibile di remoti rapporti culturali di matrice indoeuropea.
I poco più di mille abitanti del paese vivono, si può dire da sempre, di agricoltura, allevamento e pastorizia, quest'ultima sempre meno praticata. Negli ultimi decenni, infatti, l'inevitabile omologazione ai modelli di vita urbani proposti dalle vicine città di Avczzano e di L'Aquila, insieme allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e soprattutto all'abbandono da parte dei giovani delle attività economiche tradizionali, hanno trasformato la vita economica e sociale della comunità. Tuttavia, il veloce adeguamento ai modi di vita urbani non è riuscito a recidere il tenacissimo legame dei collelonghesi, giovani e anziani, con il loro passato, che viene tuttora percepito come ricco di valori e di stimoli validi. Questo diffuso sentimento si esprime in credenze, riti, pratiche comunitarie di singolare e persistente vivezza.
A iniziare dal 1991, ho condotto a Collelongo una lunga se pur discontinua ricerca sul terreno, che mi ha offerto l'opportunità di creare con molti paesani un rapporto di contiguità che si potrebbe definire affettuosa, fatto di spontanea ospitalità e di disponibilità a raccontare e a raccontarsi. Ebbene, l'impressione che ho costantemente ricevuto è che i Collelonghesi accettano volentieri le novità, ma, in una sorta di processo di accumulo, conservano usi antichi, che, in sintesi felice con il pedaggio offerto alla 'modernizzazione', trovano spesso un nuovo slancio.
La festa di sant'Antonio abate costituisce un esempio lampante di questa capacità di sintesi. Ho assistito all'evento festivo per tre anni consecutivi, recandomi in paese prima, durante e dopo lo svolgimento delle celebrazioni, canonicamente fissate al 16, 17, 18 di gennaio. Gli anni successivi mi sono limitata a raccogliere informazioni a distanza sull'andamento della festa, sul numero e sulla tipologia dei partecipanti e su particolari dei quali volevo seguire l'eventuale evoluzione. Infine, nell'anno in corso (2003), sono tornata per un'ultima volta 'sul terreno' con lo scopo di ricavare alcuni necessari riscontri alle mie ipotesi; come già nel '93, ero accompagnata da una piccola équipe dotata di telecamere professionali e di altre attrezzature di rilevamento. È stato così possibile filmare tutto l'apparato celebrativo nella sua completa interezza: il materiale, sommato a quello già montato, consentirà di costruire un filmato che renda efficacemente l'idea della festa e delle sue dinamiche espressive.
Per una pura casualità, la RAI, che era presente con una sua troupe, ha pregato di seguire e commentare la festa con i suoi inviati. La presenza ufficiale e all'apparenza apportatrice di prestigio del medium pubblico non e stata priva di conseguenze, come si potrà rilevare in un saggio successivo a questo.
Un lavoro di ricerca tanto lungo e accurato sulla ricorrenza collelonghese è dovuto alla non comune sovrabbondanza di simboli e di atti rituali in essa osservabili; è infatti vero che nei numerosissimi paesi italiani, e non,} dove nella stessa data si celebra questo popolarissimo santo, ci si limita manifestazioni più semplici, imperniate per lo più all'accensione di roghi e fuochi, spesso imponenti. A Collelongo l'apparato festivo è molto complesso e si articola, oltre all'accensione di fuochi, in questue, cortei di musicanti, offerte primiziali al santo e, soprattutto, nella distribuzione rituale di cibo, il cui simbolo principale e irrinunciabile è costituito da enormi calderoni di rame, detti 'cottore', nei quali vengono cotti quintali di mais, poi distribuiti a migliaia di 'ospiti'.
Base ineliminabile e perno immutabile della festa è dunque lo 'spreco rituale', l'offerta e il consumo collettivo di cibo; soprattutto, ma non solo, di granturco. I grani di quest'ultimo, una volta cotti, prendono il nome di 'cicerocchi', a ricordo dei ceci usati fino all'ultima guerra. È il mais del raccolto precedente, che viene offerto al santo e consumato in attesa della successiva produzione.
Lo spreco ritualizzato di cibo viene anticipato da un'istituzione molto diffusa in tutta la regione: la questua. In tempi non lontani, vari giorni prima dell'Epifania arrivavano dai paesi vicini i 'poveri', che andavano questuando di casa in casa ricevendo generose quantità di pane, farina, lardo. Come si può facilmente comprendere, questa usanza è stata cancellata da un generale miglioramento delle condizioni di vita. Attualmente, continuano a essere praticati altri due tipi di questua. Una, di recente ideazione, viene affidata al Comitato Organizzatore della festa al fine di raccogliere il denaro destinato a sovvenzionare l'acquisto di fuochi d'artificio, di manifesti e del maialino che sarà il protagonista della riffa il 18 pomeriggio. La seconda questua, di antica tradizione, è eseguita da gruppi di ragazzi del paese che, nella settimana precedente la ricorrenza, passano di porta in porta suonando e cantando la canzone del santo e ricevendo in cambio piccoli rinfreschi. Fino a una trentina di anni fa, e in paese ne è ancora vivo il ricordo, i ragazzi compivano il loro giro vestiti da contadini, da diavoli o del saio da eremita, recitando ad ogni tappa scenette della vita del santo.
La questua è contrassegnata dalla obbligatorietà del dare: rifiutare l'offerta ai questuanti equivarrebbe a rifiutarla al santo in persona, dimostrandogli in tal modo una grave mancanza di rispetto e di devozione, alla quale egli risponderà con malevolenza; chi rifiuta di dare, non solo non riceverà, ma ne subirà un danno.
Sempre nei giorni immediatamente precedenti la festa, le donne preparano le cosiddette 'panette'. Si tratta di panini di farina di grano, di forma tondeggiante, un tempo di uso solo festivo, cotte in quantità enormi per poter essere distribuite a tutti. Ora, sono molte le donne che si limitano a cuocere semplici rosette o a comprarle; ma il nome, tradizionalmente declinato al femminile, è rimasto. Per tutta la durata della festa, le panette sono considerate speciali, costituiscono il 'pane del santo', preparato con la farina ottenuta grazie alla riuscita della festa precedente e al favore conseguentemente accordato da Antonio al raccolto. Sono dunque delle vere e proprie strenne e come tali vanno donate, ricevute, ricambiate. Conclusasi la festa, perderanno ogni valore e verranno semplicemente gettate via, tranne alcune che, almeno nelle case dei più anziani, vengono conservate per poter spegnere un eventuale incendio. L'anziana Lidia S. e le sue parenti coetanee, indifferenti alla benevola incredulità dei familiari più giovani, ricordano con assoluta certezza di aver visto alcuni incendi scoppiati in stalle o case spenti grazie alle panette prontamente gettatevi dentro: quindi, per precauzione, ne tengono sempre un paio in casa.
La festa
Il 16 gennaio, verso le undici del mattino, iniziano in sordina le prime manifestazioni festive, che, pur non svolgendosi nell'ambito del tempo rituale vero e proprio, lo preannunciano. Un piccolo corteo composto di alcuni musicanti con fisarmoniche, cembali e percussioni, comincia a percorrere le strade del paese; guida il gruppetto sant'Antonio in persona: è un collelonghese, Fiore S., che con saio, bastone a tau e campanella, da un paio di decenni impersona, anzi, diventa sant'Antonio.
Verso le tredici, una famiglia che abita in una casa sulla strada principale organizza un pranzo all'aperto per tutti i compaesani. Questo dono alimentare risale a un voto fatto decenni or sono da un avo e trasmesso patrilinearmente ad ogni generazione. L'attuale capo-famiglia afferma di non ricordare o forse di non aver mai conosciuto il motivo del voto, né la sua collocazione oraria, ma si dichiara fermamente convinto a proseguire la tradizione. Il pranzo consiste di una pasta e fagioli, cotta da un uomo di casa in una caldaia posta su di un fornello all'aperto, mentre le donne preparano in un cortile interno stoviglie, vino, panette. Tutti partecipano alla distribuzione, sindaco, parroco e sant'Antonio compresi. Giungono anche, recando recipienti di vario tipo, i familiari di anziani e ammalati per prendere un po' di minestra per chi è impossibilitato a muoversi. Non sono mossi da motivi economici, naturalmente, ma solo dalla convinzione che ognuno debba ricevere la sua parte del pasto collettivo ed essere coinvolto nel giro delle offerte alimentari.
Nelle ore del pomeriggio, mentre sant'Antonio e i musicanti continuano il loro giro suonando ininterrottamente la canzone del santo, vengono dati gli ultimi ritocchi alle cottore. Con questo termine non ci si riferisce alle sole caldaie, ma ai focolari sui quali sono poste e, per estensione, all'ambiente che le ospita. Le caldaie vengono riempite d'acqua, il mais sgranato messo a portata di mano, i rinfreschi e i decori sistemati. Ordinate file di arance ornano i focolari, così come la statua dal santo in chiesa. Terminata la festa, saranno donate ai meno abbienti. Come ha detto il padrone di casa di una cottora: "Qui tutto viene offerto, questa è la notte dei doni".
Alle sedici, un colpo di pistola sparato dalla piazza principale del paese segna l'inizio dei riti. Simultaneamente, in ogni cottora, una donna accende il fuoco sotto la caldaia, recitando al contempo litanie e preghiere: il semplice e domestico gesto dell'accensione del focolare viene cosi posto nel territorio del sacro. Le preghiere sono formulate in un latino incomprensibile, il cui significato è serenamente ignorato dagli astanti e la cui eventuale traduzione avrebbe un'importanza del tutto trascurabile: è proprio la sua incomprensibilità a dargli un senso. Qualche ora dopo, si getta il mais nell'acqua bollente.
Intorno alle venti, alcuni giovani del Comitato Organizzatore, servendosi di lunghe scale, accendono i due 'torcioni’. Sono enormi gabbie di ferro a forma di colonne rastremate verso il basso, riempite di legna raccolta nel territorio boschivo comunale. Il parroco, in cotta e stola, accende dal torcione collocato davanti al sagrato una 'torcetta', sorta di lunga fiaccola di legno e cera. I presenti, a loro volta, accendono le loro passandosi l'un l'altro il fuoco del santo. Ha quindi inizio un corteo, composto dal sacerdote con i chierichetti, da paesani disposti in coppie con le torce tenute basse e quasi incrociate, sant'Antonio con i suoi musicanti; dietro si accoda la folla dei presenti.
Il parroco, con il suo affollato corteo, passa di cottora in cottora, benedicendo i focolari e rendendoli accessibili alla collettività festante. Un tempo questo cerimoniale durava molte ore, perché il numero delle cottore si aggirava fra le venti e le venticinque, una per ogni famiglia estesa. Alcune righe su questo curioso attrezzo domestico ne chiariranno l'importanza.
Le cottore di rame esistenti in paese sono tutte antiche di cento, centocinquanta anni circa; fino alla generazione passata dovevano essere trasmesse matrilinearmente, insieme all'obbligo di organizzare un focolare. In caso una delle figlie fosse rimasta nubile, la cottora sarebbe passata a lei e quindi, dopo questa sosta nella famiglia paterna, alle figlie delle sorelle. Questo passaggio poteva dare adito a complicazioni diplomatiche di non lieve entità e a lunghe diatribe. Un fatto sembra comunque certo: le cottore, almeno negli ultimi cento anni, hanno seguito le donne da una generazione all'altra, nel loro peregrinare da una razza all'altra. Da qualche anno le cottore vengono spesso trasmesse dalle madri ai figli maschi primogeniti. I paesani non danno spiegazione alcuna a questo cambiamento, quasi certamente dovuto all'estinzione del movimento migratorio e della transumanza, che allontanavano gli uomini da casa per mesi o anni; il mantenimento della residenza da parte dei maschi delle famiglie può aver portato allo scoperto una tendenza che per decenni si era manifestata occasionalmente con il passaggio della caldaia alla figlia nubile e alla casa paterna di lei. Impossibile sapere se si tratta del ripristino di una antica tradizione patrilineare interrotta da un sceolo di emigrazioni o di un fenomeno nuovo.
Il corteo che con il parroco apre ufficialmente l'accesso alle cottore è l'unico evento di questa festa che assomigli ad una processione, con il suo deambulare chiuso, interno al paese, cui si fondono le caratteristiche del pellegrinaggio, con una collettività in cammino verso la casa, anzi, le case del santo.
Terminato il suo giro di benedizioni, il parroco rientra in chiesa; ne uscirà più tardi per godersi la festa, svestito degli abiti liturgici e insieme della sua funzione di rappresentante ufficiale della Chiesa. Questo discreto ritirarsi consentirà al santo 'vivente' di rivestire nuovamente il suo saio e di iniziare con i musicanti il proprio giro per le cottore.
Per tutta la notte migliaia di persone passeranno di focolare in focolare, più e più volte, accettando cicerocchi, panette, dolci. vino. La gente accorre numerosa da tutti i paesi vicini, molti sono gli emigrati, ormai da sempre residenti oltre-oceano, che tornano per l'occasione. Si formano spontaneamente vari gruppi: chi segue Antonio, chi parenti o amici incontrati lungo il percorso, chi si aggrega ad altri improvvisati musicanti. Ogni volta che un gruppo entra in una cottora, si svolge uno scambio di saluti e auguri con i padroni di casa, usando la formula di rito: "Tanti auguri alla cottora!". Sarà così per tutta la notte, con un flusso ininterrotto di gente che continua ad arrivare e che si inserisce senza sosta nel giro della distribuzione di cibo, auguri, saluti. La neve, il ghiaccio e il freddo intenso dell'inverno marsicano non hanno mai costituito un deterrente all'accorrere di una tale folla. Può capitare che una cottora sia gremita di gente che mangia, canta, chiacchiera e che si svuoti all'improvviso per riempirsi, dopo qualche minuto di silenzio, di altra gente allegra e rumorosa. E, come nella mitica caldaia del celta Beltain, il cibo sembra inesauribile, ce n’è sempre per tutti.
Alle prime luci dell'alba, tutti si riuniscono sul sagrato della chiesa. I torcioni nel frattempo si sono disfatti in una montagna di cenere, che riscalda la gente in attesa. Silenziose, arrivano in fila alcune ragazze in costume tradizionale, recanti sul capo delle conche di rame ornate di fiori, luci, scene miniaturizzate della vita del santo. Dopo averle fatte sfilare, un'apposita giuria assegnerà premi alla conca più applaudita e all'abito più bello e di pregio. Fino a venti, trenta anni fa, quando le cottore erano organizzate solo dalle famiglie, questo che ora è un breve cerimoniale era molto più complesso: da ogni focolare uscivano le padrone di casa recando delle conche che venivano allineate sul sagrato; quindi, dalle cottore arrivavano delle ragazze abbigliate in costume, che sorreggevano sul capo conche decorate, seguite a loro volta da cortei di altre giovani che trasportavano recipienti pieni di cicerocchi; questi venivano versati nelle conche già predisposte e messi a disposizione dei poveri di tutti i paesi vicini. Solo dopo questa rinnovata dimostrazione di solidarietà e di spreco rituale di cibo, veniva premiata la conca più riccamente decorata, con l'accompagnamento del rumoroso tifo dei parenti delle fanciulle.
Le ragazze,giovanissime, poco più che bambine, continuano a sfilare e a preparare conche sempre più originali, ma non sono più rappresentative di una specifica cottora. La loro esibizione e la loro connessione con le conche ha perso la vecchia, manifesta valenza di fertilità e di fecondità; ne resta il ricordo, nello sfilare delle fanciulle davanti alla gente, apertamente esposte e protagoniste di una gara gentile, insieme all'usanza di chiamare ogni vincitrice "La conca più bella dell'anno...", che identifica la giovane con un recipiente di evidente forma femminile, colmo di cibo e di promesse di vita. Lo spreco rituale, l'orgia alimentare, l'ostentazione di prodotti, l'offerta primiziale, l'accensione di fuochi, sono elementi che connotano la festa di sant'Antonio a Collelongo come una festa di Capodanno, che imita, auspica e inaugura una stagione di abbondanza; una festa solare-agraria, solitamente connessa ad una economia prevalentemente agricola. Questa constatazione porta a rilevare una sorta di contraddizione, rappresentata proprio dalla figura sacra cui la festa è dedicata.
Sant'Antonio fu un eremita egiziano del III secolo, reso famoso in tutto il mondo cristiano dalla biografia scritta in greco da Atanasio e da lui stesso diffusa in Europa. Grazie alle successive traduzioni nelle varie lingue dell'epoca, il fascino austero del santo, vigoroso, incolto e irruente, lo portò ad essere il popolarissimo capofila del movimento monastico europeo, destinato a influenzare per secoli la vita religiosa e sociale dell'Occidente. Nell'ambito della religione cosiddetta popolare e nel corso dei secoli, la figura di sant'Antonio ha sviluppato una personalità sfaccettata e controversa. Un aspetto interessante, connesso alle narrazioni delle lotte dell'eremita col diavolo, è quello bricconesco e scaltro dell'uomo di campagna che con la sua furbizia supera le difficoltà postegli dal demonio, la cui perfidia è sempre derubricata in dispettosità. Questo ritratto popolaresco si riflette in canzoni umoristiche, molto conosciute nel Centro-Sud italiano. A Collelongo, già da vari anni sacerdoti e membri del Comitato Organizzatore hanno 'epurato' le scherzose canzoni locali, introducendo testi devotamente ortodossi. Nel 1992, il ricordo delle caratteristiche clownesche del santo non era ancora sopito: il corteo benedicente di quell'anno fu interrotto all'improvviso dalla figura piroettante di un sant'Antonio vestito di bianco che, dopo aver attraversato la folla, eseguendo velocemente alcuni salti mortali, sparì nella notte.
Radicatissima e ineliminabile è in paese la percezione del santo come Padrone del fuoco, ma soprattutto come protettore degli animali domestici, degli allevatori, dei pastori e dei cacciatori (categoria che ha a che fare con animali selvatici, evidentemente esclusi dal patrocinio). Nel nome di sant'Antonio, dopo la messa delle sei, la mattina del 17 il sacerdote benediceva gli animali, portati numerosi sul sagrato dai loro proprietari; l'usanza è ora desueta. In suo onore, fino ad una decina di anni fa, i fedeli ponevano davanti alla sua statua offerte primiziali, quali salsicce, porzioni di animali, uova fecondate. Inoltre, in paese, come del resto in molte località italiane, si narra che la notte del 16 gennaio, il santo si rechi in tutte le stalle domandando agli animali come siano stati trattati dai loro padroni, distribuendo premi e punizioni a seconda delle risposte.
Come osserva V. Lanternari a proposito della figura del Signore degli Animali, cui Antonio va a mio avviso omologato, essa tende continuamente a polarizzarsi in senso malefico e il suo precario equilibrio fra benevolenza e ostilità deve essere mantenuto con offerte e cautele rituali: solo un rito ben eseguito assicura la sua benefica funzione elargitrice. I Collelonghesi hanno idee chiarissime in proposito: ''sant'Antonio è il padrone degli animali", ripetono continuamente, e aggiungono: "sant'Antonio è dispettoso". E non si tratta degli innocenti dispetti che le leggende umoristiche narrano egli ritorcesse sul diavolo, tutt'altro: il santo offeso fa incendiare, provoca morie di animali e 'manda' la malattia del fuoco che porta il suo nome. In paese si tramanda una ricca anedottica sull'argomento. Questa componente malevola, così strettamente congiunta a quella propizia, è confermata da W. Cianciusi, colto avvocato di Collelongo, autore di numerosi saggi sul paese e sulla storia della regione, che cita la "pervicace e proterva volontà di nuocere del Santo, cui non si può fare torto non compiendo il sacrifìcio" (Cianciusi, 1972, pp. 333). La festa, appunto, che facit sacrum l'alimento considerato più importante.
La percezione ambivalente della figura del patrono è ideologicamente connessa alle più antiche attività della Marsica, la pastorizia e l'allevamento, affiancate da una difficile agricoltura, che da tempo, grazie soprattutto al prosciugamento del Fucino, ha preso il sopravvento su ogni altra attività tradizionale. A Collelongo, tutto il rituale di sant'Antonio si aggancia esclusivamente al ciclo agrario, con le caratteristiche oblative connesse alla prevalente esperienza dell'agricoltura: l'accensione di fuochi notturni, lo spreco rituale di doni e di cibo, l'ostentazione di prodotti della terra, l'aspettativa che, in contraccambio, il santo favorisca il prossimo raccolto. Ma il ritratto del patrono che emerge parlando con la gente del paese è unicamente quello del custode degli animali e dell'etica comportamentale nei loro confronti.
Innovazioni
Le cottore sono sempre state di tipo esclusivamente famigliare, organizzate nell'ambito di ogni razza, con il volonteroso aiuto di amici e vicini, che in tal modo potevano partecipare della futura benevolenza di sant'Antonio. Fra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, molte famiglie non furono in grado di affrontare la spesa e la fatica di 'distribuire la festa'. Spontaneamente, nessuno ricorda più su iniziativa di chi, si corse ai ripari. Così, quando nel 1991 andai per la prima volta a Collelongo per assistere all'evento, vi erano solo due cottore 'private', mentre due erano state organizzate dal Comitato Alpini, molto popolare in paese, e dal Comitato Organizzatore della festa, che mai negli anni precedenti aveva svolto un compito simile. Nel 1993, il processo innovativo compì un ulteriore passo avanti. Il numero delle cottore era aumentato, con grande soddisfazione dei paesani; alle due familiari che avevano resistito tenacemente, se ne erano aggiunte altre cinque, offerte dal gruppi di varia composizione: i bambini della scuola elementare con le loro maestre; giovani e giovanissimi di quattordici, sedici anni; il Comitato Alpini; il Comitato Organizzatore. Questi ultimi sono diventati presenze fisse, almeno fino all'anno in corso. Lo stesso schema, con alcune varianti, si è: ripetuto negli anni successivi.
Dal 2002, alle due vecchie cottore private se ne è aggiunta una nuova, offerta da un giovane architetto che da qualche tempo vive in paese con la famiglia e che esprime il suo desiderio di integrazione usando un mezzo di immediata comunicabilità. Alle cottore 'pubbliche' ormai entrate nella tradizione festiva, Comitato Alpini, Comitato Organizzatore, Giovani, si sono aggiunte quella della Pro Loco e quella, curatissima nella scenografia e abbondantissima nell'offerta di rinfreschi, organizzata da un gruppo che potremmo definire 'politicamente impegnato'.
Il passaggio da cottore solo private ad un sistema misto che vede protagonisti per accuratezza e disponibilità di mezzi i gruppi non parentali, non è avvertito dalla gente del paese come una reale trasformazione, probabilmente anche per la gradualità del processo, ma soprattutto perché la prassi rituale sembra, ed è, quella di sempre: anzi, le cottore non solo sono sempre al centro dell'evento, ma sono tornate ad essere numerose.
Ma la trasformazione si è verificata. Fino a una ventina circa di anni fa, il migliaio di abitanti del paese seguiva i ritmi tranquilli e ripetitivi di una vita faticosa, non necessariamente povera, ma contrassegnata da un notevole distacco dai modelli urbani, segnatamente dalle tecnologie e dai mass-media. In pochi anni la piccola società collelonghese è enormemente mutata. La famiglia estesa non è più la colonna portante della vita individuale e sociale, il cui fulcro si è spostato all'esterno. La scuola è considerata importante e sempre più frequentemente i ragazzi prolungano gli studi fino al diploma o alla laurea; di conseguenza, sono pochissimi coloro che si dedicano alle occupazioni tradizionali. Ragazze e ragazzi passano la maggior parte del loro tempo con i coetanei e, finiti gli studi, preferiscono impiegarsi in azienda o negli uffici, anche a costo di fare i pendolari con la città. Bambini, ragazzi e giovani hanno decisamente acquisito una nuova rilevanza sociale. Si aggiunga, a questo epocale cambiamento, l'azzeramento del flusso migratorio che per decenni ha allontanato da casa soprattutto gli uomini. La piccola società odierna non avverte più l'urgenza di confermarsi come imperniata su di una famiglia, percepita come meno fragile che in passato. L'attuale organizzazione festiva riconosce dunque l'esistenza di fasce d'età e di gruppi che hanno un effettivo ruolo nella collettività.
Per concludere, ciò che colpisce, in un panorama nazionale variegato di migliaia di feste sacre scomparse o derubricate a sagre, è che la collettività di Collelongo continua ad autorappresentarsi e a mostrarsi utilizzando i mezzi di sempre: la festa di sant'Antonio, le cottore, il grande consumo collettivo di doni alimentari. Questa particolare festa ha dunque manifestato la capacità di modellarsi flessibilmente sulle nuove esigenze e sulla nuova realtà.
Probabilmente è per questo motivo che i Collelonghesi, interpellati in proposito, negano che si sia verificato un vero cambiamento: l'evento festivo viene continuamente riplasmato dagli stessi protagonisti in modo da corrispondere a come essi percepiscono la loro stessa identità.
La festa di sant’Antonio abate a Collelongo:
rifondazione massmediatica di un evento popolare
Ernesto Di Renzo
Il presente contributo mira a completare la trilogia di interventi che è stata esposta, in occasione dell’VIII Convegno AISEA, sul soggetto della festa di sant’Antonio abate a Collelongo (L’Aquila).
Considerato che sulle modalità di attuazione dell’evento, così come sui contenuti ritualistici e sulle valenze simboliche, è stato scritto con esaurienza di discorso in altre pagine di questo volume, mi limiterò qui a rendere conto di alcune incongruità che l’edizione di quest’anno ha fatto registrare in rapporto al suo modello di svolgimento originario per effetto di una interferenza esterna causata dalla presenza del mezzo televisivo nazionale.
Parlare di tale interferenza, se da una parte significherà ricostruire la breve cronistoria dei fatti accaduti nel piccolo comune abruzzese la sera del 16 gennaio, dall’altra significherà potersi aprire a delle riflessioni di carattere più generale che riguardano il modo in cui i modelli mass-mediatici dominanti usano rivolgere lo sguardo alla realtà del mondo foklorico con pervicaci accenti riduzionistici e manipolatori; restituendone il più delle volte un’immagine oleografica, in posa, edulcorata, pittoresca e, non raramente, destorificata.
Simili accenti, pur sfuggendo (verosimilmente) a preordinate strategie volte ad attualizzare la dialettica contrappositiva tra cultura egemonica e culture subalterne, di fatto palesano l’esistenza di un processo di deriva ideologica che procrastina ai nostri giorni l’annosa questione del modo in cui la cultura ufficiale interpreta la realtà antropologica del mondo popolare.
Di cottora in cottora: la destrutturazione del rito
L’edizione 2003 della festa di sant’Antonio abate verrà certamente ricordata nella memoria dei suoi protagonisti come quella della sua rifondazione dovuta alla presenza di una troupe televisiva di un noto programma di intrattenimento RAI. Una presenza, come avrò modo di dettagliare più avanti, tutt’altro che mimetica o discreta; al contrario invadente e rumorosa, come si addice a chiunque agisca nella consapevolezza di essere il vero ed indiscusso protagonista della situazione. Una presenza, inoltre, dapprima fortemente caldeggiata, quindi sopportata, infine apertamente contestata a causa dei numerosi disguidi che ha provocato nello svolgimento del protocollo rituale.
Sebbene ogni anno le celebrazioni collelonghesi richiamino un discreto numero di emittenti pubbliche e private provenienti dall’intera regione, evidentemente mosse dal desiderio di documentare un avvenimento dagli apparati scenografici altamente suggestivi, nell’edizione appena trascorsa ad incrementare il drappello dei cine-operatori ha agito in maniera risolutiva la determinazione dell’attivo sindaco del paese. Costui, sollecitato sia da opportunismo politico sia da spirito campanilistico, ha pensato di dare il massimo risalto all’evento e ai suoi illustri partecipanti - alcuni parlamentari, esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, amministratori pubblici di vario calibro - chiamando in causa una popolare trasmissione dell’ente televisivo nazionale in onda quotidianamente nella fascia di programmazione mattutina. Inoltre, da politico abile e navigato, ha ritenuto di conferire il più ampio risalto all’avvenimento attraverso un’opera di promozione pubblicitaria condotta sulle pagine della stampa locale. Risultato: si è venuto a creare un clima di entusiasmo generalizzato che ha caricato la festa di comprensibili aspettative da parte dei protagonisti. Ben presto, però, costretti a doversi contraddire.
Infatti, benché il programma dei festeggiamenti fosse stato curato nei minimi dettagli, è apparso subito chiaro che a dettare le regole del gioco non sarebbero stati il comitato organizzatore, i proprietari delle cottore, il sindaco, il parroco, il santo “incarnato” nella figura di Fiore Salucci, bensì l’intera troupe televisiva inviata dalla RAI: quindi il regista, il conduttore, l’autore del programma, il cameraman, il tecnico dei suoni.
Questi, come preludio a quanto più avanti sarebbe dovuto accadere, come prima cosa si sono presentati in paese con circa due ore di ritardo rispetto ai tempi previsti, determinando un significativo slittamento dell’accensione del torcione che segnala l’inizio dei riti; quindi, esponendo difficoltà logistiche che avrebbero imposto il rientro a Roma la notte stessa, hanno chiesto di poter anticipare, dunque simulare, alcune importanti sequenze cerimoniali destinate a svolgersi solo alle primissime ore del mattino seguente. Inoltre, per esigenze di natura scenografica, hanno imposto la delocalizzazione di particolari eventi rituali rispetto ai luoghi normativamente preposti al loro svolgimento, facendoli ripetere più di una volta al fine di ottenere la ripresa più adatta alla successiva messa in onda. Inutile sottolinearlo, questi eventi che si aveva premura di filmare erano quelli che comportavano l’esibizione di figuranti in costume e che servivano a rendere al meglio una certa immagine stereotipata che la televisione è usa restituire della festa popolare.
A questi ritardi iniziali, già causa delle prime reazioni di insofferenza da parte dei collelonghesi, se ne sono venuti aggiungendo di ulteriori in concomitanza di ogni tappa che il piccolo corteo - composto dal parroco, dai musicanti e dalle autorità civili - compie in corrispondenza di ciascuna cottora per impartire la dovuta benedizione: atto, questo, che apre l’accesso al consumo collettivo del cibo rituale (cicerocchi)da parte della folla in pressante attesa. A determinare il rallentamento di siffatte cerimonie ogni volta sono sopravvenuti motivi logistici legati al posizionamento delle luci, dei microfoni e della telecamera.
Oramai, nella misura in cui gli imprevisti venivano affastellandosi, appariva a tutti chiaro che i tempi del rituale non sarebbero stati più quelli canonici sanciti dalla tradizione bensì quelli tecnici imposti dalla presenza del mezzo audiovisivo. La festa, cioè, stava sperimentando una sua singolare destrutturazione ad opera dell’illustre ospite.
Ma il vero climax disorganizzativo è stato raggiunto verso le ventitré, in corrispondenza della cosiddetta cottora di AN, la più spettacolare in termini scenografici e proprio per questo reputata dal conduttore RAI come spazio ideale per la realizzazione di alcune interviste. Senonché, sopraggiunte difficoltà connesse al difettoso funzionamento degli apparati audiofonici, hanno fatto sì che lo zelante inviato attuasse una sorta di sequestro del parroco fino a che il problema non si fosse pienamente risolto. Si è venuta così a creare, per circa una quarantina di minuti, una complicata situazione di stallo strutturale del rituale: da una parte si è impedito al parroco di concludere il suo giro di benedizioni non ancora ultimato, cosa gravissima in quanto fino a che una cottora non viene benedetta i proprietari non possono adempiere ai loro doveri di dispensare cibo a paesani e forestieri; dall’altra si è obbligato centinaia di persone ad accalcarsi in spazi ristrettissimi e ad attendere un tempo eccessivamente dilatato per ricevere la spettante razione di cicerocchi, vino e dolcetti. Questa imbarazzante impasse, la cui risoluzione positiva è stata raggiunta soltanto con il ricorso al buon senso di posticipare ad altro luogo e in altro momento le programmate interviste, ha fatto sì che le regole dell’ospitalità saltassero definitivamente con reprimende ed invettive rivolte al personale della Rai.
Offesi dalle eccessive intemperanze della troupe televisiva, i collelonghesi si sono infatti decisi a riconquistare la “proprietà” della loro festa mettendosi addirittura in urto con il sindaco, “colpevole” di aver favorito la sventurata presenza del mezzo televisivo.
«Non è possibile accettare una cosa simile solo per apparire qualche minuto in televisione», ha inveito con manifesta irritazione all’indirizzo della troupe un membro del comitato còlto in piena emergenza organizzativa:
qua ci sono migliaia di persone che vengono da Avezzano, da Celano, da Roma, da Sulmona, dall’Aquila e non possiamo certo fare questa brutta figura, se no’ che pensano chi siamo. Abbiamo sopportato di cominciare la festa in ritardo per colpa vostra, vi abbiamo accontetati a fa’ sfilare le conche in anticipo, siamo stati gentili e disponibili a tutte le richieste che ci avete fatto, ma adesso basta! Chi vi credete di essere. Tanto se poi succede qualcosa di storto è con noi che tutti quanti se la pigliano, mica co’ voi.
«È vero», gli ha fatto subitanea eco un altrettanto risentito testimone, esasperato dal lungo periodo di attesa dinanzi la porta sbarrata della cottora:
il fatto che la festa sarà ancora più conosciuta va bene, è una bella cosa, però ora si comincia a esagerare. La gente si lamenta perché viene allontanata per lasciare il posto ai politici e perché non viene fatta entrare fino a quando voi [la troupe] non ve ne andate. Io allora dico: se volete venire alla festa venite pure, ma come tutti gli altri. Fate una cosa tranquilla. La festa è la nostra e voi aspettate. Vi mettete in fila e aspettate. Non esiste che io e i miei amici veniamo cacciati dalle cottore perché sta arrivando il presidente della regione o perché voi della televisione tardate a fare le vostre riprese. Non esiste proprio!
Questo concitato siparietto veniva dipanandosi mentre tra il nutrito gruppo di astanti si levava a mo’ di coro lo slogan: «fuori la Rai dalla festa!»
Finalmente, a partire dalla mezzanotte, malgrado intralci e dilazioni di ogni sorta, i festeggiamenti hanno ripreso a seguire il loro giusto corso. Eclissatisi gli illustri ospiti e ristabiliti i ritmi consueti di partecipazione al rito, le migliaia di presenti hanno continuato ad aggirarsi caoticamente per le cottore del paese bevendo e mangiando in onore del santo. Alle prime luci dell’alba, scomparsa ogni traccia della presenza forestiera, i collelonghesi si sono finalmente ritrovati nel privato dell’ordine comunitario a celebrare la parte più intima e attesa dell’intero complesso festivo: la premiazione della più bella tra le conche da parata e la conseguente (ri)affermazione dei ranghi di prestigio tra le “razze” o i vari gruppi sodalistici. Il tutto nell’attesa di potersi rivedere l’indomani nei resoconti di un conduttore di Saxa Rubra.
In che modo la presenza del mezzo televisivo nazionale ha agito nel rifondare la festa collelonghese di sant’Antonio abate? Direi che due sono gli ordini di considerazione da doversi valutare: l’uno riguarda le alterazioni che la presenza della troupe Rai ha determinato nelle modalità di svolgimento del rituale, con le eventuali conseguenze – in questo caso apparentemente scongiurate – sulla gestione degli equilibri intra e inter-comunitari; l’altro attiene il modo in cui l’immagine della festa è stata dapprima ricercata, quindi riproposta nella successiva messa in onda delle riprese filmate.
La festa come prestazione di tipo agonistico
La ricorrenza di gennaio, rappresenta per la collettività del piccolo paese dell’Abruzzo montano un evento celebrativo i cui significati si collocano su un piano di interessi che travalica la sfera del semplice dato religioso-devozionale. L’offerta e il consumo rituale dei cicerocchi, infatti, se da una parte rinvia ad una pratica propiziatoria di natura magico-religiosa , propria dell’ideologia contadina arcaica, dall’altra assembla su di sé valori che investono il campo della competizione e dell’affermazione del prestigio sociale, individuale e di gruppo.
La posta in gioco si presenta ogni volta elevatissima: dalla riuscita o meno della festa può infatti derivare l'accrescimento o lo scadimento della reputazione di chi ne cura direttamente l’organizzazione. E poiché la composizione del comitato dei festeggiamenti sembra riflettere di volta in volta una precisa componente ceto-anagrafica della comunità locale, ecco allora che la riuscita o il fallimento della festa può conseguentemente tradursi, agli occhi dell’intero paese, nell’affermazione, o nel declassamento, di questa o di quella specifica categoria di persone. Un affermazione e/o declassamento i cui effetti possono arrivare a coinvolgere la sfera della stessa amministrazione politica che ha il compito di sovrintendere all’allestimento logistico, e in parte finanziario, dell’evento.
Ma non è solo il piano delle relazioni intra-comunitarie a risentire degli esiti della festa. Questi, infatti, possono arrivare a coinvolgere anche il campo dei rapporti inter-comunitari che insistono tra Collelongo ed i paesi posti nelle sue immediate adiacenze: primi tra tutti Trasacco e Villavallelonga. In essi, contemporaneamente alla festa dei cicerocchi, si celebrano da antica data due feste similari che vedono nel santo anacoreta egiziano ancora una volta l’indiscusso protagonista. Sebbene tali eventi si svolgano secondo procedimenti simbolici e ritualistici di diversa natura, tuttavia la distribuzione gratuita di cibo rappresenta per entrambi la componente cerimoniale di maggiore interesse collettivo; un interesse che ogni anno mobilita un discreto contingente di forestieri provenienti dall’intero territorio della Marsica. Benché l’entità dei partecipanti ai tre diversi contesti non sia mai stato minimamente paragonabile in termini numerici (a sicuro vantaggio di Collelongo), è tuttavia evidente che la competizione festiva costituisce un campo di confronto aperto su cui i singoli paesi sono chiamati necessariamente a misurarsi. A rappresentare la posta in gioco non ci sono solo gli intensi spiriti campanilistici espressi dagli abitanti di ciascuna località: c’è anche, e soprattutto, la capacità di saper gestire con vantaggio un’offerta ludico-ricreativa in grado di attrarre la parte più cospicua di una domanda turistica in costante incremento.
La distorsione dello sguardo televisivo
L’altro ordine di considerazione da doversi valutare, al fine di delineare il carattere rifondativo della festa, attiene al modo in cui la sua immagine è stata riproposta nel servizio televisivo ad essa dedicato. Come spesso accade quando la tivù prende a soggetto il mondo della realtà popolare, anche nel caso in questione è stata messa in onda una lettura pittoresca dell’evento tutta tesa a far risaltare – in alcuni minuti di esposizione – le sue sfaccettature folcloristiche, accentuandone le componenti ludiche, orgiastiche, e goderecce: sfilata di comparse in costume tradizionale, bevute di vino, abbondanza di alimenti, manipolazione del fuoco; componenti che, per quanto rivestano un ruolo importante nella coreografia della festa tuttavia non ne esauriscono sostanza, svolgimento e interessi. Si potrà a questo punto obiettare che compito della televisione generalista non è quello di proporre delle letture antropologiche della società nel cui seno essa opera, bensì quello di offrire spettacolo, fare intrattenimento, incrementare l’audience. E su ciò, credo, una ragionevole dose di buon senso potrà trovarci tutti d’accordo. Ciò non toglie che potrebbero essere prese in considerazione letture “diverse” di quelle stesse realtà tali da sfuggire ai banali cliché cui il telespettatore è abituato (destinato!) ad assistere con sempre maggiore frequenza. Con questa opinione voglio ricondurmi ad un discorso di portata più generale che verte sul modo in cui i modelli di cultura dominanti, di cui la televisione è il formidabile portavoce, si rapportano alla realtà del mondo popolare.
La televisione, tanto quella pubblica che quella commerciale, osserva il mondo della cultura folklorica attraverso una serie di stereotipie risolutamente incanalate all’interno di una gamma fissa di situazioni. Tra queste situazioni è innanzitutto la festa, ma anche la fiera, la sagra, la parata in costume ad intercettare ed esaurire la parte più considerevole dell’interesse mass-mediatico. In più, all’interno di queste uniche, o quasi uniche, situazioni l’attenzione delle telecamere sembra privilegiare esclusivamente alcuni tratti, o performance, a scapito di tutti gli altri: figuranti in abito tradizionale che danzano o posano in continuazione; orchestrine che eseguono lisci, tarantelle o saltarelli; tavolate dove si cucina secondo “antiche” ricette o dove si espongono abbondanti prelibatezze gastronomiche degne di una corte rinascimentale; caratterizzazione colorita, dei personaggi.
Il mondo folklorico sembra dunque trasparire agli occhi di una diffusa programmazione televisiva, come lo spazio e il tempo di una festa permanente che si contrappone strutturalmente alla dimensione frenetica, produttiva ed alienante della realtà metropolitana. Una dimensione in cui risiedono, in perfetta modulazione e in evidente atmosfera di astoricità, dimensione ludico-infantile dell’esistenza, veracità delle tradizioni, armonia dei rapporti interpersonali, eufonia tra uomo ed ambiente.
In un recente programma di intrattenimento andato in onda domenica 1 giugno 2003 su una emittente del maggiore gruppo televisivo commerciale nazionale il conduttore, dovendo commentare una delle tante manifestazioni popolari che animano il panorama dell’Italia rurale, ha esordito pronunciando le seguenti parole:
Benvenuti a Arquà Petrarca, dove tutto è rimasto come nel 1200, nel 1300 meglio, quando Petrarca venne qui a vivere e trascorse gli ultimi anni della sua esistenza. Quando dico che tutto è rimasto come allora non scherzo, come potete vedere dal pane che si sta preparando nel modo in cui si faceva nel Medioevo. Il grano duro viene ancora oggi messo in macine di pietra e poi, dopo essere stato ammassato rigorosamente a mano dalle donne del posto viene messo a cuocere in antichi forni di pietra [...].
Tutto questo dire mentre un'orchestrina in costume suonava arie di sapore medievale; una comparsa dalla fisionomia giullaresca muoveva allegramente la macina del grano; massaie operose si affaccendavano a svolgere quella che, secondo le parole del conduttore, sarebbe dovuta essere una loro incombenza quotidiana.
Ma il vero campionario delle stereotipie fatte circolare dalla programmazione televisiva sulla realtà del mondo popolare affiora in tutta la sua persuasiva espressività nel campo della comunicazione pubblicitaria. Nel patinato e suadente universo dei “consigli per gli acquisti” tale realtà si colora di una molteplicità di tratti artatamente contraffatti che sembrano rinviare alle estetizzanti e ottocentesche pagine di un Tommaseo, di un Tigri o di un Giusti.
La dimensione folklorico/rurale diventa così:
- un mondo georgico dove la mietitura del grano costituisce un elemento di corale serenità e al cui interno un’avvenente contadina, per nulla provata dalla fatica del raccolto, si muove tra le messi con un fascio di spighe tra le mani (réclame di un marchio di pasta);
- un luogo idilliaco dove la farina viene prodotta da graziosi mulini ad acqua immersi nei toni pastello di una quiete senza tempo (réclame di un marchio di biscotti);
- una realtà schietta in cui le donne - ignare dei miracoli che possono compiere le lavatrici! - lavano a mano le camicie dei propri mariti con lo scopo di renderle bianche e splendenti (réclame di un marchio di detersivo);
- una dimensione armonica dell’esistenza dove le relazioni inter-generazionali sono improntate all’insegna dell’armonia, dei buoni sentimenti e delle dolci note (réclame di un marchio di prodotti surgelati);
- un ambiente genuino dove si persevera nelle abitudini alimentari sane e naturali di una volta, ma - paganamente! - si ignora la delizia di certi prelibati condimenti (réclame di un marchio di majonese);
- un posto dove il parto di animali si svolge in una dimensione di serena attesa all’interno di spazi dominati dalla compostezza e dal calore domestico (réclame di un marchio di liquori);
- un habitat immacolato dove la natura domina incontrastata in perfetta sintonia con i pastori e le loro greggi (réclame di un marchio di automobili e di un marchio di cioccolato).
Certo, tutti noi possiamo riscontrare che non sono più i tempi in cui i contadini andavano in giro scalzi e a dorso di mulo; che non sono più i tempi in cui la realtà del mondo rurale era così come veniva ritratta nei servizi degli anni ’60 di Nanni Loy o di Sergio Zavoli. Tuttavia mi sembra di poter constatare che non siano neanche più i tempi del sabato del villaggio, degli organetti e dei saltarelli, dei lupini e dei cantastorie, come la televisione, o almeno una certa televisione generalista incline al folklorico e al popolaresco vuol farci ingenuamente credere. Se alla base di queste immagini messe costantemente in onda agisca una qualche forma di nostalgismo storico, di strategia politica, di mistificazione ideologica o semplicemente di abbaglio antropologico è quanto, credo, meriterebbe di essere approfondito con maggiore adeguatezza.
Saggio tratto dal volume di L.Bonato (a cura di), Festa viva. Continuità, mutamento, tradizione, Torino, Omega, edizioni, vol I (II), pp. 37-48
Saggio tratto dal volume di L.Bonato (a cura di), Festa viva. Continuità, mutamento, tradizione, Torino, Omega, edizioni, vol I (II), pp. 231-239.
Saggio tratto dal volume di L.Bonato (a cura di), Festa viva. Continuità, mutamento, tradizione, Torino, Omega, edizioni, vol I (II), pp. 251-258
Cfr. ivi, Marucci, La festa di sant’Antonio abate a Collelongo: tradizione e innovazioni; Salvatore, La festa di S. Antonio Abate a Collelongo: diventare il santo.
Questo modo di denominare la cottora fa rifermento alle simpatie politiche della famiglia che la gestisce.
Lo stesso sindaco, a sua volta, preoccupato dalle ripercussioni che i fatti accaduti avrebbero potuto generare sul piano delle stabilità politiche, a termine dei festeggiamenti mi ha confidato tutta la sua costernazione per la prepotenza manifestata dalla troupe televisiva; esprimendo la ferma decisione a riferire “a chi di dovere” circa gli atteggiamenti colonizzatori che l’intero paese ha dovuto subire nel più assoluto diniego delle regole del rispetto e dell’ospitalità.
Si consulti al riguardo tutta l’interpretazione storico-antropologica del rituale collelonghese elaborata da Alfonso Di Nola, 1976, pp. 179-265.
All’interno dell’organigramma comunitario agiscono diverse componenti in costante confronto dialettico: anziani/giovani, uomini/donne, professionisti/agricoltori, conservatori/tradizionalisti, di destra/di centro-sinistra. Da questa dialettica sociale, la comunità collelonghese trae una formidabile forza propulsiva che anima, ed ha animato, il panorama culturale del paese, rendendolo tra i più dinamici del comprensorio marsicano.
In passato, in base a quanto riferitomi da alcuni intervistati, il mal riuscito funzionamento della festa è stato causa del declino di un’amministrazione politica direttamente coinvolta nella sua cattiva organizzazione.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
DI NOLA A. (1976), Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Torino, Boringhieri.
LOMBARDI SATRIANI L. (1980), Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna, Milano, Rizzoli.
CIRESE A. M. (1986), Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo.
LANTERNARI V. (1983), Festa, carisma, apocalisse, Palermo, Sellerio.
DI RENZO E. (2000), Si parva licet componere magnis. Forme minime di pellegrinaggio, in Marucci Gabriella (a cura di), Il viaggio sacro. Culti pellegrinali e santuari in Abruzzo, Colledara (TE), Andromeda.
MAZZACANE L. (1985), Struttura di festa, Milano, Franco Angeli.
BIANCO C., DEL NINNO M. (1981), Festa. Antropologia e semiotica, Firenze, Nuova Guaraldi.
JESI F. (1997), La festa. Antropologia, etnologia, folklore, Torino, Einaudi.
GIALLOMBARDO F. (1990), Festa, orgia e società, Palermo, Flaccovio.
CLEMENTE P., MUGNAINI F. (2001), Oltre il folklore, Roma, Carocci.
BRAVO G. L. (1984), Festa contadina e società complessa, Milano, Franco Angeli.
Radiotelevisione in festa.
Raccontare la tradizione sui media
Letizia Bindi
L'intervento che presento oggi rappresenta un tassello del lavoro che da qualche anno sto conducendo su una sezione particolare dell'Archivio multimediale della RAI, quella cioè dedicata alla rappresentazione delle tradizioni locali e delle culture popolari italiane sui media e all'attraversamento che le discipline etnoantropologiche hanno compiuto all'interno della produzione mediatica dal dopoguerra in poi.
A partire dalla metà degli anni Novanta, come sappiamo, è cresciuta visibilmente anche nell'azienda la consapevolezza che l'Archivio multimediale rappresentasse uno straordinario patrimonio storico-culturale e si sono moltiplicate le operazioni di digitalizzazione, facilitazione all'accesso, schedatura nonché le produzioni atte a valorizzare tali archivi1.
Il rischio è che questo sforzo di valorizzazione manchi di un'analisi critica delle strategie di rappresentazione delle culture popolari e che soprattutto non problematizzi a sufficienza il complesso rapporto che viene ad instaurarsi nelle società mediatiche tra culture tradizionali e locali, cultura di massa e cultura d'elite, questione questa su cui hanno riflettuto molto negli ultimi anni alcuni studiosi anglosassoni, come ad esempio Fiske (1988) o Bauman (1992) e intellettuali nostrani come Pier Paolo Pasolini che già nel 1953 interveniva sulle pagine del RadioCorriere con un articolo su Cultura di massa e cultura popolare (1953). Più recentemente sono tornati su questo dibattito, per ciò che concerne l'Italia, Francesco Faeta (1998) e Fabio Dei (2003) e, da un settore di studi non specificamente demoantropologico, un giovane studioso come Franciscu Sedda (2002).
In anni precedenti, e rivolto ad un periodo storico antecedente l'era mediatica, ma ugualmente cruciale per la comprensione dei rapporti tra cultura d'elite, culture tradizionali e cultura di massa e per l'importanza che le rappresentazioni intellettuali del 'folklore' hanno avuto - e, aggiungerei, possono avere anche oggi - nella gestione delle strategie identitarie a livello locale, resta invece fondamentale il contributo che Luigi Lombardi Satriani ha dato con un testo come Il silenzio, la memoria e lo sguardo (1979).
Gli oggetti mediatici hanno d'altronde occupato anche la riflessione accademica nordamericana più recente che pure ha spostato l'asse dell'interesse sui media gestiti e pensati da membri di comunità etniche native o marginali rispetto ai grandi circuiti della 'cultura pubblica', come forma di riscatto e nuova assertività identitaria, fornendo un'interessante apertura allo studio dei materiali anche italiani in una chiave rinnovata di analisi, come pratiche, cioè, di rappresentazione delle identità di cui, a mio giudizio, può molto beneficiare sia la storia dei nostri studi sia l'approfondimento delle strategie di patrimonializzazione oggi sempre più cruciali sul piano della circolazione pubblica dei contenuti afferenti alle culture locali (Ginsburg, Abu-Lughod e Larkin (a cura di), 2003), ma anche testi più strettamente concentrati sulle modalità di indagine etnografica attraverso l'impiego delle nuove tecnologie audiovisuali (Jules-Rosette e Bellman, 1977).
Da qualche anno perciò ho iniziato ad analizzare con maggiore sistematicità gli archivi multimediali della RAI al fine sia di analizzarne il contenuto di interesse specificamente demoantropologico (trasmissioni curate o ideate da colleghi, documentari etnografici realizzali grazie al contributo della televisione italiana o realizzati autonomamente e dunque trasmessi dalla RAI, programmi a interesse 'folklorico' o 'turistico'), ma anche ad interrogarmi sul modo in cui il 'folklore' e la categoria di 'folklore' attraversi tali archivi e come la programmazione realizzata a partire da questi patrimoni audiovisivi consenta di comprendere meglio sia il contesto culturale in cui essi venivano raccolti e quindi trasformati in prodotto mediatico (carteggi, programmazione, consulenze, finanziamenti, in una parola forse desueta il livello strutturale della produzione mediatica di programmi e notizie a interesse locale e tradizionale) sia gli specifici prodotti risultanti da questo circuito culturale e decisionale (analisi dei contenuti, delle modalità estetiche e semiotiche di costruzione dei messaggi, delle notizie e dei programmi, uso e abuso dei testi a commento delle immagini, ecc.).
Il lavoro che ne risulta è complesso e talora difficoltoso sia per la lacunosità - casuale talora, altre volte meno - degli archivi cartacei dell'azienda, sia per una relativa scarsità di testimonianze su questi problemi, sia infine per la complessità culturale e politica degli 'oggetti'/prodotti analizzati.
Una cosa è certa però: la categoria 'folklore' conta più di 8000 voci nell'archivio multimediale della RAI, viene per lo più impiegata per indicare tradizioni locali italiane, è guarnita quasi sempre di attributi regionali (folklore campano, folklore toscano, ecc.), esclude l'impiego di altre chiavi di catalogazione come demologico, popolare, campanile o derivati, si sovrappone, ma solo raramente a 'tradizione', nella particolare accezione di 'tradizioni popolari', comunque assai meno rappresentato del primo in questa filza di termini.
La prima schedatura risale alla metà degli anni Settanta e risente probabilmente dell'ondata revivalistica che dette origine, in quegli anni, a un interesse diffuso, anche se spesso non specialistico, verso il mondo rurale, il Meridione, le tradizioni locali, le culture popolari. In una parola la stagione del 'folk' come grande prodotto di massa, progressivo o regressivo che lo si intendesse.
Si tratta di materiali compositi, per genere e stili di ripresa da cui ho scelto oggi di presentare la traccia audiovisuale presente nell'Archivio Storico della RAI di una sola, particolare festa, particolarmente adatta però a mostrare, a mio giudizio, sia le possibilità euristiche di un'indagine di questo genere sia a suggerire alcune riflessioni sul modo in cui la tradizione è stata costruita, manipolata e gestita dai poteri mediatici, ma anche da un'estetica comunicativa che, a partire dagli anni Cinquanta in poi, privilegia linguaggi omogenei e tende a fornire una precisa idea del Paese inteso come 'comunità immaginata' rispetto alla diversità interna della realtà geografica e culturale italiana2.
La festa è quella di Piedigrotta, 'oggetto' già di per sé complesso, non foss'altro per la sovrapposizione al suo interno di elementi di culto tradizionale e ufficiale e per la relativamente precoce - a partire già dalla fine dell'Ottocento - sovrapposizione della festa tradizionale con la competizione canora che si può a buon diritto considerare uno dei massimi antecedenti dello spettacolo nazional-popolare, 'alla Sanremo', così come noi lo conosciamo oggi.
Già lo stesso Granisci d'altronde parlava di Piedigrotta come 'festa' fiaccata sul piano delle tradizioni e divenuta usanza massificata e strapaesana e la condannava come 'spettacolo' regressivo e 'repressivo' della cultura popolare, come espressione di provincialismo folkloristico3.
Ai suoi tempi tuttavia di Piedigrotta già si parlava come di una competizione locale che per l'importanza ricoperta dalla tradizione della canzone napoletana in Italia e nel mondo - nobilitata tra l'altro dalla presenza di romanze attribuite a nomi altisonanti della musica colta e operistica (Donizzetti ad esempio) - assurgeva ad una notorietà impensabile per le feste tradizionali presenti nel resto del Paese, sbalzandola di diritto agli onori delle cronache nazionali.
Piedigrotta ci appare, dunque, già agli inizi del secolo come un prodotto ibrido, capace di richiamare un pubblico non solo popolare, ma colto, non solo locale, ma nazionale e di incuriosire persino gli intellettuali d'avanguardia come Mannelli, ma anche Capuana, Scarfoglio, Serao, Viviani.
Era evidente che una festa che fin dalla fine dell'Ottocento si era progressivamente trasformata sovrapponendo all'impianto originario, di tipo tradizionale, agricolo quello metropolitano, nazionale e sovranazionale dell'industria del turismo e dello spettacolo, dell'intrattenimento e della vera e propria produzione mediatica - editoria discografica, periodici, e quindi anche film, sin dai primi anni Venti, e quindi dirette radiofoniche, non appena ve ne fu la possibilità, ovvero negli anni Trenta - divenisse un 'oggetto mediatico' eccellente per la moderna comunicazione radiotelevisiva che all'indomani della guerra si incaricò di raccontare le realtà diverse del Paese e di elevare a 'prodotti nazionali' quegli aspetti delle culture locali che sembravano maggiormente adatti a rappresentare la tipicità della cultura italiana, nonché una certa immagine del Meridione d'Italia come luogo di amenità spensierate, elemento questo, specie per l'area napoletana, destinato a rimanere particolarmente persistente nell'iconografia cinematografica e nel bozzettismo letterario fino ad anni recenti.
Stretta entro la categoria regionalistica di 'folklore campano' Piedigrotta è infatti massicciamente rappresentata negli archivi della RAI fin dagli anni Cinquanta, in trasmissioni sia radiofoniche che televisive e in prodotti destinati sin al pubblico colto che ai notiziari generalisti. Accanto a questi documenti RAI si aggiungono tra l'altro una rilevante quantità di filmati - compresi tra il 1936 e il 1962 - raccolti dall'Istituto Luce in veri e propri piccoli documentati da trasmettere nella ben nota Settimana Incom. un genere di intrattenimento cinematografico - piccoli cinegiornali - che anticipò, per molti versi, i rotocalchi di costume della successiva programmazione televisiva e giornalistica.
Già a partire dalla metà dell'Ottocento, d'altronde, e con un'intensificazione progressiva, la festa aveva sempre più perso l'aspetto di una ricorrenza del calendario agrario tradizionale, intessuto di culti pagani e di reminiscenze borboniche - come ad esempio la parata militare istituita a partire dal Seicento che celebrava la vittoria dei Borboni a Napoli e che culminava nella processione del re al santuario -, per divenire uno spettacolo di massa intrecciato con le vicende dell'industria culturale regionale e persino nazionale, soprattutto grazie alla competizione canora che caratterizzava le giornate precedenti le celebrazioni dell'8 Settembre, costituendosi come vera e propria icona della 'napoletanità' nel mondo. Al tempo stesso però la festa era divenuta un vero e proprio oggetto 'eccellente' per le avanguardie: le sue luminare, i suoi suoni popolareschi ottenuti con strumenti meccanici di percussione o a fiato come il putipù, lo Scetavaiasse e il Triccabballacche, che erano stati cantati dalla poesia futurista, accanto all'atmosfera, anch'essa 'elettrica' dei cafè-chantants napoletani, come esempio della mistura di antico e moderno, affascinavano i poeti e gli artisti degli anni Dieci e Venti. Accanto alle luminare erano apparsi infatti presto, in galleria Umberto, i cinescopi e i grammofoni Edison, che permettevano di riascoltare e riprodurre le melodie di successo della competizione canora un tempo nata in contesto esclusivamente tradizionale come canto a contrasto cerimoniale nella grotta di Pozzuoli.
Di tutto questo risente l'icona mediatica della festa così come ci viene restituita dai documenti dell'Archivio RAI e dell'Istituto Luce.
Rumori di folla, fascino per la presa diretta - specie negli anni Cinquanta - elemento questo che si deve probabilmente mettere in relazione alla recente e avvincente scoperta da parte dei giornalisti così come degli etnografi delle potenzialità messe a disposizione dalle nuove tecniche di riproduzione e registrazione4. Carri allegorici, luminare e fuochi d'artificio.
La festa in televisione si spettacolarizza ulteriormente. Diviene bagno di 'gente', ritiene ed esalta soprattutto gli aspetti eclatanti dell'evento folklorico. essenzializza il racconto delle celebrazioni.
Non si tratta di semplice curiosità antiquaria, né solo di nostalgia rispetto a ciò che si sta perdendo, per quanto molti dei servizi presentino testi fuori campo di questo tono, enunciati sia da speakers anonimi che da 'testimoni nativi': «era meglio prima..., Piedigrotta non è più la stessa...», e simili adagi... Lo spettacolo della festa sembra essere la condizione essenziale della sua immissione nel circuito comunicativo e nazionale, la sua emergenza come eccezionaiità e intenso esempio di 'colore' locale sembra rappresentare la condizione primaria del suo salvataggio nella forma audiovisuale del servizio o del filmato, della notizia insomma.
La festa in televisione, inoltre, diviene fatto 'tipico’, evento reiterato e sempre uguale a se stesso. Fa parte del suo essere oggetto 'buono da filmare' il fatto che essa rappresenti una costante, una ricorrenza. Se ne esaltano gli elementi di continuità, si inseriscono nei servizi spezzoni di repertorio presi dall'archivio degli anni e dei decenni precedenti, si articola un rappor-lo tra passato e presente folklorico nell'ordine dell'identico assai più che della trasformazione e del cambiamento.
Se ne ricordano al contempo gli antichi splendori, l'intreccio, cui facevo riferimento in precedenza con la tradizione colta - prestigio della canzone napoletana, attenzione da parte di personaggi illustri -, in una parola la si nobilita attraverso l'immissione nei circuiti della cultura 'alta' attribuendo con ciò implicitamente valore deteriore all'esclusivo circuito popolare su cui si muovono altre festività locali, anche campane.
Non è inoltre irrilevante che essa faccia parte di quella sottocategoria regionale - il 'folklore campano' per l'appunto - che conta moltissimi documenti presenti nell'archivio. Sembra infatti esserci una sorta di predilezione per questa specifica area italiana in materia di rappresentazioni mediatiche del folklore: moltissimi servizi sulla festa di San Gennaro, su Guardiasanframondi, sulla Madonna dell'Arco, sulla sceneggiata napoletana, su Pulcinella e le altre maschere tradizionali, sulla smorfia e il gioco del lotto.
In un intenso documentario radiofonico del 1962. realizzato da Mario Pogliotti e Pietro Santo Stefano - insignito tra l'altro per quell'anno del Premio Italia - dall'evocativo titolo di Ascolto di una città, le melodie dei posteggiatori si mescolano alle grida reiterate dei mercati, alle preghiere delle donne durante le celebrazioni, agli scoppi dei 'botti', dei giochi pirotecnici, al rumore della lava che scende dal Vesuvio, di cui uno dei testimoni 'nativi' dice di conoscere ogni sfumatura, perché lui, 'la voce del Vesuvio l'ha studiata' e ne può fare un 'discorso scientifico'. Il registro della sonorità, sia essa modulare e melodica - come nelle canzoni della competizione piedigrottana - o travolgente e naturalistica - come la voce del vulcano che si mescola con i suoni della campagna circostante, ma anche con le sonorità artigiane dei vicoli cittadini -, sembra comunque essere una costante della rappresentazione del folklore popolare campano e in particolare delle sue occorrenze festive, al punto che in un documentario, di molti anni successivo, del 1992 per Bellitalia, il documentario radiofonico del 1962 viene riproposto come colonna sonora del montaggio visivo dei siti e delle cerimonie, degli usi quotidiani e della gestualità diffusa di una città che finendo per inglobare la propria campagna, ne ha assorbito e fatto propri gli stilemi comunicativi e i registri espressivi, primo tra tutti quello della canzone, pur modellandolo ed adattandolo alle modalità della fruizione metropolitana necessariamente più spettacolare e massificata.
Napoli e la Campania comunque sembrano rappresentare una specie di oggetto privilegiato della divulgazione mediatica in materia di tradizioni locali e contribuiscono a quella tipizzazione del folklore che vuole il mondo popolare allegro e spensierato, canterino e ballerino, affascinato dai fuochi e dalle luci, 'stuporoso', in qualche modo 'bambino’. In questo senso tra l'altro la presenza tradizionale dei bambini nel culto popolare di Piedigrotta - bambini mascherati, bambini a frotte che inseguono Pulcinella, bambini inquadrati mentre ammirano stupiti le luci delle luminarie e dei fuochi - aiutava ulteriormente la tipizzazione in chiave fiabesca della festa. In un servizio del 1962, ad esempio, lo speaker viene ripreso letteralmente immerso in una folla di bambini che si stanno intrattenendo con un attore vestito da Pulcinella; un altro servizio, del 1969, inizia con le riprese di un laboratorio di sartoria, modesto e popolare, in cui si stanno confezionando gli abiti per la mascherata e la telecamera indulge in modo prepotente sulla vestizione e le espressioni rapite dei bambini che escono dal laboratorio agghindati per la festa.
Livelli diversi della narrazione, comunque, si sovrappongono. Lo speaker propone una sorta di discorso normativo che introduce alla ricorrenza festiva e poi 'gira il microfono' alla folla di bambini chiedendo loro di commentare le celebrazioni tradizionali che si stanno aprendo, con il risultato ovvio di veder ripercorso l'intero repertorio di 'mirabilia' cui l'iconografia televisiva intendeva far riferimento: luci, fuochi, carri in notturna, gente, bancarelle, canti...
La Piedigrotta televisiva è un luogo pirotecnico e 'strapaesano', in cui la folla e indistinta - seppure, a partire dalla fine degli anni sessanta, appaiano nei filmati di repertorio anche brevi interviste alla 'gente' del luogo. Le uniche voci e facce che ricevono definizione e nominazione sono quelle di intellettuali, scrittori e rappresentanti delle istituzioni chiamati a commentare e suggellare le immagini prese 'in piazza'. E’ così che appaiono attori e cantanti, autorità pubbliche, come il sindaco Lauro nel servizio dell'Istituto Luce del 1956 dal significativo titolo di Napoli che non se ne va. Nella città più festosa del mondo, la festa più bella del mondo che è poi anche la frase con cui si apre il breve servizio nel quale, per mettere in evidenza la partecipazione generalizzata alle celebrazioni settembrine, l'autore del servizio ci teneva a mettere in rilievo che alla festa partecipavano tutti, ma proprio tutti, "dal primo cittadino (inquadratura) all'ultimo guappo (inquadratura)'': dialettica alto-basso, istituzionale/eversivo mirante ad accentuare l'aspetto non conflittuale, ecumenico della festa come luogo di reintegrazione e ricomposizione della comunità, ma anche, proprio per questo di apertura della comunità, con le sue bellezze e le sue risorse tradizionali, canore, spettacolari al resto del mondo.
Il montaggio di questo particolare documentario - inserito nella Settimana Incom del 15/9/1956 - si faceva sul finire particolarmente concitato: immagini sfuocate, smorfie sorridenti e talora sguaiate della folla che partecipava alle celebrazioni, luci, fuochi, lava, fumo del Vesuvio e frasi a commento del tipo 'il luminescente sangue torna a scorrere nelle vene della Napoli com’era; segno questo di una percezione già acuta - com'era comprensibile già dal titolo - della progressiva usura della tradizione in favore di uno spettacolo forse più massificato e, come viene detto da un altro speaker RAI nel servizio del 1969, di una festa che poco a poco ha visto il 'popolino' trasformarsi sempre più 'da protagonista in spettatore' della festa.
Una festa sempre più spettacolare e industrializzata, persino - sono di questi stessi anni gli inserimenti nel montaggio dei documentari e dei servizi di moltissime immagini che tendono a documentare la 'fabbrica della festa': impalcature gigantesche per le luminarie, preparazione dei fuochi d'artificio, costruzione di carri allegorici sempre più sfarzosi e sempre più lontani, anche tematicamente, dai contenuti rurali dei carri 'pacchiani' che originariamente accompagnavano la processione verso la Chiesa della Madonna con il loro carico colorato e rumoroso di contadini, bambini, animali e vettovaglie. A proposito di quest'ultima annotazione si può forse notare che la penetrazione progressiva dei mezzi di comunicazione di massa - nel 69 ormai già più che decennale -, specie della televisione, nella fruizione comunicativa quotidiana aveva di certo pesantemente contribuito a questa progressiva trasformazione della popolazione :da protagonista in spettatrice e che questa probabilmente risulta essere, più generalmente, una delle conseguenze più radicali dell'entrata delle comunicazioni di massa nel vissuto quotidiano delle comunità e delle singole famiglie. La festa tradizionale infatti richiede, e richiedeva, un forte grado di protagonismo individuale e collettivo, rappresenta per certi versi un modo della comunità per mettere in scena se stessa, per rappresentarsi e farsi personaggio di una performance, mentre la sua trasformazione in prodotto mediatico - quanto più industrializzato e 'turistizzato' tanto più eterodiretto rispetto al cuore della comunità - la trasforma in oggetto di visione e per ciò stesso la aliena dalla comunità, che ne resta, almeno in parte, spossessata.
Le voci del popolo restano anonime, intervistate in mezzo al resto della folla, nel rumore inaugurando così un vero e proprio stilema della nostra televisione, cioè quello dell'intervista 'all'uomo della strada' come rappresentante anonimo, tipico quanto subalterno di una realtà popolare e tradizionale confezionata, raccontata e prodotta - in termini sia intellettuali che industriali ormai - dai membri della classe dirigente. Si brucia nel giro di un decennio - i Cinquanta per l'appunto - ogni velleità di 'neorealismo radiofonico' e si imbocca, a partire dai Sessanta, un'idea di 'popolare' unitaria in cui il campanile, i campanili si fanno bozzetto e macchietta e divengono funzionali allo sketch comico o al gioco a squadre (Bindi, 2002).
L'Italia, quella vera - sembrano suggerire questi materiali - è 'una e indivisibile' e ride e gioca con le sue diversità interne perché non rappresentano più un problema, anche se in quegli stessi anni il cinema e una certa comunicazione d'elite provvedono a far conoscere il dramma dell'emigrazione interna ed esterna, dal Sud verso il Nord, dalle campagne verso le città (Rocco e i suoi fratelli, Accattone, ecc.).
Loro, i protagonisti muti di queste vicende, devono poter credere che il Paese è fatto e che la nuova 'piazza' multimediale5 è capace abbastanza per tenerli insieme tutti.
Qui siamo ancora dinanzi a un'idea del folklore come divertissement, che risente anche di paradigmi esotizzanti, orientalizzanti - specie, è ovvio, nei servizi dedicati a feste e tradizioni del Meridione d'Italia6.
È ovvio dunque che Piedigrotta resti un'icona, traccia del suo passato arcaico e di quello meno arcaico, ma altrettanto 'tipico' della competizione canora e comunque sempre grande spettacolo, curiosità locale che 'diverte' e rende sapido il messaggio audiovisivo con immagini rassicuranti e decongestionate, lontane da ogni accenno di resistenza e problematicità interne allo spazio del 'folklore'.
Chi voglia indagare in profondità i contesti etnografici di produzione e programmazione radiotelevisiva in materia di tradizioni e di folklore dovrà documentarsi sulle dinamiche aziendali, le strategie politiche e culturali che hanno presieduto alle scelte di programmazione in tal senso nei nostri notiziari e rotocalchi, e che hanno contribuito a comporre, nei decenni, una sorta di 'calendario immaginario del folklore’ fatto di 'scenette con data'. Il Paese, infatti, è cambiato e cambia, ma porta con sé memorie del passato, le riformula e le riadatta alle nuove modalità del vivere, alle esigenze della società del consumo, ai tempi e ai ritmi della produzione industriale, perché solo così riesce a immaginarsi e pensarsi senza totalmente 'spaesarsi': tema caro questo all'ultima, vibrante riflessione demartiniana sia sul piano delle rappresentazioni individuali che di quelle collettive7.
Una festa come Piedigrotta continua dunque a occupare tanto a lungo gli schermi televisivi per il suo carico di spettacolarità, ma anche perché contiene in sé tutte le contraddizioni della complessa trasformazione che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi. Si fa festa 'in icona', capace di soddisfare il progetto nazionale e mediatico di una cultura unitaria e popolare che se da un lato propone una rappresentazione modernista del Paese, al tempo stesso intende occultare le molte difficoltà della transizione da un'economia arretrata e rurale ad un'economia di mercato. Quello stesso progetto nazionale che intende superare gli scogli primari per l'unità culturale del Paese, come l'analfabetismo o l'asimmetria economica e sociale del Sud rispetto al Nord, nelle forme però spesso esclusivamente virtuali del messaggio mediatico.
Il Sud tradizionale, pro-televisivo rimane ancora a lungo quello canoro e scintillante dei fuochi dì Piedigrotta e di Te voglio bene assaje, magari accompagnati da un piatto tipico e da un buon vino campano.
NOTE
1 Si ricorderà in proposito l'intervento di Barbara Scaramucci, Direttrice delle Teche RAI, al Convegno AISEA dedicato ai Patrimoni Demoetnoantropologici, ma anche le molte trasmissioni di storia che negli ultimi anni sono state trasmesse dai canali RAI: La storia in prima serata, La grande storia. La Superstorìa, ecc.
2La nozione di 'comunità immaginate' proviene, come è ovvio, dal testo omonimo di B. Anderson (1998).
3 La citazione di A. Granisci è tratta da Idem (1977), p. 95. Scrive testualmente Gramsci: «Piedigrotta. In un articolo sul "Lavoro" (8 settembre 1929) Adriano Tilgher scrive che la poesia dialettale napoletana e quindi in gran parte la fortuna delle canzoni di Piedigrotta è in fiera crisi. Se ne sarebbero essiccate le due grandi fonti: realismo e sentimentalismo. […] La crisi di Piedigrotta è veramente un segno dei tempi. La teorizzazione di Strapaese ha ucciso strapaese (in realtà si voleva fissare un figurino tendenzioso di strapaese assai ammuffito e scimunito). Non sì ride più dì cuore: si sogghigna e si da dell'arguzia meccanica tipo Campanile. La fonte di Piedigrotta non si è essiccata, è stata essiccata perché era diventata "ufficiale" e i canzonieri erano diventati funzionari (vedi Libero Bovio)».
4 Si pensi a quanto questa novità rappresentò uno spartiacque anche nella realizzazione delle ricerche etnografiche di de Martino, Carpitella, Lomax. Cirese ed altri nel corso dei decenni successivi. Su questo ho avuto modo di riflettere in E. de Martino (20o3), pp. 137-161.
5 Isneghi M. (1998).
6 E’ anche grazie, d'altronde, alla riflessione critica recente da parte di studiosi stranieri delle culture tradizionali del Mezzogiorno d'Italia che oggi siamo in grado di riconoscere in alcune modalità di rappresentazione colta o ufficiale, nazionale del Mezzogiorno tracce di un 'orientalismo interno' che probabilmente attraversa la nostra letteratura e la nostra comunicazione élitaria da molto più tempo, come ci ricordava qualche anno fa, in un bell’intervento al Convegno AISEA dedicato al Patrimonio, Marino Mola parlando della Napoli popolare o popolareggiante dei romanzi della Serao e di altri scrittori. Cfr. Schneider J. e P. (1974; 1976).
7 De Martino E. (1977).
APPENDICE
Su alcune pratiche attuali della festa in ambito profano:
il caso delle sagre gastronomiche laziali
Ernesto DI RENZO
Premessa
Al viaggiatore che, in un qualunque fine-settimana estivo, si trovasse a transitare nelle piazze principali di Orvinio, Picinisco, Rocca di Papa, Vallerano, Campodimele o di una qualsiasi altra località del Lazio rurale, si prospetterebbe allo sguardo una realtà dai contorni così identificati: strade interdette al traffico in prossimità di aree rese temporaneamente pedonali; autovetture in sosta continuata lungo i percorsi di accesso ai centri storici; atmosfera di festa e di effervescenza collettiva vivacizzata da musiche di accento popolare; piazze e corsi gremiti da animate tavolate indugianti nel consumo di castagne, o polenta, o zuppe, o cocomero, o vino; padiglioni fugacemente allestiti dove solerti abitanti del luogo, divenuti per l’occasione cuochi, camerieri, vivandieri, dispensano senza sosta cibi e bevande a comitive di forestieri in procinto del proprio turno di degustazione. Tutto questo, ed altro ancora, sono le sagre gastronomiche, i rinomati appuntamenti culinari dei weekend fuori-porta che spingono stuoli di gitanti a calcare le strade dei borghi di provincia con lo scopo di assaporare piatti e ricette di dichiarata tradizione locale.
Eredi probabilmente delle antiche cerimonie con le quali in passato si usava accompagnare la consacrazione di edifici di culto mediante fiere, mercati e consumo collettivo di cibo, le sagre rappresentano oggi uno degli eventi ludico-popolari di maggiore consenso partecipazionistico cui aderiscono numerosi abitudinari della cosiddetta vacanza “mordi e fuggi”. Rappresentano, inoltre, una delle modalità più ricorrenti con cui la società urbana si rapporta al mondo delle tradizioni folcloriche, fruendone quella che ritiene essere la sua componente culturale più autentica e rappresentativa.
Le presenti riflessioni, nel quadro di una prospettiva di ricerca di impostazione socio-antropologica, si propongono di porre in luce alcuni elementi di conoscenza volti a restituire spazi di significatività all’odierno fenomeno delle sagre laziali, cogliendone le eventuali relazioni che intercorrono con il tempo calendariale, l’ambiente, le società e le economie locali al cui interno risultano funzionalmente collegate. Nello stesso tempo, si prefigge di far trapelare la contestualizzazione rurale e periferica del loro svolgimento, esplicitandone la fondamentale assenza dagli schemi comportamentali in uso negli ambienti cittadini. Ciò non di meno, posta l’entità della domanda turistica che sono in grado di attivare, si prefiggono di mettere in risalto il modo in cui le sagre giochino un ruolo determinante nella promozione e nella valorizzazione delle aree più marginali della regione, facendo spesso da volano ad economie devitalizzate dall’accentramento produttivo circoscritto a ben limitati distretti del territorio laziale.
Tutto ciò tenendo debitamente conto delle implicazioni che questi eventi esprimono al cospetto dei recenti dibattiti scientifici scaturiti attorno ai temi del folclore, del suo senso attuale e delle sue possibili strumentalizzazioni commerciali messe in atto dai modelli di cultura dominante. Modelli che, nell’esaltazione mass-mediatica dei valori tradizionalistici, e nella riproposizione di abusati clichè romantico-ottocenteschi, conducono spesso ad una distorsione prospettica del mondo rurale/contadino: esaltandone i soli aspetti ludico-esteriori e celandone le numerose problematicità sociali ed economiche.
Breve profilo socio-antropologico delle sagre
Nel Lazio, così come nell’intera geografia regionale italiana, le sagre gastronomiche costituiscono un fenomeno collettivo di recente affermazione. Un fenomeno complesso e sotto molti punti di vista controverso che, non potendosi sbrigativamente riguardare come un succedaneo della festa “paesana” consueta, occupa un ruolo di primissimo piano nelle moderne pratiche di fruizione dell’universo folclorico. Sebbene alcune vantino uno spessore storico dotato di una certa significatività, la quasi totalità di esse colloca la propria nascita in epoche cronologiche del tutto recenti. Al loro fortunato radicamento, inziato a partire dagli anni ‘70 dello scorso secolo e proseguito con ritmi esponenziali nei decenni successivi, ha contribuito una molteplicità di fattori tra cui spiccano con evidenza:
- il superamento di una economia agraria di sussistenza volta essenzialmente all’autoproduzione e all’autoconsumo familiare;
- la derivata maggiore disponibilità di risorse alimentari da destinare alla redistribuzione collettiva e alla vendita;
- la più ampia flessibilità lavorativa che si accompagna alla possibilità di usufruire di maggiore tempo libero da destinare al divertimento e allo svago;
- la generalizzata e diffusa disponibilità di mezzi di spostamento ad uso privato e personale;
- la più rilevante utilizzabilità di denaro da assegnare allo svolgimento di bisogni di non primaria necessità;
- il rinnovato interesse, iniziato a partire dalla fine degli anni ‘60 anni, verso il mondo del passato e il conseguente affermarsi di revivalismi culturali tendenti a contrastare l’egemonia dei modelli sociali urbanocentrici;
- la conseguente esaltazione dei localismi identitari a scapito dei globalismi alienanti e deculturativi; una esaltazione che, tradotta nei termini del discorso alimentare, ha prodotto una rivalutazione (mass-mediatica) delle gastronomie tradizionali ed etnico-regionali a scapito di quelle seriali, industriali, macdonaldizzate.
Alla luce di tali presupposti, le sagre si configurano come realtà ibride e multiformi situate a cavallo tra l’istituto della festa popolare tradizionale (in specie le ricorrenze patronali) e il fenomeno della mini-imprenditorialità a carattere “dilettantesco” e - in prevalenza - non lucrativo. Realtà che, nella riproposizione di scenari e atmosfere tipiche della “civiltà” contadina, perseguono essenzialmente (ma non solo) l’accaparramento dei flussi turistico-vacanzieri specie di provenienza extraterritoriale ed urbana. Obiettivo, questo, il cui raggiungimento viene spesso ricercato mediante un business che non sempre tiene conto della coerenza con le tradizioni gastronomiche autoctone: come dimostrano le diffuse sagre della birra, le generiche sagre della bruschetta o le numerose degustazioni di prodotti agroalimentari “fuori-stagione” e “fuori-territorio” che attualmente vengono allestite in differenti luoghi della regione.
Sagre e territorio a confronto: alcuni prospetti statistico-fisionomici.
La casistica delle sagre laziali prospetta un ampio ventaglio di offerta alimentare che riflette solo in parte le diversità produttive degli ambienti fisici e le tradizioni gastronomiche del passato storico. Quest’ultimo, contrassegnato da una fondamentale semplicità di risorse e da un’altrettanta semplicità di ricette adottate nel prepararle, si rivela segnato da una profonda “crisi della memoria” cronologicamente situabile a cavallo tra gli anni ’60-’70 dello scorso secolo:
da quel momento, infatti, i piatti che, per lunghissimo tempo, avevano costituito l’alimentazione base di gran parte della popolazione, scompaiono progressivamente dalla cucina quotidiana, fino ad essere, nella maggior parte dei casi, relegati ad ambiti o ricorrenze particolari […] all’interno di cui confluisca ancora questa cucina, che viene sentita come retaggio e patrimonio del passato , della quale si conserva il ricordo ma che già da tempo ha smesso di far parte dell’alimentazione quotidiana. Non va inoltre sottovalutato il fatto che, a partire appunto dagli anni ’60, il numero delle donne lavoratrici sia progressivamente aumentato, fino a costituire un importante cambiamento nelle abitudini familiari e nell’organizzazione della società
A determinare siffatta crisi della memoria collettiva, che secondo Corrado Barberis «non fu soltanto un cambiamento di mestiere ma un ripudio complessivo del passato», hanno agito fattori concomitanti quali:
l’abbandono di massa delle campagne e dei piccoli centri da parte delle nuove generazioni a vantaggio delle grandi città, dove le tradizioni tendono a scomparire più rapidamente, o lo sviluppo e la diffusione dei cibi surgelati, che hanno fortemente modificato le abitudini alimentari, e garantito la disponibilità dei prodotti indipendentemente dalle stagioni e dai territori di produzione.
E sebbene diverse sagre cerchino oggi di contrapporre un deciso argine ai fenomeni di deculturazione alimentare, l’avvenuta modificazione delle abitudini nutrizionali, l’incidenza pervasiva dell’impresa turistica e la globalizzazione dei gusti e dei consumi sembra trovare in molte di esse dei riflessi del tutto significativi.
Nel Lazio, le sagre gastronomiche corrispondono ad una tipologia di eventi difficilmente inventariabili nell’ambito di una classificazione unitaria. Ciò dipende dal fatto che, aldilà di una fisionomia comune che le identifica, costituiscono una realtà caleidoscopica dai tratti dinamici ed eterogenei. Così, mentre alcune chiamano in causa un coordinamento di tipo amministrativo-locale, altre manifestano contrassegni spontanei e popolari. Mentre alcune esigono significativi investimenti economico-finanziari e complessi apparati logistici che ne supportino l’allestimento, altre implicano impianti organizzativi di semplice attuazione alla cui cura attendono comitati appositi di cittadini volenterosi. Mentre alcune trovano svolgimento nel corso delle tradizionali feste patronali, arricchendone il cartellone delle manifestazioni ludico-evasive, altre (la maggioranza) costituiscono eventi “laici” dal carattere concorrenziale-sostitutivo delle feste stesse. Mentre alcune rinviano ad una origine più che decennale altre manifestano una genesi del tutto recente. Mentre alcune perseguono la promozione di un prodotto alimentare o di una ricetta culinaria di carattere tipicamente locale, altre si limitano a proporre l’offerta commerciale di generi gastronomici di più ampio consumo. Inoltre, mentre alcune esprimono un evidente segno di continuità temporale e di fissità calendariale, altre vengono allestite in maniera saltuaria e non necessariamente cadenzata.
Pressochè tutte, invece, aldilà delle singole variabili rilevate, sono accomunate dalla regola di far corrispondere all’offerta di cibo il pagamento di una somma più o meno consistente di denaro da destinarsi ad impieghi di carattere diversificato. Impieghi che possono riguardare sia l’autofinanziamento delle attività statutarie delle associazioni che le allestiscono, sia la realizzazione di opere di pubblica utilità (rifacimento dell’arredo urbano, allestimento di parchi-gioco per bambini, restauro di chiese e palazzi) sia la partecipazione a campagne di raccolta fondi per attività sociali e umanitarie.
Complessivamente nello spazio dell’intera regione risultano in esercizio ben 650 sagre, corrispondenti ad una media di 1,6 eventi per ogni comune. È evidente che si tratta di un valore numerico del tutto teorico che non tiene conto delle differenti situazioni attestate sul territorio; il riscontro operato sul terreno, infatti, ha permesso di documentare casi differenziati di località che organizzano fino cinque o più sagre l’anno e altri che ne organizzano una sola o nessuna.
In generale, l’offerta gastronomica vede il primato assoluto delle castagne: delle 650 sagre segnalate, infatti, ben 41 sono riservate al consumo di questo diffuso frutto autunnale. La ragione di un così elevato valore è da rapportarsi all’ampia estensione boschiva (il coefficiente di boscosità è pari al 27% della superficie totale) che ricopre una parte significativa del territorio collinare e di media-montagna della regione, specie quello situato in corrispondenza dei Monti Cimini, degli Affilani, del Cicolano, della zona tra S. Vito Romano e Bellegra e dei Castelli Romani. Lo scorporamento dei dati permette di assegnare 21 sagre alla provincia di Roma, 9 a quella di Rieti, 5 a quella di Viterbo, 4 a quella di Frosinone e 3 a quella di Latina. Permette inoltre di attribuire lo svolgimento di 21 eventi nel mese di ottobre, 18 in novembre, 2 in dicembre e 1 in gennaio.
All’offerta di castagne fa immediatamente seguito quella della polenta, con 32 casi complessivi rilevati. Si tratta di un piatto tipico soprattutto del periodo ottobre-marzo, con punte massime nei mesi di dicembre e di gennaio (sebbene non manchino due casi in agosto). Condita con aggiunta di ragù di pecora, funghi porcini, spuntature di maiale e salsicce, la polenta è presente in 13 sagre nella provincia di Frosinone, 11 in quella di Roma, 6 in quella di Rieti e 1 in quelle di Latina e di Viterbo.
Alla polenta, fanno immediatamente seguito le bruschette, di cui sono state evidenziate nel totale 31 sagre. Questo alimento a base di pane abbrustolito, olio e aglio strofinato, viene proposto sia nella sua forma più semplice, sia insaporito con tartufo, pomodorini, verdure, legumi e altri generi di condimenti che tuttavia si discostano da una originaria tradizione contadina. Di sagre della bruschetta se ne contano 13 nella provincia di Roma, 7 in quella di Rieti, 5 in quella di Frosinone e 3 nelle province di Viterbo e Latina. A ruota seguono tutti gli altri generi alimentari e culinari, disposti in base ad un ordine decrescente (vedi Tab.1) che vede al fondo della graduatoria l’offerta di piatti tradizionali di matrice strettamente locale: gli abbuoti a Viticuso (FR), il ciavarrotto a Formia (LT), l’acquacotta a San Martino al Cimino (VT), i bucatini all’amatriciana ad Amatrice (RI), la sbroscia a Marta (VT), le sagne di farro con l’aglione ad Orvinio (RI), la zuppa di fagiolo cioncone a Vivaro (RM).
Ragionando in termini di ripartizioni amministrative (vedi Tab.2), il 31% delle sagre trovano attuazione nella provincia di Roma, il 26% in quella di Frosinone, il 20% in quella di Rieti, il 13% in quella di Viterbo, mentre solo il 10% vengono allestite nella provincia di Latina. Tale disparità di valori, se da una parte è da porsi in relazione al variabile numero dei centri che ricadono nel territorio di ogni singola provincia, dall’altra è da riferirsi a precise dinamiche di natura geografica e socio-economica.
Se si tiene invece conto della calendarizzazione delle sagre in rapporto al ciclo dell’anno emerge un evidente divario distributivo che gioca a svantaggio soprattutto dei periodi invernali e primaverili (vedi Tab.3). Dall’analisi dei dati acquisiti risulta come il I° trimestre dell’anno prevede lo svolgimento di 69 sagre, con punta massima di 28 nel mese di gennaio; il II° trimestre ne prevede 91, con valore massimo di 40 nel mese di maggio; il III° trimestre ne prevede complessivamente 370, con un vertice di 290 in agosto; il IV° trimestre, infine, implica lo svolgimento di 85 eventi, di cui 64 nel solo mese di ottobre. Dicembre, febbraio, marzo e aprile risultano invece i mesi che fanno registrare il minor numero di eventi: rispettivamente 24, 17, 12 e 21 .
Simile andamento trova giustificazione in livelli di spiegazione che tengono conto delle condizioni climatiche, delle disponibilità stagionali di molti generi agro-alimentari, nonché dell’andamento dei cicli lavorativi (soprattutto urbani).
In particolare, la notevole flessione di sagre riscontrata nel periodo invernale, oltre a giustificarsi con le avversità metereologiche che incidono notevolmente negli spostamenti sul territorio, e oltre a motivarsi (parzialmente) con la scarsità di primizie, si spiega soprattutto nella particolare relazione che tale periodo intrattiene con il calendario festivo liturgico. Trattandosi infatti dei mesi interessati dalle ricorrenze del Natale, del Carnevale, della Pasqua, i tradizionali eccessi alimentari che di norma li caratterizzano fanno sì che si presti un minore interesse verso ulteriori proposte rinvianti al consumo di cibo .
Al contrario, la forte concentrazione di sagre nel periodo estivo, oltre a spiegarsi con ragioni di segno diametralmente opposto alle precedenti, si collega in maniera determinante alla maggiore flessibilità dei ritmi lavorativi e al diffondersi dei fenomeni vacanzieri. Questi agiscono concretamente sia nell’incoraggiare le gite fuori-porta, sia nell’attivare gli spostamenti turistici nelle aree extra-urbane, sia nel favorire il rientro degli immigrati nei propri paesi di origine: elevando esponenzialmente il numero dei residenti che vi alloggiano e stimolando le molteplici cerimonialtà di accoglienza.
Sempre legata alla sfera dei ritmi lavorativi, e alla conseguente maggiore/minore disponibilità di tempo libero, è la regola che “ammassa” lo svolgimento delle sagre negli spazi dei fine-settimana: soprattutto di sabato e di domenica, raramente di venerdì. Si tratta di una prassi che solo in corrispondenza del periodo luglio-agosto sembra conoscere significative attenuazioni, posta l’esigenza degli organizzatori di evitare penalizzanti sovrapposizioni tra eventi analoghi allestiti in paesi geograficamente limitrofi.
Dal passato all’oggi: casi esemplificativi di sagre laziali
La sagre, nella loro accezione di manifestazioni popolari legate al consumo collettivo (e a pagamento) di cibi e bevande, costituiscono dei fenomeni di recente affermazione nel panorama geografico del Lazio rurale e, più in generale di gran parte del territorio nazionale. Fenomeni che, se nella migliore delle ipotesi rinviano le radici al secolo di storia, nella prevalenza dei casi situano le proprie origini negli anni del “miracolo italiano”. Tuttavia, è soprattutto nell’ultimo trentennio che si è assistito ad una loro più incisiva proliferazione sotto la spinta congiunta dei vari impulsi sociali, culturali ed economici riferiti in inizio di esposizione.
Tra le centinaia di eventi gastronomici attualmente presenti nelle piazze delle cinque province, la sagra dell’uva di Marino si segnala certamente come una tra le più longeve e fortemente radicate nell’immaginario collettivo. Frequentata ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutta la regione, e dalle aree immediatamente adiacenti, questa manifestazione situa la sua nascita nell’epoca del Ventennio fascista e rivela una strettissima aderenza con gli assetti economico-produttivi del territorio, vocazionalmente designato alla coltivazione di uva da vino. Al suo allestimento concorrono diversi soggetti pubblici e privati che ne hanno assunto la gestione diretta, contraddicendo il modello organizzativo di impronta popolare che altrove rappresenta la matrice distintiva di questa tipologia di fenomeni. Del resto non potrebbe essere altrimenti, se si considera la mole delle risorse logistiche e finanziarie messe in campo per gestire la massiccia affluenza di pubblico, nonché il notevole investimento in immagine che comune e cittadinanza si attendono di ricavare dall’esito positivo della festa.
La sagra marinese, oltre a connotarsi come una delle più antiche del Lazio, si segnala anche per la sua netta apertura al business turistico che fin dall’inizio ne ha improntato la nascita. Istituita il 4 ottobre 1925 da Ercole Pellini in concomitanza delle celebrazioni patronali in onore della Madonna del SS.mo Rosario, il suo scopo originario è stato essenzialmente quello di promuovere «l’immagine di Marino e dei suoi prodotti vitivinicoli [...] tenendo conto dei servizi anche culturali che la città poteva offrire nel suo insieme [al] flusso di gitanti domenicali della capitale». Al riguardo, il modello a cui il poeta romano di origini marinesi si è voluto direttamente ispirare sono state le “Feste Castromenie”, precedenti manifestazioni popolari concepite “a tavolino” con l’obiettivo «di richiamare turisti da Roma e dintorni al fine di favorire il commercio e la vendita del vino». Tali feste, caratterizzate da sontuosi eventi culturali e di spettacolo, furono allestite nel 1904 per recuperare al crollo dell’economia locale dovuto ad una disastrosa grandinata che aveva distrutto tutto il raccolto gettando nel lastrico l’intera comunità.
Con gli stessi obiettivi di dare impulso turistico al territorio e di sostenere la produzione vitivinicola locale, a partire dal 1973 è stata istituita a Piglio (FR) la sagra dell’uva cesanese. Volta a pubblicizzare le qualità di uno dei vitigni autoctoni più importanti ed apprezzati della regione, la manifestazione ha luogo nel mese di ottobre e si svolge nell’arco di un’intera settimana. Per l’occasione i vari rioni dell’antico borgo stanziato sulle propaggini dei Monti Ernici vengono addobbati con coreografie alludenti alla tramontata “civiltà” contadina e vengono animati dalla presenza di alcuni gruppi canori che si esibiscono lungo le strade affollate di turisti. Inoltre, sempre al fine di ricreare un’atmosfera di vita tradizionale, i proprietari delle cantine invitano gli ospiti a “tracannare” il vino direttamente dalle tipiche “cupelle”, dando così piena soddisfazione a quella ricorrente ansia di folcloristico/pittoresco che una parte significativa di persone desidera attendersi da questo genere di eventi.
La volontà di rilanciare l’immagine di una località un tempo rinomata per il suo turismo balneare, e l’intento di promuovere la tipicità di un prodotto alimentare direttamente connesso all’agricoltura locale, ha portato la città di Ladispoli ad istituire nel 1950 la sagra del carciofo romanesco. Sorta in pieno periodo di boom economico, questa manifestazione si segnala attualmente come uno dei più rinomati appuntamenti fieristico-gastronomici dell’intera regione, nonchè come un valido veicolo pubblicitario con cui la città tirrenica intende dare impulso al proprio sistema produttivo locale: sia agricolo-commerciale che vacanziero. Infatti fin dall’esordio, si legge in un opuscolo di storia locale, «la manifestazione aprì ai cittadini ladispolani le porte dei mercati del nord come Firenze, Padova, Bologna e Verona […] e ebbe anche una importante funzione economica: erano molte infatti le famiglie romane che, avendo una casa, ne anticipavano l’apertura mentre altre venivano in quell’occasione affittando un appartamento o una camera». Capace nelle ultime edizioni di richiamare fino a 300.000 presenze da tutta Italia, la sagra si svolge ogni anno nel mese di aprile e coinvolge numerosi produttori agricoli che vendono in piazza i loro carciofi, crudi e cucinati. La sua preparazione è gestita in maniera verticistica dall’Amministrazione comunale e dalla Pro-Loco cittadina; inoltre, a causa degli importanti sviluppi fatti recentemente registrare dall’evento, lo stesso Ente Regione è entrato in qualità di suo sponsor ufficiale riconoscendogli lo statuto di Fiera regionale.
Di matrice organizzativa più prettamente popolare, ma sempre legata alla valorizzazione commerciale di un prodotto dell’agricoltura locale, è invece la sagra della cicerchia che si svolge a Campodimele, in provincia di Latina. Istituita per la prima volta nel 1981, la manifestazione ha luogo nel mese di luglio e consiste in un rito di piazza nel corso del quale viene distribuito il raro legume, un tempo assai presente nella cucina contadina povera. Il piatto, preparato da un comitato di circa 15 persone poste alle direttive della Pro-Loco, viene servito in zuppa con aggiunta di aglio e pomodoro e viene messo in vendita ad un prezzo convenuto che garantisce anche un bicchiere di vino. Il ricavato, recuperate le spese di gestione, viene reso ogni anno disponibile per finanziare attività di beneficenza o per realizzare opere di pubblica utilità. Gli stessi organizzatori, oltre a promuovere con vigore l’appuntamento gastronomico che richiama alcune migliaia di turisti dai principali centri del circondario e dalla stessa capitale, si sono recentemente impegnati nel fare opera di persuasione presso i coltivatori della zona al fine di incrementare la produzione del legume, attivando con successo il complesso iter legislativo necessario all’ottenimento di un marchio di qualità protetta. Marchio di qualità che, in provincia di Rieti, vede interessato anche un altro importante prodotto dell’agricoltura laziale: il marrone antrodocano.
Alla promozione di questo ricercato frutto si è voluto dedicare una specifica sagra che si tiene nel comune di Antrodoco (RI), alle falde del Monte Terminillo. Come molti altri eventi dello stesso segno che hanno luogo in ottobre nei diversi centri del Lazio montano, la sagra antrodocana si svolge in un clima di intensa spettacolarizzazione volto a richiamare l’attenzione dei turisti che percorrono le strade dei weekend autunnali. Nella circostanza, il comitato organizzatore provvede a distribuire gratuitamente un piccolo cartoccio di castagne che i partecipanti consumano in loco, unitamente all’acquisto di porzioni ulteriori di prodotto messe in vendita dai coltivatori locali alloggiati in appositi stand.
Sempre ad Antrodoco, inoltre, nei mesi di luglio-agosto hanno luogo altri due importanti eventi volti a valorizzare un prodotto gastronomico e una ricetta culinaria di schietta matrice autoctona: la sagra del pecorino e la sagra degli stracci antrodocani. Giunte quest’anno alla quarantaseiesima edizione, entrambe richiamano diverse migliaia di turisti dal Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria; inoltre, accanto alle sagre della polenta, della birra e degli spaghetti alla carbonara contribuiscono a rendere l’offerta gastronomica locale tra le più ricche e diversificate dell’intera regione.
Sulla base di questi limitati esempi, ritenere che le sagre costituiscano un fenomeno commerciale volto fondamentalmente a perseguire il marketing di un territorio o la promozione di prodotto alimentare locale rappresenta tuttavia un evidente errore di prospettiva. Più che un errore di prospettiva, un malinteso fondato su una parzialità di lettura e di analisi. Se si tiene debitamente conto delle differenti tipologie di sagre presenti in tutto il Lazio (vedi Tab.3) è possibile infatti constatare come accanto a situazioni come quelle sopra menzionate ve ne sono numerose altre che manifestano un’assoluta mancanza di referenzialità sia con gli aspetti produttivi del territorio sia con la volontà di ri-valorizzare le tradizioni gastronomiche ad esso relative.
Queste categorie di sagre, tipiche soprattutto delle aree carenti di risorse agro-alimentari autoctone e povere di ricettari culinari tradizionali - ma tipiche anche di molti borghi satelliti di città di medio-grande dimensione - sono spesso concepite con lo scopo di conferire un livello di maggiore visibilità a luoghi (altrimenti) sprovvisti di significative attrattive di tipo paesaggistico, storico-culturale, artistico-architettonico. In relazione a siffatto genere di manifestazioni, gli organizzatori sembrano non preoccuparsi affatto di offrire agli avventori prodotti gastronomici avulsi con le stagioni in corso, o con le caratteristiche ambientali delle zone di svolgimento: e così allestiscono degustazioni di vino nel mese di giugno, della salsiccia e della polenta in quelli di luglio-agosto, del merluzzo in località di montagna, o del porcino e della castagna in zone prive di idonee aree boschive.
In alcune documentate situazioni, le sagre sembrano invece rispondere al prevalente obiettivo di perseguire un business economico legato alla vendita di prodotti di cui il mercato stagionale propone un’alta domanda. È il caso delle estivissime sagre della birra e del cocomero, delle autunnali e recenti sagre del vino novello, delle invernali sagre della polenta, o delle tardo-primaverili sagre delle fave e delle ciliegie. In simili casi, non avendo le Pro-Loco e le amministrazioni comunali interessi diretti a sostenere l’iniziativa, i compiti organizzativi sono assunti in prima persona da gruppi associativi, o da comitati spontanei di cittadini, attratti dalla possibilità di realizzare agevoli ricavi da destinarsi ad attività di tipo diversificato (in genere di beneficio collettivo, più che di lucro privato).
Sagre e feste a confronto: alcune ipotesi conclusive
La moderna ermeneutica antropologica concepisce le sagre gastronomiche come un fenomeno di tradizione inventata; rilevando, nella maggior parte di esse, la mancanza di riscontrabili agganci con preesistenti tradizioni da cui farne derivare l’origine storica.
È vero. Il mondo contadino/pastorale ha storicamente conosciuto molteplici occasioni in rapporto alle quali la distribuzione collettiva di cibo ha assunto un ruolo di primaria importanza. Tuttavia è altrettanto vero che tali situazioni hanno quasi sempre costituito parte integrante di una dimensione cerimoniale strettamente connessa ad eventi di natura religiosa. Tra questi, quelli collegati al calendario liturgico e, soprattutto, alle feste patronali, hanno rappresentato l’ambito più appropriato in cui situare momenti di condivisione alimentare di natura compensatoria ( negare l’indigenza cronica), apotropaica (scongiurare i rischi per il raccolto), propiziatoria (favorire l’abbondanza di risorse alimentari).
Oggi, in un contesto storico-antropologico in cui viene fatto un ampio uso strumentale della cultura popolare, le sagre gastronomiche rappresentano sì un fenomeno di invenzione della tradizione, spesso pensato per creare immagini utili all'industria turistica; tuttavia, viste in base ad una differente angolazione prospettica, costituiscono una realtà dagli attributi assai più complessi e articolati. Costituiscono, cioè, una categoria creativa e utilitaristica di micro-imprenditorialità che, scaturendo dal basso e cavalcando il successo della domanda gastronomica di “genuina fattura”, sembra voler perseguire un triplice, ma non certamente esclusivo, obiettivo:
promuovere in forma auto-vantaggiosa le risorse produttive presenti nelle aree rurali e montane del territorio regionale, spesso compresse o de-vitalizzate dal persistente sottosviluppo che caratterizza i centri più distanti dai principali distretti industriali, commerciali e finanziari;
inserirsi all’interno di circuiti vacanzieri che, per quanto limitati ad un turismo di tipo “mordi e fuggi” e per quanto circoscritto agli spazi del weekend o del periodo estivo, sono tuttavia ritenuti in grado di attivare un indotto vantaggioso per la (ri)valorizzazione culturale ed economica dei centri stessi;
plasmare o ricostruire un’identità di gruppo, disgregata dallo spopolamento degli ambienti rurali, da negoziare nella dialettica locale-globale; dialettica al cui interno spiriti campanilistici, attaccamento alle radici e ripristino delle tradizioni giocano un ruolo primario e nient’affatto trascurabile.
FESTA PATRONALE |
SAGRA GASTRONOMICA |
Collocazione in una dimensione religiosa dei suoi significati e dei comportamenti collettivi |
Dimensione integralmente laica della sua rappresentazione. Raramente la sagra trova spazio in un contesto celebrativo di tipo festivo-patronale |
Destinazione sociale introflessa: la comunità si autorappresenta e celebra se stessa. |
Destinazione sociale estroflessa: la comunità si apre all’esterno per ricavare profitto e visibilità |
Eccesso alimentare come una delle componenti significative finalizzate alla compensazione e alla propizione di abbondanza |
Consumo alimentare come principale componente significativa atta a perseguire finalità direttamente remunerative |
Sospensione delle funzioni economiche e produttive |
Perseguimento di utilità economica |
Consumo rituale di un menù alimentare diversificato nel quadro di una dimensione domestica e familiare |
Consumo voluttuario di un prodotto alimentare esclusivo effettuato in ambito pubblico e collettivo |
Relazione cronologica con i cicli stagionali e il calendario liturgico |
Relazione funzionale con i cicli stagionali e il tempo vacanziero |
Rigidità del protocollo cerimoniale |
Carenza di prassi rituali di svolgimento |
Questua collettiva e fruizione gratuita dell’evento pubblico |
Impegno economico da parte di uno o più soggetti comunitari e fruizione a pagamento dell’evento |
Per tali diretti fini, ad organizzare sagre popolari non attendono grandi multinazionali del cibo o importanti enti pubblici, il cui impegno promozionale in campo alimentare consiste nell’allestire fiere o kermesse di maggiore risonanza mass-mediatica; nè sono professionisti della gastronomia e della ristorazione. A proporre e organizzare sagre sono fondamentalmente comitati spontanei di cittadini raggruppati in circoli culturali e ricreativi, associazioni sportive e di volontariato, centri sociali, parrocchie, confraternite, misericordie, pro-loco.
Alla luce di simili considerazioni appare del tutto riduttivo risolvere il discorso sulle sagre bollandole in termini di eventi costruiti su di una falsa memoria ad uso e consumo dell’industria turistica di massa, come spesso accade di cogliere nelle parole di alcuni specialisti delle materie demo-antropologiche. Certo, nessuno dubiterà mai che esse siano un’invenzione recente delle mode neo-folcloriche e del marketing territoriale; così come nessuno crederà mai che l’autenticità dell’offerta gastronomica sia ovunque e comunque garantita. Ciò, tuttavia, non costituisce ragione sufficiente per destituire il senso dei loro valori funzionali o per ritenerle realtà prive di una matrice identitaria popolare.
Del resto è un dato ormai acquisito che la sola profondità storica non può ritenersi come il parametro sufficiente per decretare l’autenticità di un costume o di una tradizione; così come è altrettanto noto che non tutto ciò che proviene dal passato sia da ritenersi portatore di valori folclorici tradizionali di per sé autentici. Cos’è allora che permette di considerare le sagre del Lazio contemporaneo, soprattutto rurale e periferico, come l’espressione di una cultura popolare propriamente intesa? Le parole di Alberto Cirese ne offrono un attendibile chiarimento:
la popolarità di un fenomeno culturale non dipende dall’origine e dalla forma […] dipende invece dal fatto che quel particolare fenomeno è presente (esclusivamente o almeno in modo prevalente e caratterizzante) in un certo ambito sociale, e non è presente (o è presente in modo non caratterizzante) in altri ambiti sociali che coesistono con i primi. In altre parole […] ciò che in genere fa la «popolarità» di un fatto culturale è la relazione storica di differenza o di contrasto rispetto ad altri fatti culturali coesistenti e compresenti all’interno di uno stesso organismo sociale.
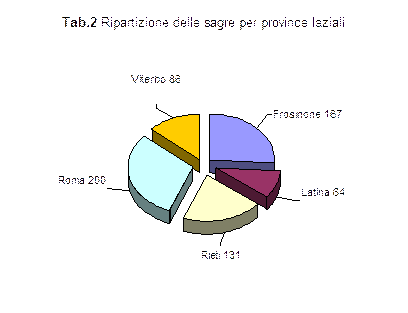
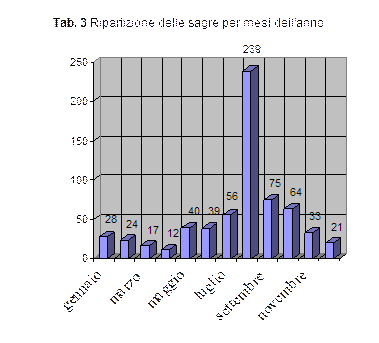
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
2004 Barberis C. (ed.), Identità e tradizione gastronomica del Lazio, «Quaderni di Informazione Socioeconomica», n. 10.
2003 Castello A., Le sagre nel Lazio, Roma, ARSIAL.
2002 Zanini De Vita O., il cibo e il suo mondo nella campagna romana, Roma, Alexandra Editrice.
2002 Dei F., Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi.
2002 Zongoli M. V. (ed.), Le vie di Bacco nel Lazio. La via dei Castelli Romani, Roma, Gangemi.
2001 Clemente P., Mugnaini F., Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci.
2000 Russo N., L’ambiente rurale laziale, Roma, Grafica Rispoli Editrice.
2000 Carbone A., Dono G., Gioia M., Indagine sui prodotti agricoli tipici della Regione Lazio,«Quaderni di Informazione Socioeconomica», n.3.
1998 Jannattoni L., La cucina romana e del Lazio, Roma, Newton Compton.
1986 Cirese A. M., Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo.
Saggio tratto dal volume di L. Barozzi (a cura di), Storia del Lazio rurale. Il Novecento, Roma. Arsial, 2005, pp. 306-321
Per il DELI (Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1979, 5 voll.), il termine sagra deriva da sagro, var. di sacro, (“festa sacra”). Le prime attestazioni note di sacra risalgono al XIV secolo, ad es. al 1342, col significato di “festa nell’anniversario della consacrazione di una chiesa”. Il significato di “festa popolare con fiera e mercato” compare per la prima volta nel Boccaccio (1353), associato ad una voce ancora di diffusione chiaramente regionale (veneto-lombarda). Il recente slittamento semantico verso il significato di “festa a carattere unicamente laico e ludico, con abbondanti libagioni” potrebbe essere stato facilitato anche dal D’Annunzio, che usò sagra come sinonimo di “commemorazione civile” (ad es. La Sagra dei Mille, maggio 1915). L’uso attuale della parola, dunque, sembra porsi esattamente all’incrocio tra il termine boccaccesco e quello dannunziano.
Questo lavoro è l’esito parziale di un work in progress condotto da chi scrive nel territorio laziale nel biennio 2003-2004. I dati statistico-numerici riportati, pur nel rigore metodologico del loro reperimento e della loro trattazione, hanno valore indicativo in riferimento allo specifico arco di tempo considerato. Ciò dipende dal fatto che le sagre, pur nel quadro di una sostanziale fissità di svolgimento, sono suscettibili anno per anno di possibili modificazioni nel numero, nella collocazione calendariale e nella tipologia gastronomica.
V. Piccinin, Le fonti e il territorio, in C. Barberis (ed.), Identità e tradizione gastronomica Nel Lazio¸ in «Quaderni di Informazione Socioeconomica», n. 10, 2004, p. 25.
Alla definizione di un numero così elevato di sagre sì è pervenuti mediante un procedimento di ricerca in cui, allo spoglio delle dispersive e non sempre attendibili fonti documentarie disponibili, è stata costantemente interpolata una ricognizione diretta sul terreno volta a verificarne e aggiornarne lo svolgimento.
Tale realtà sembra assegnare una posizione di sostanziale primato soprattutto ai paesi di piccole e medie dimensioni posti in aree extra-urbane rurali e montane; laddove sia le città capoluogo sia i centri maggiormente industrializzati fanno registrare valori di gran lunga inferiori alla media rilevata.
Alle sagre della bruschetta possono essere accostate, per evidente similarità di prodotto, quelle delle panzanelle, frese e panemollo, di cui sono rilevabili complessivamente 6 casi.
Gennaio, seppure con cifre relativamente basse, è il mese che esprime il maggior numero di sagre. La ragione è da ricercarsi nella ricorrenza calendariale della festa di S. Antonio Abate, in occasione della quale in molti paesi si provvede ad organizzare la tradizionale distribuzione collettiva di cibo rituale.
Non bisogna trascurare la circostanza che nel periodo compreso tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile cade generalmente la Quaresima, tradizionalmente connessa alla morigeratezza dagli eccessi alimentari. Essendo quello delle sagre un fenomeno fortemente legato alla dimensione conservativa delle campagne, ciò fa si che in molti casi ancora si rispettino i consuetudinari precetti religiosi.
Fonte : http://www.uniroma2.it/didattica/trad-pop-a/deposito/DOSSIER_FESTA._DISPENSE.doc
sito web: http://www.uniroma2.it/didattica/trad-pop-a/
Autore : Ernesto Di Renzo + altri autori indicati nel testo
Studio dei fenomeni festivi e rituali
Visita la nostra pagina principale
Studio dei fenomeni festivi e rituali
Termini d' uso e privacy