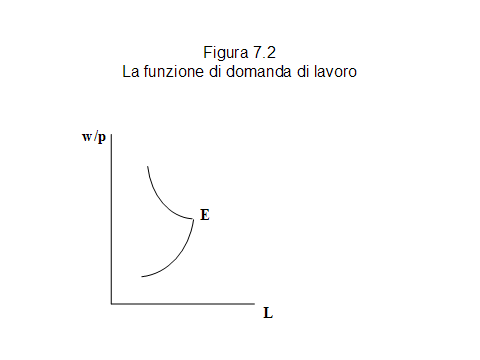Politica economica e del lavoro
Politica economica e del lavoro
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
Lia Fubini
Materiale didattico per il corso di “Politica economica e del lavoro”
Modulo 2
Anno accademico 2009/10
Capitolo 1
Il mercato del lavoro
Il lavoro è in primo luogo una fonte di reddito: per i più è necessario lavorare per vivere; ma il lavoro è anche fonte di realizzazione degli individui. Fino allo scoppio della crisi, cioè fino al 2008, la nostra società era sempre più ricca e continuava a crescere; tuttavia non era in grado di garantire un lavoro a tutti gli individui che avrebbero voluto lavorare.
A maggior ragione oggi, con la recessione in corso, i disoccupati sono in aumento e cresce il numero dei poveri. La nostra società non è dunque in grado di distribuire la ricchezza in modo tale da evitare che ci siano individui che vivono sotto la soglia della povertà. Oggi nella maggior parte dei paesi industrializzati la povertà non riguarda solo i disoccupati, ma anche un numero crescente di lavoratori precari e sottopagati.
Secondo le stime presentate nei Rapporti dell’International Labour Office (ILO), un’agenzia affiliata alle Nazioni Unite, a livello mondiale circa 212 milioni di persone erano disoccupate nel 2009 con un incremento di 34 milioni rispetto al 2007. Il numero dei giovani disoccupati nel mondo è aumentato di 10,2 milioni tra il 2007 e il 2009, l’incremento più elevato dal 1991.
L’ILO stima che la disoccupazione globale tenderà a rimanere elevata anche nel 2010. Nelle economie avanzate si prevede per il 2010 un incremento dei disoccupati di 3 milioni di persone, mentre nelle altre regioni i tassi si stabilizzeranno ai livelli attuali o diminuiranno solo lievemente.
Questo capitolo presenta un quadro delle condizioni del mercato del lavoro in Italia e un confronto con i paesi dell’Unione Europea.
La classificazione della popolazione in base al lavoro
La definizione applicata nelle moderne economie e dagli istituti di statistica definisce occupati solo coloro che tramite il lavoro percepiscono un reddito monetario e disoccupati coloro che vorrebbero lavorare per percepire un reddito e sono attivamente impegnati nella ricerca di occupazione ma non la trovano. Sono dunque esclusi dalla categoria “occupati” coloro che svolgono attività non remunerate, ad esempio il lavoro domestico o il volontariato. Parimenti sono esclusi dalla categoria dei disoccupati coloro che vorrebbero lavorare, ma non cercano attivamente un’occupazione.
Date le difficoltà di raccogliere dati nei paesi meno sviluppati e le differenze nei metodi di rilevazione nei diversi paesi, è necessaria una certa cautela quando si confrontano i dati delle diverse economie. Per quanto riguarda i paesi dell’Unione Europea l’uniformità dei sistemi di rilevazione consente confronti abbastanza precisi.
I principali dati relativi al mercato del lavoro in Italia vengono rilevati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) attraverso un’indagine campionaria svolta intervistando circa 175.000 persone in oltre 1200 comuni del territorio italiano.
Per cominciare, esaminiamo i principali aggregati che l’ISTAT prende in considerazione nelle sue rilevazioni sul mercato del lavoro. Le persone intervistate in età lavorativa (oltre i 15 anni) vengono suddivise dall’ISTAT in tre categorie:
a) Occupati. Il percorso seguito dall’ISTAT per la classificazione delle persone definite occupate è sinteticamente illustrato nella figura 1.
La categoria degli occupati comprende dunque le persone di 15 anni e più che nella settimana a cui si riferisce l’intervista:
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura,
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro anche non retribuito nella ditta familiare in cui collaborano abitualmente
- sono assenti dal lavoro (ad esempio per ferie o per malattia), secondo i criteri illustrati nella figura 1.
Figura 1
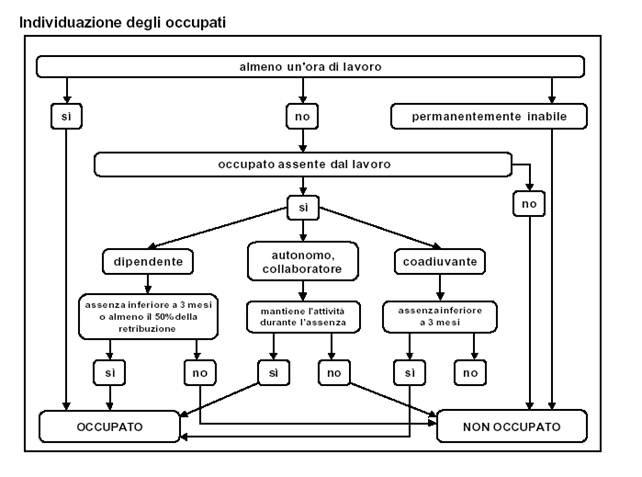
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica “La nuova rilevazione sulle forze di lavoro. Contenuti, metodologie organizzazione” Istat, giugno 2004
C’è però una categoria di persone difficile da classificare, si tratta di coloro che lavorano nel sommerso, i cosiddetti lavoratori in nero. A rigore dovrebbero considerarsi occupati, l’intervistatore dell’ISTAT garantisce l’anonimato all’intervistato, ma i lavoratori occupati in attività sommerse temono denunce e spesso preferiscono dichiararsi disoccupati o inattivi. A maggior ragione questo discorso vale per chi è impegnato in attività illegali o criminali.
b) Persone in cerca di occupazione. Il percorso seguito dall’ISTAT per la classificazione delle persone in cerca di occupazione è illustrato nella figura 2. Sono incluse in questa categoria le persone non occupate di età compresa fra i 15 e i 74 anni che:
- hanno effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista,
- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. Le persone in cerca di occupazione comprendono dunque i disoccupati, cioè coloro che hanno perduto il lavoro e lo cercano attivamente, nonché le persone alla ricerca della prima occupazione.
Figura 2
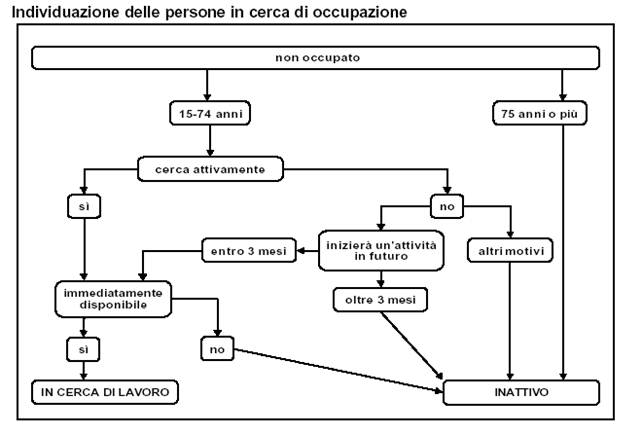
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica “La nuova rilevazione sulle forze di lavoro. Contenuti, metodologie organizzazione”, Istat, giugno 2004
La somma dei lavoratori occupati e delle persone in cerca di occupazione (disoccupati) costituisce le forze di lavoro, ovvero la popolazione attiva.
c) Inattivi. Questa categoria include coloro che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero le persone non classificate come occupate o in cerca di occupazione.
I principali indicatori che descrivono le condizioni del mercato del lavoro sono:
- Il tasso di attività, che è il rapporto fra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento.
- Il tasso di occupazione, che è il rapporto fra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.
Salvo diversa indicazione, il tasso di attività e il tasso di occupazione vengono calcolati facendo riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni).
- Il tasso di disoccupazione che è il rapporto fra persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.
- Il tasso di disoccupazione di lunga durata che è il rapporto fra persone in cerca di occupazione da dodici mesi e oltre e le forze di lavoro.
Un concetto a cui talora si fa riferimento è quello di unità di lavoro standard (ULA), che rappresenta la quantità di lavoro prestata in un anno da un lavoratore a tempo pieno, o la quantità equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è legato al numero di lavoratori occupati, ma al volume di lavoro impiegato.
(Per dati e tabelle sull’occupazione, disoccupazione, ecc. si veda sul sito la rilevazione dell’Istat.)
In Italia la forza lavoro, secondo i dati ISTAT, nel 2009 era pari a circa 25 milioni di persone, di cui circa 23 milioni di occupati e 2 milioni di persone in cerca di occupazione. Se teniamo conto che la popolazione residente in Italia è pari a circa 60 milioni, il 41,5% della popolazione residente italiana appartiene alla forza lavoro. La popolazione in età lavorativa (15-64 anni) era pari a circa 40 milioni. Dunque circa 15 milioni di persone, pur essendo in età lavorativa erano fuori della forza lavoro, cioè non erano né occupati, né attivamente in cerca di occupazione. La maggior parte sono studenti, casalinghe/i, pensionati o altre persone che non sono effettivamente disposte a lavorare (circa 12 milioni), ma circa 3 milioni sono in realtà disponibili a lavorare, ma non cercano attivamente occupazione. Molte di queste persone che, pur non cercando lavoro, sono disponibili a lavorare, possono essere definite “lavoratori scoraggiati”. Si tratta sia di lavoratori disoccupati che nei periodi di elevata disoccupazione, dopo aver tentato di trovare lavoro, abbandonano la ricerca, sia di quei potenziali lavoratori che rinunciano ad entrare nel mercato del lavoro a causa delle scarse probabilità di trovare occupazione. I "lavoratori scoraggiati" non sono inclusi dalle statistiche fra i disoccupati, ma fra i "non appartenenti alle forze di lavoro", tuttavia si tratta di persone pronte a cogliere nuove opportunità di occupazione, quando queste si presentano.
In effetti, quando diminuisce l’occupazione, diminuisce anche la forza lavoro e viceversa, perché molti disoccupati smettono di cercare lavoro se si convincono di non avere possibilità di trovarlo. Intorno alla metà degli anni novanta il calo dell’occupazione è stato accompagnato da un declino della forza lavoro. Negli ultimi anni prima dello scoppio della crisi in atto è aumentata l’occupazione e diminuito il numero dei disoccupati e parallelamente è aumentata la forza lavoro, perché, dato l’aumento delle opportunità lavorative, molte persone precedentemente “inattive” sono entrate nel mercato del lavoro.
Per questo motivo è importante considerare il tasso di occupazione, che ci dice qual è la percentuale di persone in età lavorativa che il sistema è in grado di assorbire. Un tasso di occupazione elevato è indice di un sistema che è in grado di utilizzare adeguatamente le risorse disponibili.
In Italia il tasso di occupazione (15-64 anni) è fra i più bassi dell’Unione Europea, nel 2009 era superiore solo a quello di Malta e Ungheria.
Si tenga conto che l’obiettivo fissato dall’agenda di Lisbona per il 2010 era di un tasso di occupazione pari al 70%. Ciò indica che in Italia il fattore produttivo “lavoro” è impiegato in misura nettamente inferiore alla maggior parte dei paesi europei e che perciò una risorsa importante non viene adeguatamente utilizzata e limita le possibilità di crescita del nostro paese. Il dato tuttavia cela anche una maggiore diffusione del lavoro sommerso, dato che, come abbiamo visto, i lavoratori in nero spesso dichiarano di essere disoccupati.
Un dato importante che viene rilevato dall'ISTAT è la percentuale di disoccupati di lunga durata sul totale della forza lavoro. In Italia quasi la metà dei disoccupati presenti sul mercato del lavoro sono disoccupati da un anno o più.
La dinamica dell’occupazione in Italia
Se guardiamo all’andamento dell’occupazione e del tasso di disoccupazione negli ultimi cinquant’anni in Italia come in altri paesi Europei, notiamo che, dopo una discreta performance negli anni cinquanta e sessanta, la situazione occupazionale ha cominciato a deteriorarsi verso la fine degli anni settanta, quando, con le politiche di aggiustamento condotte dalle economie occidentali per far fronte agli shock petroliferi, il tasso di disoccupazione ha cominciato ad aumentare e l’occupazione ha registrato una flessione nel tasso di crescita. L’economia italiana, che già negli anni ottanta aveva mostrato una scarsa capacità di creare nuovi posti di lavoro rispetto alle economie più avanzate, nei primi anni novanta è stata investita da una grave crisi occupazionale, caratterizzata non solo da un aumento dei disoccupati, ma anche da una sensibile diminuzione nel numero degli occupati. Nella seconda metà degli anni novanta sembra essersi verificata una svolta, nel 1996 riprende a crescere il numero degli occupati, aumentano il tasso di attività e di occupazione e dopo il 1998 si registra un calo nel numero dei disoccupati e comincia a calare il tasso di disoccupazione. Dalla fine del 2002 si evidenzia un indebolimento della tendenza espansiva dell’occupazione. L’aumento nel numero di occupati verificatosi nel periodo 2003-2005 è attribuibile all’emersione del lavoro nero prestato dagli immigrati per effetto della regolarizzazione dei cittadini stranieri e non a un effettivo aumento dei posti di lavoro disponibili.
Peraltro la dinamica espansiva dell’occupazione della seconda metà degli anni novanta, che ha seguito con un anno di ritardo la tendenza in atto nell’UE, è apparsa più debole che nella maggior parte degli altri paesi europei.
I mediocri risultati dell’Italia sul piano occupazionale rispetto alle altre economie avanzate dipendono in larga misura dal modesto aumento del PIL che, dagli anni ottanta, ha mostrato una crescita più contenuta rispetto alla media degli altri paesi industrializzati. Le politiche di compressione della domanda globale adottate negli anni novanta per rispettare i criteri di convergenza necessari per entrare nell’Unione Monetaria hanno imposto una brusca frenata alla nostra economia e, di riflesso, hanno avuto un impatto negativo sull’occupazione.
Ma un ruolo di rilievo è stato giocato anche, come vedremo nei prossimi paragrafi, dalle specializzazioni settoriali dell’Italia e dal dualismo nord-sud che caratterizza la nostra economia.
Con la crisi, come ovvio, la situazione occupazionale in Italia è nettamente peggiorata. Nel quarto trimestre del 2009 il numero di occupati risultava in calo dell’1,8% rispetto al corrispondente periodo del 2008 (-428.000 unità). Calano soprattutto l’occupazione autonoma, i dipendenti a termine, i collaboratori. Il tasso di occupazione ha registrato nell’ultimo anno un calo di 1,4 punti percentuali. Alla crescita della disoccupazione si accompagna un incremento degli inattivi dell’1,7% (+253.000 unità), in particolare di coloro che non cercano attivamente lavoro perché pensano di non trovarlo e di coloro che rimangono in attesa dei risultati di passate azioni di ricerca di lavoro.
La distribuzione settoriale dell’occupazione
Nel corso degli anni novanta, nell’UE come in Italia, si è verificata una forte diminuzione degli addetti nell’agricoltura, una sostanziale stabilità dell’occupazione nell’industria e un notevole incremento nel terziario. Attraverso le rilevazioni dell’ISTAT, scopriamo che quasi due terzi dei lavoratori sono occupati nei servizi, poco meno di un terzo lavora nell’industria e circa il 4% nell’agricoltura. Questa distribuzione settoriale, in cui domina la quota di lavoratori occupati nei servizi e l’agricoltura assorbe una quota minima degli occupati, non è una peculiarità italiana, ma contraddistingue tutti i sistemi produttivi avanzati ed è dovuta alla crescente terziarizzazione e finanziarizzazione dei sistemi economici moderni.
Nei primi anni 70 l’agricoltura assorbiva circa un quinto degli occupati; il peso del settore agricolo è poi progressivamente calato.
Lo sviluppo del terziario in Italia come negli altri paesi industrializzati ha rappresentato la principale componente nel processo di crescita dell’occupazione negli ultimi decenni; mentre nel 1970 il terziario assorbiva il 40% dell’occupazione, ormai circa due terzi degli occupati lavorano nel settore dei servizi. Tuttavia l’Italia segue il trend europeo con un certo ritardo, soprattutto mostra una dinamica e un’incidenza assai più contenute rispetto agli altri paesi europei in settori determinanti per la crescita dell’occupazione, quali i comparti dei servizi alle famiglie e alle imprese che nella UE hanno esercitato un ruolo trainante per l’occupazione.
Per quanto riguarda l’occupazione industriale è importante sottolineare che il nostro apparato produttivo presenta alcune specificità rispetto agli altri paesi europei: una specializzazione produttiva prevalentemente nei settori tradizionali e un elevato numero di piccole e micro imprese. Quasi metà dell’occupazione manifatturiera è concentrata nei settori tradizionali (alimentari, tessile, abbigliamento, cuoio e calzature), mentre il peso dei settori a più alto tasso di ricerca e sviluppo risulta inferiore alla maggior parte dei paesi europei. Questo tipo di specializzazione produttiva ha progressivamente provocato un indebolimento nella posizione dell’Italia sui mercati mondiali ed incide negativamente sulla crescita occupazionale essenzialmente per due ragioni. In primo luogo, la crescita della domanda nei settori tradizionali è stata negli ultimi anni relativamente contenuta. In secondo luogo i settori tradizionali sono i più esposti alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, che sono più competitivi grazie al basso costo del lavoro e alle normative più tolleranti su inquinamento, sicurezza, ecc. Questa situazione ha causato fra l’altro uno spostamento verso l’estero di attività che non risulta più conveniente mantenere in Italia.
Come si è detto, un’altra specificità del settore manifatturiero italiano è la prevalenza di unità produttive di piccola dimensione. La struttura dimensionale delle imprese in Italia è da molti considerata un indice di arretratezza del nostro sistema produttivo; infatti ne condiziona negativamente la competitività con ovvi risvolti sull’occupazione, che tende a crescere più debolmente che negli altri paesi industrializzati. Peraltro si è assistito a un continuo ridimensionamento delle grandi imprese che, a partire dai primi anni ottanta, continuano a registrare un vistoso calo dell’occupazione. Basti pensare che dal 1995 al 2006 l’occupazione dipendente nelle imprese industriali con oltre 500 addetti è scesa circa del 20%.
1.4 Divari territoriali
La situazione italiana si caratterizza per una netta segmentazione del mercato del lavoro, sia a livello territoriale che per tipologie di lavoratori.
Le statistiche sull’occupazione in Italia evidenziano le forti differenze nella distribuzione territoriale delle forze di lavoro, degli occupati e dei disoccupati. Esistono divari territoriali considerevoli in molti paesi, ma difficilmente accentuati come nel nostro.
Tutti gli indicatori relativi al mezzogiorno si presentano decisamente peggiori rispetto alla media europea.
Viceversa il Nord (con l'eccezione di alcune aree metropolitane, quali Torino e Genova, particolarmente toccate dal declino della grande impresa) presenta tassi di disoccupazione e tassi di occupazione in linea con la media europea.
La discreta performance occupazionale nelle regioni del centro-nord fino allo scoppio della crisi deriva dal fatto che in tali regioni il declino della grande impresa è stato accompagnato dallo sviluppo di imprese di dimensione media e piccola. Particolarmente importante sono stati la creazione di molte imprese nel nord-est e nel centro, lungo la direttrice adriatica, e lo sviluppo dei distretti industriali . Si noti tuttavia che già prima della crisi la crescita dell’occupazione nel nord-est sembrava essersi arrestata e si evidenziava una fase di ristagno nell’attività di molte piccole imprese. Con la recessione ovviamente la situazione si è notevolmente aggravata.
Senza dubbio la situazione del Mezzogiorno deriva dalla sua debolezza economica e istituzionale. Per quanto riguarda gli aspetti economici, il sistema produttivo meridionale è caratterizzato da una dotazione scarsa di infrastrutture, da un limitato contenuto innovativo degli investimenti, da una specializzazione produttiva in settori tradizionali. L’aspetto istituzionale gioca un ruolo rilevante: l’incapacità delle istituzioni di fornire servizi funzionali allo sviluppo locale ha incentivato la crescita della corruzione e dell’illegalità (compreso il lavoro nero), creando così un terreno ostile allo sviluppo di nuove attività che comportino un aumento dell’occupazione ufficiale. Non è questa la sede per approfondire i problemi strutturali dell’economia meridionale, che sono stati trattati da una vastissima letteratura. Basta dare uno sguardo ai dati per rendersi conto che l’Italia appare un paese letteralmente spaccato in due. In numerose regioni del Nord la disoccupazione risulta relativamente contenuta, anche se nettamente in crescita, almeno per quanto riguarda l’offerta di lavoro maschile. Ma la situazione nel mezzogiorno è senz’altro allarmante.
Il mercato del lavoro femminile
Il mercato del lavoro femminile in Italia presenta aspetti contraddittori. Un aspetto senza dubbio positivo si può riscontrare nel fatto che la presenza femminile sul mercato del lavoro ha registrato un andamento crescente, nonostante la crisi occupazionale che ha investito l'Italia nell'ultimo quarto di secolo. In particolare, negli ultimi anni, gli ampi differenziali di genere si sono progressivamente ridotti.
La crescita dell’offerta di lavoro femminile dipende da vari fattori: le trasformazioni socio-culturali che hanno comportato mutamenti nella struttura della famiglia e nel ruolo della donna nel contesto famigliare, la diffusione del lavoro part-time, l’incremento della domanda di forza lavoro nel settore dei servizi. Ma, nonostante la crescita della partecipazione femminile, le differenze di genere si mantengono ancora molte elevate e non è ancora stato colmato il divario esistente con gli altri paesi industrializzati, né in termini di tassi di disoccupazione, né in termini di tassi di occupazione. Il tasso di occupazione delle donne è fra i più bassi dell'UE, e presenta un divario di oltre 20 punti percentuali rispetto a Danimarca, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Paesi Bassi. L'Italia è stata superata anche dalla Spagna e dalla Grecia, che pure in passato presentava una situazione ancora più critica. Fra i paesi della UE solo Malta nel 2009 presenta un tasso di occupazione femminile inferiore a quello italiano.
Non è più possibile oggi spiegare le differenze di genere attraverso il minore investimento delle donne in istruzione e formazione, in quanto le donne in Italia hanno una formazione e una cultura mediamente più elevata rispetto agli uomini. Va tuttavia sottolineato che le donne tendono a privilegiare gli studi in campo umanistico e la formazione umanistica appare meno spendibile sul mercato del lavoro di quella scientifica.
Notiamo invece che, oltre ai puri elementi discriminatori, una serie di provvedimenti volti a favorire le donne, hanno finito con l'avere un impatto negativo sul mercato del lavoro femminile; si pensi ai congedi di maternità, che portano ad una discriminazione in favore degli uomini (anche se oggi esistono i congedi per paternità, la loro diffusione è ancora piuttosto limitata), o alle deduzioni fiscali per il coniuge a carico che scoraggiano la partecipazione femminile regolare al mercato del lavoro, incentivando caso mai il lavoro nero delle donne o ancora il pensionamento per le lavoratrici anticipato rispetto agli uomini. Tali misure dovrebbero essere comunque compensate da politiche in grado di controbilanciarne gli effetti.
Un altro motivo che spiega il basso tasso di attività femminile è ovviamente costituito dalle attività di cura a cui le donne sono tradizionalmente costrette a dedicare una parte del loro tempo. Sarebbe necessaria una politica di riequilibrio delle responsabilità familiari fra uomini e donne volta ad alleggerire le attività di cura attraverso la creazione di asili, dopo scuola, assistenza agli anziani, ecc. Si tratta di politiche che hanno dato ottimi risultati nei paesi scandinavi; in tali paesi si registrano, infatti, tassi di partecipazione alla forza lavoro molto elevati sia per le donne che per gli uomini, differenze minime fra generi sia per quanto riguarda il tasso di partecipazione, sia per quanto riguarda il tasso di disoccupazione e differenziali retributivi più contenuti della media europea. Tali politiche trovano tuttavia ostacoli di attuazione oggi nel nostro paese, che si muove in un'ottica di tagli alla spesa pubblica.
Uno studio sull'inserimento professionale dei giovani mostra inoltre la difficoltà di accesso delle donne ai lavori a tempo indeterminato; i maschi alla ricerca della prima occupazione risultano avere circa il 50% di probabilità più delle femmine di trovare un lavoro a tempo indeterminato. Viceversa un contributo significativo all'ampliamento della base occupazionale femminile è derivato dalle forme di lavoro atipico (part-time, lavori a tempo determinato) e dal lavoro autonomo. Resta però da verificare in quale misura l'avviamento al lavoro attraverso forme "atipiche" favorisce un inserimento stabile e in quale misura costituisce invece una forma di marginalizzazione delle donne nel mercato del lavoro.
Un altro problema relativo all’occupazione femminile è la cosiddetta “segregazione verticale” cioè la forma di discriminazione che impedisce alle donne di salire i gradini più alti della scala professionale, fino a raggiungere posizioni di vertice. Sia nel settore pubblico che nelle imprese private le donne raramente accedono ai livelli manageriali che a loro competerebbero per età, anzianità e qualifica. La situazione è decisamente migliore per le donne che decidono di intraprendere una carriera imprenditoriale, in cui il successo dipende dalla capacità e non dalla selezione improntata a una discriminazione di genere. Basti notare, a questo proposito, che alla fine degli anni novanta le donne erano circa il 5% dei dirigenti e il 21,2% degli imprenditori.
Il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.
Una peculiarità del nostro mercato del lavoro è rappresentata dall’elevata incidenza del lavoro indipendente sull’occupazione totale. Gli occupati dipendenti nel 2009 sono circa 17.282.000 e gli indipendenti 5.640.000 milioni. La quota dei lavoratori autonomi in Italia è decisamente più elevata rispetto alla media europea. Una possibile spiegazione di questo fenomeno può essere individuata nella struttura dimensionale delle imprese italiane, caratterizzata da un numero eccezionalmente elevato di piccole imprese. Infatti anche gli altri paesi europei a sviluppo tardivo, come Spagna, Portogallo e Grecia presentano una quota di lavoratori indipendenti superiore alla media UE. In questi paesi incide in larga misura anche il fatto che la quota di addetti in agricoltura è relativamente alta e che in agricoltura la percentuale dei lavoratori indipendenti è molto elevata. In Italia viceversa il peso dell’occupazione agricola è piuttosto contenuto. Peraltro nel nostro paese l’alta percentuale di lavoratori indipendenti è rilevabile in tutti i settori e non solo in quelli tradizionali, normalmente caratterizzati da una maggiore presenza di imprese artigiane.
Indubbiamente la presenza particolarmente elevata di piccole e micro imprese in Italia ha un ruolo determinante nella spiegazione della elevata quota di indipendenti, ma è necessario anche considerare che il dato italiano è viziato dalla presenza di un numero crescente di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto che, come vedremo nel prossimo paragrafo, formalmente sono considerati lavoratori indipendenti, ma che in molti casi mascherano forme di lavoro dipendente .
Il lavoro atipico
Negli ultimi anni si è verificata una accentuata tendenza alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro. Sono nate nuove forme contrattuali che hanno consentito un crescente utilizzo del lavoro a tempo determinato e diverse tipologie di orario. Il lavoro atipico comprende le forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato e dalle forme tradizionali di lavoro autonomo. Si tratta di una categoria residuale ed eterogenea che include varie tipologie contrattuali, quali i lavori a tempo determinato, il lavoro parasubordinato, che occupa una posizione intermedia fra l’occupazione alle dipendenze e il lavoro autonomo, il part-time, il telelavoro. Le varie forme di lavoro atipico presentano aspetti e problematiche differenti e soddisfano esigenze diverse di flessibilità.
Nel nostro paese esistono numerose forme di contratti a tempo determinato. La legge 196/1997 (il cosiddetto pacchetto Treu) ha introdotto e regolato alcune forme di contratti a tempo determinato, ad esempio il lavoro interinale. Con la legge 30/2003, altrimenti chiamata riforma Biagi, le forme contrattuali atipiche si sono moltiplicate. Sono peculiari dell’indirizzo del legislatore forme contrattuali quali il job on call (lavoro a chiamata) lo staff leasing (affitto di interi reparti di lavoratori da parte di agenzie interinali), il job sharing (lavoro ripartito).
I contratti a termine sono rapidamente cresciuti passando dal 6,8% dell’occupazione dipendente nel 1994 a circa il 10% a partire dal 2000. Nel 2005 i contratti a carattere temporaneo hanno interessato oltre due milioni di lavoratori dipendenti (quasi il 13%). Oltre la metà dei nuovi posti di lavoro creati dal 1994 al 2005 sono a lavori a termine. Con lo scoppio della crisi la quota di lavoratori dipendenti a termine è scesa a meno del 10%. I primi a subire l’effetto della crisi e ad essere estromessi dal mercato del lavoro sono stati infatti i lavoratori con contratti temporanei che alla scadenza non sono stati rinnovati.
Anche il part-time coinvolge un numero sempre più elevato di lavoratori e attualmente copre oltre il 15,1% dei dipendenti (oltre 2,6 milioni di lavoratori).
Al netto delle sovrapposizioni, oltre 3 milioni di lavoratori è coinvolta in forme di lavoro atipico.
Contemporaneamente è cresciuto il lavoro dei collaboratori coordinati e continuativi e dei collaboratori a progetto che, pur collocandosi formalmente come lavoro autonomo spesso nasconde situazioni di lavoro dipendente, senza però le garanzie normalmente offerte al lavoratore dipendente (ad esempio la retribuzione in caso di assenza per malattia). I collaboratori sono legati da un contratto con un’azienda senza esclusività (ma nella maggior parte dei casi il legame è con una sola azienda). Si può stimare che circa mezzo milione di collaboratori siano in realtà lavoratori subordinati “mascherati” da autonomi.
Il lavoro nero
L’attività sommersa permette di aggirare le norme che regolano l’attività di produzione e l’utilizzo del lavoro; dunque consente l’evasione fiscale e contributiva, l’inosservanza delle norme relative alla sicurezza, agli orari di lavoro e ai minimi salariali.
Le imprese che operano nel sommerso possono quindi abbassare i costi e mettono perciò in atto pratiche di concorrenza sleale rispetto alle imprese regolari. In Italia il fenomeno del sommerso è molto diffuso e in aumento. Le nuove forme di flessibilità non sono state in grado di contrastare lo sviluppo del lavoro sommerso, che ha continuato a crescere per tutti gli anni novanta. Questo perché il sommerso è generato non tanto dall’esigenza di comprimere i costi diretti del lavoro, che con le nuove forme di flessibilità risultano notevolmente ridotti, ma dal desiderio di evasione fiscale e contributiva, nonché dalla volontà di eludere tutta una serie di norme atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori. La crescita del lavoro irregolare fra i lavoratori dipendenti è probabilmente imputabile anche alla crescente presenza di stranieri nel nostro paese .
Naturalmente è difficile calcolare l’ampiezza del sommerso, per cui ci dobbiamo accontentare di valutazioni tutt’altro che precise. Secondo le stime effettuate dall’ISTAT nel 2009 le unità di lavoro irregolari erano circa 3 milioni e le posizioni di lavoro dipendente non regolare superavano i superavano i 4 milioni.
La percentuale di lavoratori irregolari è in crescita fra i lavoratori dipendenti e ha raggiunto nel 2000 il 18% dell’occupazione dipendente, mentre risulta stabile (intorno all’8,3%) fra gli indipendenti. Fra il 1992 e il 1998, mentre l’occupazione regolare scendeva di quasi il 5%, quella irregolare aumentava di oltre il 10%. Il tasso di irregolarità nel 2000 risultava particolarmente elevato nel settore agricolo (32,1%), ma anche il comparto delle costruzioni (16%) e dei servizi (commercio, riparazioni e trasporti 18,6%, intermediazione monetaria e finanziaria 13,8%, altri servizi 16,2%) registravano tassi di irregolarità piuttosto alti, mentre l’industria in senso stretto non sembra utilizzare in modo consistente il lavoro irregolare (5,7%). L’incidenza di irregolari sulle unità di lavoro complessive è concentrata soprattutto nelle regioni meridionali (22,6% nel Mezzogiorno, 15,2% nel Centro, 11% nel Nord).
A questo punto ci si potrebbe chiedere qual è il tasso di disoccupazione al netto dei lavoratori in nero. I disoccupati in Italia sono circa due milioni e le unità di lavoro irregolari sono oltre i tre milioni; se valutiamo che una larga percentuale dei lavoratori in nero tende a dichiararsi disoccupata, saremmo tentati di pensare che in Italia siamo in una situazione di piena occupazione. Tuttavia, in primo luogo è dubbio che si possa considerare davvero occupata una persona sottopagata e non tutelata. Inoltre è necessario considerare che solo una parte dei lavoratori in nero sono persone che si dichiarano disoccupate (poco più di 1/3 secondo uno studio del Censis del 1998). I lavoratori in nero vengono infatti anche reclutati fra occupati (per il secondo lavoro), pensionati, cassintegrati e lavoratori in mobilità, immigrati extra-comunitari senza permesso di soggiorno e altre persone che non si dichiarano in cerca di occupazione.
Per saperne di più
Segnaliamo qui alcuni siti internet utili per trovare dati e informazioni sul mercato del lavoro.
-Il mercato del lavoro nel mondo:
International Labour Office (ILO) www.ilo.org
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) www.unctad.org
Organizzazione internazionale di difesa di diritti umani contro la schiavitù www.antislavery.org
- Il mercato del lavoro nei paesi industrializzati:
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) www.oecd.org
-Il mercato del lavoro in Europa:
Europa - L’Unione Europea in linea (sito ufficiale dell’UE) http://europa.eu.int
European Employment Observatory www.etuc.org
- Il mercato del lavoro in Italia:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) www.istat.it
ISFOL www.isfol.it
Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) www.cnel.it/
Europa Lavoro (sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo in Italia) http://www.europalavoro.it/
Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) www.inail.it
Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS) www.inps.it
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL www.isfol.it
Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.minwelfare.it/default.htm
-Siti sindacali:
CGIL www.cgil.it
CISL www.cisl.it
UIL www.uil.it
Confederazione europea dei sindacati www.etuc.org
-Siti di quotidiani :
Il Sole-24 Ore www.ilsole24ore.com
La vera dimensione della crisi occupazionale
di Francesco Pirone*
da economia e politica – www.economiaepolitica.it
07 Dicembre 2009
L’impatto della recessione economica internazionale sul mercato del lavoro italiano è sempre più evidente com’è dimostrato dall’emergere di sempre nuove e più gravi crisi aziendali e occupazionali, dall’inasprirsi del conflitto sindacale – che rispetto ai mesi passati sta trovando un po’ più di spazio in quotidiani e telegiornali – e dal diffondersi di condizioni, spesso drammatiche, di disagio sociale. La situazione non migliorerà nei prossimi mesi, anzi le proiezioni economiche diffuse dall’OECD nelle scorse settimane segnalano che nel prossimo anno la disoccupazione per l’Italia continuerà ad aumentare, pur in un contesto di lieve ripresa economica[1].
Le statistiche sul tasso di disoccupazione, però, non colgono che una parte dell’attuale crisi occupazionale, sia per distorsioni tecniche nella misurazione della disoccupazione, come si avrà modo di chiarire, sia perché il disagio materiale dei lavoratori è anche legato alla precarizzazione dell’occupazione che s’intreccia all’assenza di lavoro. Il tasso di disoccupazione pertanto è un indicatore che sottostima il disagio economico ed occupazionale dei lavoratori che è un fenomeno a più dimensioni che riguarda lo scoraggiamento nella ricerca di occupazione, il ricorso alla cassa integrazione, la sottoccupazione e il lavoro a termine. È opportuno, quindi, soffermarsi con più attenzione sulle statistiche disponibili per meglio individuare le dimensioni della crisi occupazionale.
I dati più aggiornati e dettagliati ISTAT sul tasso di disoccupazione in Italia, riguardano il secondo trimestre 2009[2]. A quella data le persone in cerca di occupazione – alla base del calcolo del tasso di disoccupazione – erano oltre 1,8 milioni, un valore che è tendenzialmente cresciuto nei mesi seguenti, come dimostrano le recentissime stime mensili provvisorie diffuse dall’ISTAT, registrando che ad ottobre 2009 il numero dei disoccupati era salito a circa 2 milioni[3]. È noto, però, che si tratta di un calcolo che esclude un numero rilevante di persone che pure essendo senza lavoro e ritenendosi disoccupate vengono considerate come “non attive”, perché il conteggio tra i “disoccupati” è vincolato alla ricerca attiva del lavoro e all’immediata disponibilità a lavorare[4]. I lavoratori considerati inattivi perché non soddisfano tali requisiti possono essere considerati “scoraggiati”, cioè persone che hanno smesso la ricerca attiva del lavoro, nella convinzione di non poter trovare occupazione. A questi si aggiungono quelli che, invece, non sono incondizionatamente disponibili a cominciare un lavoro nelle due settimane successive all’intervista, come spesso capita a donne con figli o anziani a carico. L’effetto di questi fenomeni – lo scoraggiamento appunto – può essere stimato analizzando la composizione della popolazione non attiva. Sulla base dei già citati dati ISTAT, l’insieme dei lavoratori scoraggiati contava, a seconda degli aggregati che si includono, tra un minimo di 3,1 milioni persone, ad un massimo di 4,7 milioni di persone. Si tratta di lavoratori che solo per motivi definitori non sono considerati disoccupati e che possono essere conteggiati in aggiunta ai 1,8 milioni di persone ufficialmente in cerca di lavoro e che, se considerate ai fini del calcolo del tasso di disoccupazione, lo farebbero salire dal 7,4%, all’11,9% (calcolo restrittivo) o addirittura al 16,9% (calcolo allargato).
Guardando, d’altra parte, i dati sul numero degli occupati – circa 23,2 milioni – va sottolineato che non viene considerata la diffusione della cassa integrazione guadagni (CIG) a cui le imprese hanno fatto ampio ricorso nel 2009. È opportuno ricordare, infatti, che la CIG non incide sullo stato occupazionale dei lavoratori che, durante i periodi in cassa integrazione, rimangono ufficialmente “occupati”. L’INPS, relativamente al periodo gennaio-ottobre 2009, ha comunicato di aver concesso circa 716,8 milioni di ore di CIG[5]. In relazione a questi dati INPS, le elaborazioni dell’Osservatorio CIG della CGIL stimano un valore medio di 970.844 lavoratori interessati dalla cassa integrazione nei primi dieci mesi dell’anno[6]. In altri termini si tratta di circa un milione di lavoratori che, pur non avendo perso l’occupazione, hanno registrato una riduzione, più o meno rilevante, del reddito da lavoro.
Non tutti i restanti occupati, però, possono essere considerati a riparo dal bisogno materiale. Al contrario, tra i lavoratori sottoccupati, i lavoratori dipendenti a termine e i lavoratori autonomi parasubordinati, c’è una quota a basso reddito e a ridotte (o nulle) protezioni sociali che può essere assimilata a quella che nei contesti anglosassoni viene definita come l’area dei working poors e che, probabilmente, sono più di altri in condizioni di disagio economico e sociale, anche fuori dalla crisi occupazionale.
Tornando alle statistiche disponibili, una dimensione quantitativa indicativa della sottoccupazione emerge dai dati sugli occupati per ore lavorate. Poiché per essere considerati occupati dall’ISTAT basta aver lavorato anche un’ora nella settimana di riferimento, è opportuno scorporare dall’aggregato degli occupati i lavoratori con un orario estremamente ridotto. L’Istituto di statistica rileva che, al secondo trimestre 2009, circa 510 mila persone registrate come occupate hanno svolto meno di 10 ore di lavoro settimanale (circa il 2,2% degli occupati).
Bisogna infine considerare un’area più vasta di occupazione temporanea, più o meno esposta alla precarietà, ma sicuramente a forte rischio nell’attuale crisi occupazionale, cioè in una fase in cui le opportunità di rioccupazione a scadenza di contratto si riducono. Un primo aggregato di lavoratori a rischio occupazionale è quello dei lavoratori dipendenti a tempo determinato che, facendo riferimento alla stessa fonte ISTAT, erano pari a 2,2 milioni (il 9,5% dell’occupazione totale). A questi si può aggiungere una quota di lavoratori parasubordinati conteggiati tra i lavoratori autonomi. Non ci sono dati aggiornati sul lavoro autonomo parasubordinato, tuttavia per avere un ordine di grandezza è utile rifarsi ai dati disponibili di fonte INPS aggiornati al 2007. Analizzando il database INPS, senza considerare i professionisti, si osserva che circa il 58% dei collaboratori non va oltre i 10mila euro di reddito annuo e di questi il 92% ha un solo committente[7]. Questo gruppo di collaboratori a monocommittenza e a reddito basso che rappresenta la quota più debole dei collaboratori era pari nel 2007 a circa 984 mila lavoratori.
L’analisi dei dati statistici disponibili, per quanto artigianale e bisognosa di maggiori approfondimenti evidenzia che la crisi occupazionale, se letta in un’ottica multidimensionale, riguarda un numero di lavoratori che si pone in un ordine di grandezza che è almeno cinque volte l’ammontare della disoccupazione ufficiale. Si tratta di indicazioni di massima coerenti con le informazioni che giorno per giorno la cronaca registra sul malessere dei lavoratori e sul crescente conflitto sociale e che dovrebbero spingere per tempo le istituzioni di governo a mettere la crisi occupazionale e la condizione dei lavoratori al vertice dell’agenda politica, a livello nazionale e territoriale.
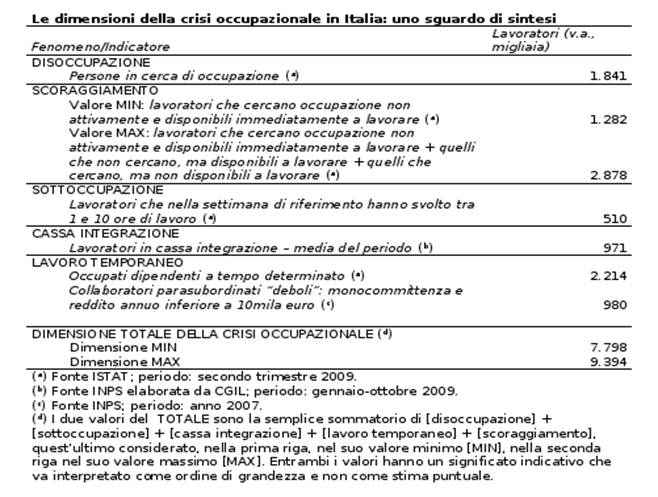
*Assegnista di ricerca, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Università di Salerno
[1] Cfr. OECD, Economic Outlook: Flash file - quarterly projections. Italy - Key economic projections, Parigi, 19 novembre 2009.
[2] Cfr. ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro. II semestre 2009, Roma, 22 settembre 2009.
[3] Cfr. ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro – Dati mensili. Ottobre 2009: dati provvisori, Roma, 1 dicembre 2009.
[4] Sono considerate in cerca di occupazione le persone non occupate tra 15 e 74 anni che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive all’intervista. Sulle distorsioni prodotte dalle definizioni alla base della Rilevazione sulle forze di lavoro, si veda quanto già pubblicato in questa sede: Pirone F., Di cosa parlano le nostre statistiche sul mercato del lavoro?, Economia e Politica, 17 Febbraio 2009.
[5] Cfr. INPS, Osservatorio sulle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni, (aggiornato ad ottobre 2009).
[6] Cfr. CGIL, CIG ottobre 2009, a cura dell’Osservatorio CIG del Dipartimento Settori Produttivi, Roma, 2009.
[7] Cfr. INPS, Osservatorio sui parasubordinati. Contribuenti collaboratori, (aggiornato all’anno 2007).
Capitolo 2
La disoccupazione
Oggi la disoccupazione è uno dei più gravi problemi economici e sociali che affliggono l’Italia e alcuni fra i più importanti paesi europei. Fra gli economisti non esiste consenso sulle sue cause e sulle politiche necessarie per ridurla, per cui si è articolato un vaso dibattito teorico intorno a tale problema. In questo capitolo cercheremo di individuare le cause principali della disoccupazione europea e le ragioni della sua persistenza. Per inquadrare il fenomeno è necessario analizzare alcune distinzioni che permettono di classificare le diverse tipologie di disoccupazione. A questo proposito le statistiche disponibili sono solo parzialmente di aiuto, perché non indicano le cause della disoccupazione.
2.1 Tipi di disoccupazione
I lavoratori sono disoccupati per motivi diversi e per periodi di tempo diversi e i responsabili della politica economica normalmente si preoccupano per certi tipi di disoccupazione e non per altri. Per questo è utile classificare la disoccupazione in base alle sue caratteristiche e alle sue origini.
Tradizionalmente la disoccupazione è stata classificata secondo quattro tipologie: frizionale, strutturale, stagionale e ciclica. In tempi recenti alcuni autori hanno posto l’accento anche sulla disoccupazione tecnologica, che può essere considerata un aspetto particolare della disoccupazione strutturale.
La disoccupazione frizionale è la disoccupazione di breve durata, che deriva dalla normale ricerca del posto di lavoro.
La disoccupazione frizionale esiste perché il mercato del lavoro è una struttura dinamica: ci sono settori in espansione e altri in declino, ci sono imprese che chiudono e altre che nascono, ci sono lavoratori che aspirano a un posto di lavoro più adatto alle proprie esigenze e ci sono persone che cercano occupazione per la prima volta, mentre altre si ritirano dal mercato del lavoro.
Le persone alla ricerca della prima occupazione e i lavoratori che cercano un nuovo posto di lavoro normalmente rimangono disoccupati per un certo periodo. Infatti non tutti i lavori sono uguali, i posti di lavoro si differenziano per mansioni, retribuzione, orari, dislocazione geografica e l’informazione circa le disponibilità di lavoro è imperfetta. Quindi è più che naturale che si impieghi un po’ di tempo per trovare il lavoro adeguato alle proprie capacità ed esigenze anche se la domanda di lavoro è elevata. Poiché esistono delle “frizioni” nel funzionamento del mercato del lavoro e la riallocazione dei lavoratori non è immediata in ogni economia c’è sempre una quota di disoccupazione frizionale.
Molti lavoratori rimangono disoccupati per un periodo di tempo piuttosto lungo, talora interrotto da lavori saltuari. Lunghi periodi di disoccupazione non possono essere attribuiti alla normale ricerca di un posto di lavoro; la disoccupazione strutturale nasce dunque dallo squilibrio fra il numero dei lavoratori con particolari qualifiche e il numero di lavoratori con quelle qualifiche richiesti dalle imprese. In genere la disoccupazione strutturale riguarda i lavoratori non specializzati. Nelle moderne economie infatti è in calo la domanda di lavoro non qualificato, che spesso viene sostituito dalle macchine. Tuttavia si va diffondendo sempre più la disoccupazione di lunga durata anche fra lavoratori che hanno qualificazioni anche elevate, ma diverse da quelle richieste dal mercato.
Nel Consiglio Europeo di Lisbona, tenutosi nel marzo del 2000, erano stati fissati una serie di obiettivi per il 2010 in materia di occupazione, fra cui quello di un tasso di occupazione del 70% un tasso di occupazione femminile del 60%.
Si intende per distretto industriale un’area delimitata in cui si raccolgono piccole imprese appartenenti allo stesso settore. Grazie alla sua omogeneità consente l’accumulazione e la trasmissione di esperienze e conoscenze.
Le rilevazioni dell’Istat non consentono di conoscere il numero dei contratti a termine stipulati né la loro durata, ma solo il numero di lavoratori occupati con tali contratti nella settimana in cui l’intervista dell’Istat è stata eseguita.
Si noti che il peso dell’economia sommersa sembra essere in crescita ovunque. Secondo lo studio di F. Schneider “Nuovi risultati sull'andamento delle dimensioni dell'economia sommersa in 17 paesi OCSE”, pubblicato dall’OCSE (1998) l’incidenza dell’economia sommersa sul PIL in Italia sarebbe pari al 28,2%, il che porrebbe l’Italia, a fianco della Grecia, nei primissimi posti fra le economie della UE, seguite nell’ordine da Spagna, Portogallo, Belgio (oltre il 20%); gli altri paesi UE si collocherebbero fra il 10 e il 20%, ad eccezione dell’Austria (9,6%)
La distinzione fra disoccupazione strutturale e frizionale è sfumata; la discriminante è la durata dei periodi di disoccupazione. In caso di disoccupazione strutturale gli ostacoli che separano i posti vacanti dai lavoratori disoccupati sono notevoli e richiedono che i lavoratori si impegnino per acquisire nuove specializzazioni e/o si trasferiscano in località diverse. In caso di disoccupazione frizionale invece le barriere derivano semplicemente da imperfezioni dell’informazione. Rimane problematico in quale categoria collocare una disoccupazione della durata di alcuni mesi che richiede un qualche impegno in nuove attività formative per essere riassorbita.
L’attuale situazione del mercato del lavoro richiede una ulteriore nozione di disoccupazione, che possiamo definire “disoccupazione intermittente”. La diffusione dei contratti a tempo determinato ha creato una nuova categoria di lavoratori, che passano continuamente da periodi di lavoro a periodi di disoccupazione non per loro volontà ma perché comunque non riescono a trovare un’occupazione stabile. In molti casi rimangono disoccupati per periodi brevi, ma più volte nel corso di un solo anno e spesso devono impegnarsi in corsi di formazione per poter trovare una nuova occupazione.
La disoccupazione stagionale risulta da un minor livello di attività economica in determinati settori dell’economia in particolari momenti dell’anno. Per esempio nel settore agricolo e nell’edilizia c’è un rallentamento dell’attività durante l’inverno. Anche il turismo è spesso un fenomeno stagionale.
La disoccupazione ciclica deriva da un rallentamento dell’attività produttiva. Nelle fasi recessive ristagna il livello dell’attività economica e di conseguenza diminuisce la domanda di lavoro. In queste fasi aumenta quindi la disoccupazione. La disoccupazione ciclica viene poi riassorbita nelle fasi espansive del ciclo economico.
La disoccupazione tecnologica deriva dall’introduzione di impianti e macchinari che consentono di risparmiare la quantità di lavoro impiegata per unità di prodotto. Non necessariamente il progresso tecnico è distruttore di lavoro, anzi spesso l’introduzione di innovazioni comporta un aumento della domanda di lavoro, perché induce lo sviluppo di nuove attività produttive. Tuttavia esistono fasi in cui l’innovazione tecnologica comporta prevalentemente l’introduzione di tecnologie labour-saving e conduce quindi alla soppressione di posti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le mansioni non qualificate.
Disoccupazione di squilibrio
La persistenza di elevati tassi di disoccupazione per periodi prolungati, come quella che ha caratterizzato l’economia europea a partire dagli anni settanta, è indice dell’esistenza di uno squilibrio duraturo fra domanda e offerta di lavoro non attribuibile a frizioni o a ostacoli temporanei. Dal punto dell’analisi macroeconomica può essere utile una classificazione che mette in risalto tale fenomeno, e cioè quella fra disoccupazione frizionale e disoccupazione di squilibrio . Si può definire disoccupazione di squilibrio l’eccedenza netta dell’offerta sulla domanda di lavoro. La disoccupazione frizionale è misurabile come il numero di lavoratori disoccupati uguale al numero dei posti di lavoro vacanti. Tale distinzione non mette in luce le cause della disoccupazione, bensì evidenzia che esiste una quota di disoccupazione attribuibile alle normali frizioni esistenti in ogni mercato del lavoro, per cui esistono contemporaneamente posti di lavoro vacanti e disoccupati, e questo è un fenomeno fisiologico in qualsiasi economia, e che ci sono lavoratori disoccupati perché nel sistema economico i posti di lavoro disponibili nell’economia non sono sufficienti ad assorbire l’intera forza lavoro. Vedremo più avanti quali sono le cause dello squilibrio esistente sul mercato del lavoro. Non tutti gli economisti si trovano d’accordo su questa distinzione, dato che, come vedremo in seguito, ci sono teorici convinti della capacità del sistema economico di condurre all’equilibrio fra domanda e offerta di lavoro: come ogni altro mercato, anche il mercato del lavoro sarebbe governato dalla legge della domanda e dell’offerta e quindi non viene concepita l’idea di uno squilibrio persistente. In questa ottica la disoccupazione si giustificherebbe con un temporaneo ritiro del lavoratori disoccupati dal mercato del lavoro e la disoccupazione si configurerebbe, in tal caso, come disoccupazione volontaria. Questa constatazione ci rimanda a un'altra classificazione presente nella teoria economica sulla disoccupazione e cioè quella fra disoccupazione volontaria e involontaria.
Il concetto di disoccupazione volontaria può sembrare un paradosso; se un individuo è volontariamente disoccupato, ciò significa che non intende lavorare e quindi non fa parte della forza lavoro, come tale a rigore non può essere considerato disoccupato. Tuttavia nella teoria economica il concetto di disoccupazione volontaria è ampiamente utilizzato, anche se non è privo di ambiguità. In prima approssimazione possiamo affermare che si ha disoccupazione volontaria quando ci sono lavoratori che non accettano di lavorare al salario corrente, ma sarebbe disponibile a lavorare se gli venisse offerto un salario più elevato. Viceversa quando ci sono lavoratori disoccupati disposti a lavorare al salario corrente si ha disoccupazione involontaria. Come si è detto, ci sono economisti che non credono nell’involontarietà della disoccupazione e che sono convinti che la disoccupazione sia solo volontaria. Ritengono infatti che chiunque possa trovare un lavoro se disposto ad accettare un salario sufficientemente basso; su questo argomento torneremo più avanti.
La distinzione fra disoccupazione volontaria e involontaria comunque non è del tutto chiara. In primo luogo si dovrebbero conoscere le motivazioni dei singoli lavoratori disoccupati. Per esempio, deve essere considerato disoccupato volontario un lavoratore che rifiuta una occupazione non adeguata alla sua preparazione professionale o un lavoratore costretto a lavorare per una paga da fame? In secondo luogo è necessario tenere conto di quanto tempo i lavoratori impiegano per trovare un lavoro e di quali difficoltà incontrano in tale ricerca. Nei periodi di elevata disoccupazione può risultare lungo e difficile trovare un lavoro, per cui molti potenziali lavoratori abbandonano la ricerca di impiego; i lavoratori scoraggiati potrebbero essere considerati disoccupati volontari, ma non vengono computati nella forza lavoro e quindi nelle statistiche ufficiali non appaiono come disoccupati.
Queste osservazioni evidenziano come dal punto di vista dell’analisi empirica le statistiche sulla disoccupazione offrono un quadro molto approssimativo della reale situazione del mercato del lavoro, ma mettono anche in luce l’ambiguità della distinzione fra disoccupazione volontaria e involontaria, almeno nel significato che oggi si attribuisce a tale classificazione. Viceversa la distinzione fra disoccupazione frizionale e di squilibrio evidenzia l’essenza del problema e, in linea con l’analisi keynesiana, mette in luce come la disoccupazione, nella sua componente non frizionale, sia il risultato del fallimento dell’azione riequilibratrice delle forza di mercato.
In realtà la distinzione fra disoccupazione frizionale, volontaria e involontaria fu introdotta da Keynes, ma con un significato diverso da quello che oggi comunemente le si attribuisce. Keynes infatti enfatizzò il concetto di disoccupazione involontaria per sottolineare il fatto che la disoccupazione è il risultato di squilibri che si generano fuori del mercato del lavoro e che impediscono a un certo numero di lavoratori di trovare occupazione al salario corrente o anche a un salario lievemente inferiore (cfr. Keynes J. M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London; trad. it. Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet, Torino, 2001, pag.199 edizione italiana). La disoccupazione volontaria sarebbe invece determinata dal rifiuto o dall’incapacità dei singoli lavoratori “di accettare una remunerazione corrispondente al valore del prodotto attribuibile alla sua produttività marginale” (Keynes pag.190).
2.2 I costi della disoccupazione
La disoccupazione provoca gravi costi individuali e seri danni all’economia e alla società.
Naturalmente l’entità dei danni dipende in larga misura dalla durata della disoccupazione. La disoccupazione frizionale non è obiettivamente preoccupante. Ben diversa è la disoccupazione che dura a lungo. La presenza di un’ampia quota disoccupazione di lunga durata implica che il sistema non è in grado di assorbire le fasce più deboli dei lavoratori e per gli individui che rimangono senza lavoro per mesi o, talora, anche per anni, la situazione è molto grave per tutta una serie di motivi. Il più ovvio è naturalmente la mancanza di una retribuzione, che porta gli individui a ridimensionare il loro livello di spesa e può portare a situazioni di povertà.
Il problema non è solo economico; gli aspetti economici sono risolti, in molti paesi, con aiuti e sussidi che permettono di porre rimedio, almeno parzialmente, al problema della mancanza di reddito . La disoccupazione di lunga durata provoca una perdita di capacità e competenze e ciò pregiudica la possibilità di trovare lavoro per chi è rimasto a lungo inattivo. La disoccupazione comporta anche gravi costi psicologici: i disoccupati si sentono esclusi, perdono fiducia in se stessi, si sentono un peso per la famiglia e per la società, cadono facilmente in depressione. La perdita di motivazioni che accompagna lo stato di disoccupazione può rendere passivi gli individui e rende sempre più problematico il reinserimento nel mercato del lavoro.
I danni della disoccupazione non sono solo individuali, sono costi per l’intera società.
La disoccupazione costituisce una perdita di capacità produttiva, uno spreco di risorse; la perdita di competenze e capacità è distruzione di capitale umano; i disoccupati costituiscono infatti risorse esistenti che non vengono utilizzate e ciò significa che il reddito prodotto è minore di quello che si potrebbe realizzare se tutti fossero occupati. Un’elevata disoccupazione può anche portare a un peggioramento delle condizioni di lavoro esistente, ad esempio si possono tenere in vita attività e posizioni lavorative improduttive e, talora, anche rischiose solo per evitare l’aggravarsi della situazione occupazionale. Si pensi, a questo proposito, al caso degli impianti petrolchimici di Gela. Si trattava di impianti fortemente inquinanti che mettevano a rischio la salute dei lavoratori e della popolazione locale; nonostante gli evidenti pericoli, gli abitanti di Gela nel 2002 si sono ribellati all’eventualità di chiusura di tali impianti, perché questi rappresentavano la fonte principale di occupazione e quindi di sostentamento per la cittadinanza.
La disoccupazione aumenta le disuguaglianze fra i cittadini e può creare perciò tensioni sociali e comportamenti xenofobi. Quando la domanda di lavoro è bassa di solito le persone più colpite dalla disoccupazione sono le minoranze appartenenti alle fasce deboli. Ciò rende più difficile l’integrazione degli immigrati e spesso provoca comportamenti razzisti, perché gli immigrati vengono considerati persone in concorrenza per i posti di lavoro; spesso sentiamo affermare infatti che gli immigrati “rubano” il posto di lavoro agli italiani.
La disoccupazione, inoltre, influenza i salari e le condizioni di lavoro degli occupati. Man mano che cresce la disoccupazione, aumenta la competizione fra lavoratori e ciò provoca una pressione sui salari verso il basso, come emerge dalla curva di Phillips. La competizione sul mercato del lavoro favorisce inoltre lo sviluppo del lavoro nero e di forme di lavoro atipico a bassa remunerazione, che accrescono insicurezza e precarietà nelle fasce deboli della forza lavoro. Ciò provoca un aumento nella dispersione salariale e una crescita delle disuguaglianze. Il fenomeno dei working poors, cioè dei lavoratori che vivono al di sotto della soglia della povertà, è il risultato più evidente della concorrenza fra lavoratori in una situazione di insufficienza di domanda di lavoro.
2.3 La disoccupazione: alcuni dati di lungo periodo.
Negli ultimi cinquant’anni, le economie dei paesi capitalistici hanno conosciuto diverse situazioni occupazionali. Per quanto riguarda i paesi dell’Europa Occidentale possiamo distinguere con una certa precisione due fasi: una prima fase, che va dal secondo dopoguerra al 1973, caratterizzata da tassi di disoccupazione bassi e tendenzialmente in calo, e la fase successiva al 1973, in cui si è registrato un notevole aumento del tasso di disoccupazione.
Nel corso della prima fase si è avuta quasi la sensazione che la disoccupazione non costituisse più un problema per la maggior parte delle economie europee. In Italia si sono registrati tassi di disoccupazione un po’ più elevati che nel resto d’Europa essenzialmente a causa delle difficili condizioni dell’economia del Mezzogiorno, ma comunque nel decennio 1960-70 il picco massimo nel tasso di disoccupazione è stato nel 1965 con un valore inferiore al 6%. Le altre importanti economie europee facevano registrare tassi di disoccupazione ancora più contenuti.
Anche in Giappone la disoccupazione era a livelli minimi, mentre negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione era un po’ più elevato che in Europa ed oscillava fra il 4 e il 5%.
A partire dal 1973, anno della prima crisi petrolifera, la disoccupazione comincia a crescere quasi ovunque (vedi tabella 2.1). Nell’Unione Europea il fenomeno diventa allarmante soprattutto a partire dagli anni ottanta. Nella seconda metà degli anni novanta si è registrata un’inversione di tendenza, più accentuata nelle economie di piccole dimensioni. Ma in Francia, Germania, Grecia e Spagna il tasso di disoccupazione continua a superare il 9%. Anche in alcuni fra i paesi recentemente entrati nella UE la situazione è critica, in particolare in Polonia (17,7% nel 2005) e Slovacchia (16,3%).Negli ultimi decenni la disoccupazione non ha toccato livelli elevati come quelli registrati nel corso della Grande Depressione (negli Stati Uniti nel 1932 aveva raggiunto il 24%), ma certamente ha raggiunto livelli allarmanti (in Spagna fra il 1982 e il 1998 non è mai scesa sotto il 15%).
In Europa appare preoccupante soprattutto il fenomeno della persistenza della disoccupazione, cioè il fatto che ad ogni recessione il tasso di disoccupazione aumenta, ma nelle fasi espansive del ciclo la disoccupazione si riduce poco, per cui cresce il tasso di disoccupazione tendenziale (depurato cioè dagli effetti del ciclo economico).
Negli Stati Uniti la crescita del tasso di disoccupazione dopo la prima crisi petrolifera è stata più contenuta che in Europa. A partire dagli anni novanta il tasso di disoccupazione ha cominciato a diminuire e, verso la fine dello scorso decennio, ha raggiunto il livello più basso dal 1970. Con la crisi che ha investito l’economia americana, la disoccupazione è tornata a crescere nel 2001 e, nel 2003 ha raggiunto il 6%, ma, con la ripresa, è tornata a calare.
In Giappone il tasso di disoccupazione ha mostrato una lieve tendenza alla crescita a partire dalla prima crisi petrolifera, ma si mantiene comunque a livelli molto bassi fino alla fine degli anni novanta, e anche in piena recessione, la situazione occupazionale non è mai apparsa allarmante. Nel 2003 il tasso di disoccupazione in Giappone ha raggiunto il picco massimo degli ultimi quarant’anni (5,3%), ma, ai primi segni di ripresa, la disoccupazione ha cominciato a scendere.
2.4 Diagnosi della disoccupazione
Analizziamo ora a grande linee le principali interpretazioni del problema attuale della disoccupazione, con particolare riferimento alla disoccupazione europea.
Come abbiamo visto, nel corso degli ultimi vent’anni la disoccupazione nei paesi della UE ha mostrato un trend crescente, mentre negli Stati Uniti è rimasta fluttuante e a livelli tendenzialmente più bassi di quelli dell’Unione Europea. I 15 paesi della UE presentano una struttura economica e una performance occupazionale tutt’altro che omogenea. Da un lato dobbiamo considerare la Germania che, fino alla riunificazione con la Germania est, ha mantenuto un tasso di disoccupazione mediamente più basso degli Stati Uniti, dall’altro paesi in cui si è verificato un notevole aumento della disoccupazione fin dagli anni ottanta, come l’Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi di dimensioni minori. Ci sono poi paesi europei che hanno mantenuto un tasso di disoccupazione costantemente basso, come l’Austria, e infine alcune economie in cui la crisi occupazionale è stata superata nella seconda metà degli anni novanta, ad esempio Paesi Bassi, Svezia e Gran Bretagna. Attualmente, come si è detto, i problemi maggiori riguardano le più importanti economie dell’Europa continentale (Francia, Germania, Italia, Spagna).
Le spiegazioni prevalenti delle diverse performance occupazionali di Stati Uniti e dei principali paesi dell’ Europa continentale si concentrano su vari tipi di elementi.
- la rigidità del mercato del lavoro e la generosità dei sistemi di welfare in Europa che provocherebbero alti costi del lavoro e disoccupazione; in particolare gli elevati sussidi di disoccupazione causerebbero un allungamento nei tempi di ricerca del lavoro, i sistemi di welfare comporterebbero elevati cunei fiscali, con effetto depressivo sulla domanda di lavoro, e la rigidità del mercato del lavoro disincentiverebbe le assunzioni;
- gli shock macroeconomici, non contrastati, anzi spesso causati dalle politiche economiche; in particolare le politiche di rigore fiscale e monetario condotte nei paesi europei per rispettare i vincoli imposti dal trattato di Maastricht avrebbero comportato un rallentamento della crescita e, conseguentemente, un aumento della disoccupazione;
- il cambiamento tecnologico, che ha portato a trasformazioni radicali nello sviluppo economico, che avrebbe generato disoccupazione anche in presenza di crescita dell’economia.
La prima di queste spiegazioni ha ristretto l’attenzione alla struttura del mercato del lavoro, le altre contengono un approccio più ampio che vede la disoccupazione come risultato di eventi che investono l’intera economia. Si tenga conto che in ogni caso gli aspetti sopra citati non si escludono e possono essere concomitanti.
2.5 Le rigidità del mercato del lavoro
Negli approcci di economia del lavoro oggi prevale la prima ipotesi. Si contrappone infatti il modello americano del mercato del lavoro - estremamente flessibile - con il modello rigido dell’Europa continentale , in cui la necessità di finanziare il generoso sistema di welfare incide sul costo del lavoro, creando un eccessivo cuneo contributivo. Tale impostazione presenta dei seri limiti, poiché le rigidità esistenti nel mercato del lavoro europeo si sono sensibilmente attenuate, o sono quasi sparite, negli anni ottanta e nei primi anni novanta, proprio in parallelo col peggioramento della situazione occupazionale. La forza contrattuale dei sindacati è nettamente calata, i salari reali non hanno più presentato rigidità verso il basso, l’introduzione dei contratti atipici ha permesso un utilizzo molto flessibile del lavoro, sia in termini di orari che di durata temporale delle prestazioni lavorative, sono stati allentati i vincoli nelle modalità di assunzioni e licenziamenti. Ad esempio, la mobilità del lavoro in Italia è molto elevata: ogni anno nel nostro paese vengono creati e distrutti oltre un milione di posti di lavoro e il tasso di turn-over dei lavoratori è molto simile a quello degli Stati Uniti. Le “rigidità” a cui si attribuisce la causa della disoccupazione erano presenti negli anni sessanta e settanta, quando il tasso di disoccupazione era ai livelli minimi e da allora si sono notevolmente ridotte.
L’evidenza empirica mostra dunque che l’aumento della disoccupazione non può essere interpretato con l’aumento delle rigidità del mercato del lavoro.
Se poi guardiamo ai dati più recenti sulla disoccupazione, notiamo che negli Stati Uniti, ai primi segni di recessione, si è registrato un forte aumento del tasso di disoccupazione, e ciò fa pensare che la ragione del boom occupazionale negli USA negli anni novanta non debba ricercarsi nella flessibilità del lavoro, ma nelle condizioni economiche favorevoli.
A parte il fatto che la performance occupazionale degli anni novanta negli Stati Uniti non sembra avere origine dalla flessibilità del lavoro, possiamo domandarci se sia opportuno seguire il modello flessibile di stampo anglosassone (come si tende a fare in numerosi paesi europei, fra i quali l’Italia) alla luce dei costi che questo modello comporta in termini di ineguaglianza e povertà. La crescita dell’occupazione è infatti avvenuta a spese della stagnazione e, talora, della riduzione dei salari reali dei lavoratori meno qualificati; di conseguenza è aumentato il numero dei lavoratori poveri e sono aumentate le disuguaglianze nei redditi dei cittadini. La mancanza di un sistema adeguato di welfare ha ulteriormente peggiorato le condizioni di povertà di una vasta fascia di lavoratori. Si è creato così un mercato del lavoro “duale”, diviso cioè in due sottomercati: il mercato primario, che comprende i posti stabili e adeguatamente remunerati, e il mercato secondario che comprende posti di lavoro a bassa qualifica, precari e mal pagati.
E’ importante poi sottolineare che la deregolamentazione del mercato del lavoro e la riduzione delle garanzie fornite dai sistemi di protezione sociale possono avere effetti depressivi sulla spesa delle famiglie e quindi possono portare ad una flessione della domanda e, di conseguenza dell’occupazione. Infatti il venir meno della certezza di mantenere il posto di lavoro, associato alla riduzione del sistema di welfare, crea incertezza e quindi riduce la domanda di beni e aumenta la propensione al risparmio.
2.6 Il ruolo degli shock
L’attenzione rivolta alla contrapposizione rigidità - flessibilità ha lasciato in secondo piano i problemi posti dal rallentamento della crescita e dagli shock macroeconomici che hanno colpito le economie europee.
L’Europa è stata colpita da gravi shock dall’inizio degli anni settanta; inizialmente le crisi petrolifere hanno inciso sulla crescita delle economie europee, determinando un aumento della disoccupazione. Dopo gli shock petroliferi sono state perseguite, in alcuni paesi, politiche macroeconomiche inadeguate.
Negli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta il tasso di inflazione è rapidamente cresciuto e perciò, nonostante la crescita della disoccupazione, nelle economie europee sono state adottate drastiche politiche deflative. In particolare le banche centrali hanno condotto politiche monetarie fortemente restrittive; in paesi come Italia e Francia e Gran Bretagna tali politiche hanno generato un aumento dei tassi di interesse reali che, provocando un rallentamento degli investimenti, hanno dato origine a una crisi occupazionale. Si noti peraltro che la Germania è riuscita a contenere la riduzione dell’occupazione fino all’inizio degli anni novanta.
Per quanto riguarda l’Italia, la permanenza nel Sistema Monetario Europeo (SME) e la politica di cambio forte ad essa associata ha comportato un crescente passivo nei conti con l’estero e una caduta delle esportazioni, con ulteriori risvolti negativi sul piano occupazionale.
La riunificazione della Germania ha costituito un ulteriore shock. Per finanziare la ricostruzione della Germania Orientale il governo tedesco ha aumentato la spesa pubblica, accrescendo il deficit di bilancio. Per tenere sotto controllo la crescita della domanda aggregata e del tasso di inflazione, la Bundesbank ha condotto una politica monetaria restrittiva. Questo mix di politiche economiche ha portato a un aumento del tasso di interesse nominale in Germania, che si è trasmesso agli altri paesi europei e ne è perciò seguito un rallentamento dell’attività economica.
Le severe politiche monetarie e finanziarie messe in atto dai paesi europei per centrare gli obiettivi del trattato di Maastricht hanno ulteriormente aggravato la situazione occupazionale in tutti i paesi aspiranti ad entrare nell’Unione Economica e Monetaria (UEM) . Non è un caso che il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna, che ha avuto un andamento simile a quello della media dei paesi della UE fino all’inizio degli anni novanta, sia sceso nettamente proprio nella seconda metà degli anni novanta. Anche negli altri paesi della UE che non sono entrati nella UEM, cioè Svezia e Danimarca, si è registrato un vistoso calo della disoccupazione. Gran Bretagna, Svezia e Danimarca, infatti, non essendo vincolate al trattato di Maastricht, non hanno dovuto condurre quelle politiche restrittive che hanno causato una crisi occupazionale in quasi tutti i paesi dell’area dell’euro.
Vediamo meglio perché questa serie di shock ha comportato un calo del tasso di crescita dell’economia e dell’occupazione. Con l’aumento del tasso di interesse reale (che è andato crescendo continuativamente dalla metà degli anni settanta fino alla fine degli anni novanta) è rallentata la dinamica degli investimenti, che ha portato a una crescita limitata della domanda aggregata, insufficiente a mantenere i precedenti livelli di occupazione. A sua volta l’aumento della disoccupazione ha minato il potere contrattuale dei lavoratori e indebolito i sindacati con un conseguente ristagno della domanda di consumi. Le imprese, vincolate dal lato della domanda, hanno limitato soprattutto gli investimenti estensivi, quelli cioè volti a un aumento della capacità produttiva e hanno privilegiato gli investimenti intensivi, cioè quelli volti a introdurre innovazioni risparmiatrici di lavoro. In questo contesto già negativo si sono innestati negli anni novanta i tagli alla spesa pubblica nei paesi dell’UEM per rientrare nei parametri di Maastricht. Le politiche restrittive condotte simultaneamente nei paesi europei si sono reciprocamente rafforzate, perché è rallentata anche la domanda estera.
Dal 2000 la situazione occupazionale è in lieve miglioramento, ma la cautela della Banca Centrale Europea nell’operare sui tassi di interesse per timore di spinte inflazionistiche continua a costituire un freno alla creazione di posti di lavoro.
2.7 Il cambiamento tecnologico
Consideriamo infine l’approccio che spiega l’aumento della disoccupazione con i cambiamenti tecnologici in atto. All’interno di tale approccio troviamo due diverse posizioni: da un lato c’è chi sostiene che sarebbe in atto una tendenza verso la “fine del lavoro” come fenomeno di massa, dall’altro c’è chi invece è convinto che questa fase di cambiamento tecnologico comporti un rallentamento temporaneo nella creazione di posti di lavoro.
La prima posizione è nettamente minoritaria fra gli economisti; si ritiene che le nuove tecnologie e la rivoluzione dell’informazione tendano a distruggere più posti di lavoro di quanti ne creino, che le macchine stiano progressivamente sostituendo gran parte delle mansioni svolte dall’uomo e che ci si avvii verso un mondo caratterizzato da una disoccupazione di massa. Questo approccio si basa sulla seguente constatazione: l’occupazione dapprima è calata nell’agricoltura e la manodopera in eccesso è stata assorbita dal settore manifatturiero, in un secondo tempo è calato anche il peso del manifatturiero e il terziario ha occupato un numero sempre maggiore di lavoratori. Ma ora ci si avvierebbe anche verso la saturazione del terziario e non esistono opportunità di impiego in altri settori. L’aumento della produttività del lavoro dunque creerebbe un eccesso di offerta di lavoro, che non trova sbocchi. Questa visione non ci sembra condivisibile, in quanto si tratta di un approccio statico che non tiene conto dell’evoluzione delle necessità e delle opportunità che col tempo si sviluppano. In altri termini esistono ancora molti bisogni insoddisfatti e nascono nuove esigenze con l’evolversi delle tecnologie, quindi esistono notevoli potenzialità di creazione di nuovi posti di lavoro. Si deve tener conto inoltre che le innovazioni di processo, cioè quelle volte ad accrescere la produttività, conducono alla creazione di nuove attività legate alla produzione di beni capitali e spesso costituiscono il punto di avvio per le innovazioni di prodotto.
Senza dubbio invece le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione hanno causato profondi mutamenti nei processi produttivi e di conseguenza è cambiata la composizione della domanda di lavoro. Nei paesi industrializzati si richiedono lavoratori con nuove competenze e specializzazioni e diminuisce la domanda di lavoratori a scarsa qualificazione. Si crea disoccupazione se, come accade in Italia e in altri paesi europei, il sistema industriale rimane ancorato alle produzioni tradizionali, i sistemi formativi non sono in grado di offrire la preparazione adeguata ai cambiamenti tecnologici in atto, l’attività di ricerca e sviluppo è inadeguata. E’ soprattutto l’incapacità del sistema europeo di adattarsi alle nuove tecnologie e di valorizzare le nuove potenzialità che da queste scaturiscono che genera scarsità di domanda di lavoro. Perciò, mentre vengono distrutti posti di lavoro in attività caratterizzate da una flessione della domanda, non ne vengono creati in modo sufficiente nelle attività nuove e in espansione. Il progresso tecnico non può dunque essere considerato automaticamente causa della disoccupazione; anzi l’evidenza empirica sembra dar ragione alla visione schumpeteriana secondo cui l’innovazione è l’elemento trainante della crescita e dell’occupazione. Nel ventennio 1950-70 produzione e produttività crescevano nei paesi europei a livelli eccezionalmente elevati e la disoccupazione era a livelli minimi. Nel periodo successivo la crescita della produttività si è ridotta, le economie europee hanno mostrato di non essere in grado di innovare e di adottare rapidamente le nuove tecniche produttive e hanno quindi subito una crisi occupazionale.
2.8 Isteresi
Uno dei fenomeni più preoccupanti nelle principali economie dell’UE è quello della persistenza della disoccupazione, chiamato anche “isteresi”. Per isteresi si intende l’incapacità della disoccupazione di ritornare al suo livello originario quando le cause che ne hanno determinato un aumento sono venute meno. Come abbiamo visto una serie di shock hanno determinato in certe fasi un aumento della disoccupazione; il problema è che quando l’effetto di tali shock è cessato, il tasso di disoccupazione non è ritornato al livello precedente. Ciò ha determinato un aumento tendenziale della disoccupazione. Tale fenomeno ha toccato gran parte delle economie europee, ma non quella statunitense, in cui il tasso di disoccupazione ha subito notevoli oscillazioni, senza mostrare una tendenza alla crescita di lungo periodo. Come si è visto, una tendenza alla crescita della disoccupazione si è manifestata anche in Giappone, ma il tasso di disoccupazione giapponese si è mantenuto costantemente basso ed è aumentato in tempi recenti solo in concomitanza con una grave recessione. (cfr. tabella 2.2 ).
C’è il rischio che il fenomeno dell’isteresi si manifesti in modo drammatico con l’attuale recessione, come già si era manifestato dopo la depressione degli anni 30. Quando, intorno alla fine degli anni trenta si era verificata la ripresa della produzione, la disoccupazione era ancora a livelli molto più elevati del periodo pre-crisi.
Tabella 2.2 Tassi di disoccupazione, media annua
UE -15 |
Italia |
USA |
Giappone |
|
1961/70 |
2,2 |
4,8 |
4,7 |
1,2 |
1971/80 |
4,3 |
6,1 |
6,4 |
1,8 |
1981/90 |
8,9 |
8,7 |
7,1 |
2,5 |
1991/00 |
9,8 |
10,8 |
5,2 |
3,1 |
Fonte: elaborazione su dati OCSE
Gli economisti hanno dato varie spiegazioni del fenomeno dell’isteresi.
Una prima spiegazione si richiama al modello insider-outsider. Sinteticamente si basa sull’idea che esista una situazione di conflitto fra occupati (insider) e disoccupati (outsider): i sindacati contrattano i salari compatibili con i livelli di occupazione esistenti, senza curarsi delle esigenze dei disoccupati. Ad ogni aumento di disoccupazione dovuto ad uno shock, diminuiscono gli insider e quindi il nuovo livello di occupazione può essere preservato anche in presenza di salari più elevati, che i sindacati non esiteranno a rivendicare per difendere i propri iscritti. Quindi ad ogni fase negativa aumenterebbe la disoccupazione che non sarebbe riassorbita nelle fasi positive, a causa dell’atteggiamento antisolidaristico degli insider. Questa teoria non solo non trova riscontro nell’evidenza empirica, ma appare nettamente in contrasto con il ruolo assunto dai sindacati che, dagli anni settanta, hanno rivolto una crescente attenzione ai problemi dei disoccupati. Tuttavia si tratta di un approccio che ha riscosso fra gli economisti un notevole successo.
C’è una teoria che lega il fenomeno della persistenza della disoccupazione al fattore “capitale umano”. I lavoratori che rimangono disoccupati per un periodo di tempo lungo perdono capacità e conoscenze, non sono in grado di mantenere le proprie competenze al passo con l’evoluzione dei processi produttivi. Se shock che generano disoccupazione si susseguono con una certa frequenza, le possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati di lungo periodo si riducono. Col tempo tali lavoratori riducono anche l’intensità di ricerca del posto di lavoro, per cui si attenua anche il loro peso nei processi di contrattazione salariale e ciò, come nel modello insider-outsider, fa aumentare anche il livello di equilibrio del salario. Il “deterioramento del capitale umano” può forse dare un contributo all’analisi dell’isteresi, ma certamente da solo non è in grado di spiegare il fenomeno della persistenza della disoccupazione; può essere utile soprattutto per spiegare i bassi tassi di partecipazione alle forze di lavoro dovuti alla rinuncia a cercare occupazione da parte dei soggetti deboli (donne, persone in età avanzata).
Più interessante sembra essere l’approccio che spiega l'isteresi attraverso l'effetto che un calo della domanda aggregata ha sugli investimenti. Nelle fasi di ristagno della produzione, la capacità produttiva risulta sottoutilizzata, il che provoca una contrazione degli investimenti e, conseguentemente, un rallentamento della crescita dello stock di capitale in termini fisici fino al momento in cui non torna a crescere il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Ma, quando si verifica una nuova espansione della domanda, le imprese non possono avvantaggiarsi di un eccesso di capacità produttiva per espandere la produzione e l'occupazione e tendono ad utilizzare al massimo la capacità produttiva esistente e quindi ad aumentare i prezzi. Tuttavia, col tempo, se non subentrano ostacoli, la capacità produttiva dovrebbe riportarsi al livello di equilibrio e la disoccupazione dovrebbe essere riassorbita. Ma, se come è accaduto nella maggior parte dei paesi europei, i responsabili della politica economica non accettano un aumento dell'inflazione e intraprendono politiche restrittive che rallentano la domanda e quindi la crescita e l'occupazione, si innesta un circolo vizioso che tende a elevare il tasso di disoccupazione tendenziale.
Capitolo 3
Occupazione e salari nell’analisi di Keynes
1.3 Keynes e la critica ai “classici”
Nel 1936, in piena depressione, Keynes pubblicò La teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta. A quel tempo le economie dei paesi capitalistici non sembravano in grado di uscire dalla grave recessione che aveva seguito la crisi del ’29; gli economisti dell’epoca tuttavia continuavano ad essere convinti che il sistema possedesse i meccanismi necessari per ritornare alla piena occupazione. Essi ritenevano che prezzi e salari reagissero istantaneamente alle variazioni della domanda e dell’offerta, portando automaticamente all’equilibrio di piena occupazione. Nel 1933 era stato pubblicata La teoria della disoccupazione di Pigou , un’opera attenta al problema occupazionale che tuttavia non prendeva le distanze dal pensiero dominante. e contemplava solo due tipi di disoccupazione, quella frizionale e quella volontaria. Nell’opera di Pigou non è invece ammessa l’eventualità di una terza categoria di disoccupazione, cioè quella involontaria, che si manifesta quando ci sono persone disponibili a lavorare al livello di salario esistente che non trovano occupazione. Ciò – sottolinea Keynes – viene giustificato dai “classici” dal fatto che esiste un accordo fra i lavoratori a non lavorare per meno; se i lavoratori fossero disponibili ad accettare una riduzione dei salari, l’occupazione aumenterebbe. Quindi quella che apparentemente può essere considerata disoccupazione involontaria deve essere ricompresa, secondo i classici, nella categoria della disoccupazione volontaria.
L’approccio keynesiano si contrappone in modo netto a questa visione. La critica di Keynes si basa su due argomentazioni, l’una, basata sull’evidenza empirica, che riguarda l’atteggiamento dei lavoratori nella contrattazione salariale e l’altra, che Keynes definisce teoricamente “fondamentale”, che fa riferimento alle modalità di determinazione del salario reale.
Iniziamo con la prima obiezione alla scuola classica. Richiamandosi all’esperienza storica, Keynes osserva che c’è una certa resistenza da parte dei lavoratori ad una diminuzione del salario monetario, il che non significa che essi non accettino riduzioni del salario reale quando queste si manifestano attraverso un aumento del livello dei prezzi. In altri termini, può darsi che i lavoratori chiedano un salario monetario minimo, ma non un salario reale minimo, almeno entro certi limiti; infatti essi non ritirano la loro offerta di lavoro quando i prezzi aumentano. Si può anche ritenere illogico tale comportamento dei lavoratori, tuttavia l’esperienza mostra che le cose stanno così. Inoltre non esiste alcuna evidenza che la disoccupazione che caratterizza i periodi di depressione sia causata dal rifiuto dei lavoratori di accettare una riduzione dei salari monetari; può aumentare la disoccupazione senza che si siano verificati cambiamenti nelle richieste dei lavoratori o nella produttività del lavoro. Anzi normalmente le richieste dei lavoratori vengono ridimensionate proprio nei periodi di depressione. Dunque se il comportamento effettivo dei lavoratori nella contrattazione salariale consente di dedurre che l’offerta di lavoro non è funzione unicamente del salario reale, il ragionamento dei classici non regge, perché il loro modello non permette di determinare la funzione di offerta di lavoro e quindi il livello effettivo dell’occupazione
Il secondo argomento che Keynes usa per confutare il modello classico si fonda sul fatto che i lavoratori non sono in grado di stabilire il salario reale che risulterà dalla contrattazione con gli imprenditori. Anche i classici ovviamente riconoscono che i contratti di lavoro vengono stipulati in termini monetari, ma ritengono che i lavoratori siano in grado di stabilire il salario reale che si determinerà con la contrattazione e da tale convinzione hanno dedotto che il mercato sia sempre in grado di determinare quel salario reale che corrisponde alla piena occupazione. Ma in realtà può non esistere alcun metodo con cui i lavoratori nel loro insieme, “mediante revisione dei contratti collettivi” possono portare i salari monetari a coincidere con quel livello di salario reale che risulta compatibile con la piena occupazione.
3.2 La teoria keynesiana dell’occupazione
In contrapposizione con l’approccio dei classici, Keynes sottolineò come nel capitalismo moderno mancassero gli automatismi capaci di generare la piena utilizzazione delle potenzialità produttive. Nell’approccio keynesiano, il sistema capitalistico è intrinsecamente instabile e, lasciato a se stesso, può dar luogo a crisi prolungate. “In essenza, la Teoria Generale costituisce un’analisi critica attorno all’effettiva capacità del sistema economico di assestarsi spontaneamente al livello di piena occupazione” . Si noti che in un certo senso il mercato del lavoro nella Teoria Generale viene tenuto in disparte, dato che il livello dell’occupazione non si spiega con la rigidità o insufficiente flessibilità salariale. Una teoria generale per Keynes deve comunque mantenere il suo carattere esplicativo indipendentemente dal grado di flessibilità salariale.
Le teorie dei classici erano basate sulla legge di Say, secondo cui l’offerta crea la propria domanda, “nel senso che il prezzo aggregato di domanda è uguale al prezzo aggregato di offerta per qualsiasi livello di produzione e di occupazione.” La legge di Say implica dunque che la domanda si adegua automaticamente all’offerta, qualsiasi sia il volume della produzione. Keynes rigetta l’idea che il livello di reddito sia sempre determinato dall’offerta e, in contrapposizione a tale visione pone al centro della sua riflessione teorica l’analisi della domanda. Nella visione di Keynes il livello dell’occupazione è determinato dalla domanda effettiva. Se le imprese non riescono a vendere tutto ciò che possono produrre, si genera disoccupazione causata dalla carenza di domanda di beni; si può dunque creare una situazione in cui vi sono lavoratori disposti a lavorare al salario corrente che non trovano lavoro a causa della carenza di domanda. Le aspettative degli imprenditori rivestono un ruolo fondamentale nella determinazione del livello di occupazione. Se la capacità produttiva non viene pienamente utilizzata perché gli imprenditori non si aspettano di vendere tutte le merci che sono in grado di produrre, si determina una situazione in cui il livello di attività è più basso di quello potenziale e c’è disoccupazione. La presenza di disoccupati e quindi di un livello minore di domanda genera a sua volta una riduzione del livello di attività economica e il sistema si può trovare a lungo intrappolato in una situazione di equilibrio di sottoccupazione. Non esistono meccanismi automatici per riportare il sistema alla piena occupazione. Una riduzione dei salari non è efficace in quanto la domanda di beni di consumo dipende dal reddito dei salariati E’ fondamentale in questo caso il ruolo della politica economica che, agendo sulla domanda aggregata, mette in moto il meccanismo del moltiplicatore.
Se per un dato valore dell’occupazione, gli imprenditori prevedono una domanda superiore all’offerta, avranno un incentivo ad aumentare l’occupazione fino al valore in cui la domanda uguaglia l’offerta. Ma non è detto che tale volume di occupazione corrisponda alla piena occupazione. Possono esserci lavoratori disoccupati, senza che esista un incentivo ad aumentare l’occupazione.
Per comprendere perché può verificarsi una situazione di equilibrio senza piena occupazione, dobbiamo concentrarci sulla funzione di domanda aggregata, che costituisce l’elemento chiave del suo schema teorico.
La decisione di impiegare una certa quantità di lavoro produce un reddito dalla cui spesa viene generata una domanda di beni di consumo da parte delle famiglie e di beni di investimento da parte delle imprese. Quando aumenta l’occupazione, aumenta anche il reddito reale complessivo. Il consumo tuttavia cresce proporzionalmente meno del reddito perché secondo una “legge psicologica fondamentale ….. di norma e in media, gli uomini sono disposti ad accrescere il loro consumo con l’aumentare del reddito, ma non tanto quanto l’aumento del reddito” . Dunque se gli imprenditori destinassero la nuova occupazione alla produzione di beni di consumo immediato subirebbero una perdita. In altri termini, se il reddito aumenta di ΔY, il consumo aumenta meno di ΔY e quindi per mantenere quel volume di occupazione una parte dell’incremento del reddito deve essere destinato agli investimenti; il volume degli investimenti aggiuntivi ΔI deve essere tale da assorbire la differenza fra l’incremento del reddito e l’incremento dei consumi. In mancanza di tale incremento degli investimenti gli imprenditori non ottengono i ricavi necessari ad indurli ad un incremento dell’occupazione. Perciò, data la propensione al consumo, il livello di equilibrio dell’occupazione dipende dall’investimento corrente, il quale a sua volta dipende dall’efficienza marginale del capitale e dal tasso di interesse. Esiste un solo livello di occupazione compatibile con l’equilibrio; solo in condizioni particolari tale livello risulta uguale alla piena occupazione.
“Quindi il volume dell’occupazione non è determinato dalla disutilità dell’occupazione misurata in termini di salari reali, salvo per il fatto che l’offerta di lavoro disponibile ad un dato salario reale pone un livello massimo dell’occupazione. Se la propensione al consumo e il flusso di nuovi investimenti sono tali da creare una domanda effettiva insufficiente, il livello relativo dell’occupazione non raggiungerà l’offerta di lavoro potenzialmente disponibile al salario reale vigente, e il salario reale di equilibrio sarà maggiore della disutilità marginale del livello di occupazione al punto di equilibrio.
Quest’analisi ci offre una spiegazione del paradosso della povertà in mezzo all’abbondanza: basta infatti un’insufficienza della domanda effettiva perché l’incremento dell’occupazione possa essere arrestato – e spesso lo sia – prima di raggiungere un livello di piena occupazione. L’insufficienza della domanda effettiva ostacolerà il processo della produzione, malgrado che il prodotto marginale del lavoro superi ancora in valore la disutilità marginale dell’occupazione
Si noti che i dati relativi al tasso di disoccupazione in Europa, Stati uniti e Giappone non sono perfettamente comparabili. In particolare, si deve tenere conto che negli Stati Uniti risulta particolarmente elevata la percentuale di lavoratori “intermittenti” e che le rilevazioni sulla forza lavoro vengono condotte telefonicamente e sono quindi meno attendibili. Altre osservazioni a questo proposito sono contenute in L. Gallino “Se tre milioni vi sembran pochi”, Einaudi, Torino 1998. Per quanto riguarda il Giappone, c’è una tendenza delle persone disoccupate a dichiararsi “non forza lavoro”, dato che la condizione di disoccupato viene considerata disdicevole.
Spesso si parla di paesi continentali dell’UE escludendo la Gran Bretagna, perché le caratteristiche del mercato del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali in Gran Bretagna stanno progressivamente avvicinandosi a quelle degli Stati Uniti, tanto è vero che spesso si parla di modello anglosassone in contrapposizione al modello europeo. E’ importante ricordare che quando si contrappone il modello americano a quello dell’Europa continentale, si trascurano importanti distinzioni che riguardano i modelli nazionali, su cui torneremo più avanti.
Nel marzo 1979 l’Italia aderì allo SME; la lira fu svalutata più volte nel corso degli anni ottanta, ma dal 1987 si decise di mantenere stabile il tasso di cambio nominale, determinando una crescente sopravalutazione del cambio reale che ha provocato un deterioramento delle nostre ragioni di scambio. Nel 1992 l’Italia dovette uscire dallo SME a causa delle crescenti difficoltà della nostra moneta e dell’ondata speculativa sulla lira.
La UEM include tutti i paesi che hanno adottato l’euro e cioè: Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia.
Keynes definì l’opera di Pigou “l’unica esposizione particolareggiata della teoria classica dell’occupazione” (J. M. Keynes Teoria generale cit. pag.191)
Cfr. l’ottima analisi di M. Zenezini “La disoccupazione immaginata” , Rosenberg & Sellier, Torino, 1997, pag. 12-14
Il moltiplicatore keynesiano è il principio secondo il quale una variazione della componente autonoma della domanda (cioè non dipendente dal reddito) produce una variazione più che proporzionale del reddito.
Efficienza marginale del capitale è quel tasso di interesse che permette di uguagliare il valore attuale, cioè stimato al tempo presente, dei rendimenti netti di un investimento in beni capitali al costo dell’investimento stesso. Secondo Keynes, ogni impresa attua i progetti di investimento che presentano un rendimento superiore al tasso di interesse di mercato; altrimenti trova più conveniente offrire a prestito i suoi fondi; l’efficienza marginale del capitale decresce al crescere del volume degli investimenti effettuati sia perché si riducono i rendimenti attesi, sia perché l’aumento della domanda di beni capitali ne fa crescere il prezzo di offerta.
Ma vi è di peggio. Non soltanto la propensione marginale al consumo è più debole in una collettività ricca, ma, siccome il capitale accumulato è maggiore, vi saranno possibilità meno attraenti di investimenti ulteriori, a meno che il tasso di interessa discenda abbastanza rapidamente, la qual cosa ci conduce alla teoria di interesse e alle ragioni per cui esso non discende automaticamente. ”
L’influenza dei salari sull’occupazione
Nell’analisi di Keynes il livello dei salari reali generalmente non determina l’occupazione, ma caso mai ne è il risultato. Keynes non ha mai sostenuto che i salari reali o monetari siano rigidi, idea che peraltro gli è stata spesso attribuita, né ha mai affermato che la disoccupazione dipende dalla rigidità salariale . Anzi va detto che Keynes rifiuta l’idea degli economisti classici, secondo cui una diminuzione dei salari provoca un aumento dell’occupazione, sostenendo che questi hanno impropriamente trasferito l’analisi del comportamento della singola impresa all’analisi del sistema economico nel suo complesso. Una diminuzione dei salari in una singola impresa o anche in un particolare settore causa un aumento della domanda di lavoro, poiché provoca una diminuzione dei costi, ma ciò dipende dal fatto che l’influenza della diminuzione dei salari in una singola impresa o settore ha un’influenza minima o nulla sulla domanda del prodotto dell’impresa o del settore considerato. Una diminuzione generalizzata dei salari richiede un’analisi diversa: un calo di tutti i salari può infatti provocare un calo della domanda aggregata e perciò dell’occupazione.
Keynes ha analizzato gli effetti di una riduzione del salario monetario ed è giunto alla conclusione che tale riduzione può avere un effetto positivo sull’occupazione, come sostenevano gli economisti classici, solo a condizione che non diminuisca la domanda aggregata espressa in termini monetari, ovvero che questa diminuisca in misura meno che proporzionale rispetto alla riduzione dei salari, il che sottintende un aumento della domanda aggregata espressa in unità di salario, cioè in numero di occupati.
E’ utile a questo punto considerare alcuni fra i principali effetti evidenziati da Keynes di una riduzione dei salari sulla domanda, che peraltro “offrono un saggio della problematicità di Keynes nell’affrontare una questione che la successiva interpretazione keynesiana ha analizzato quasi sempre in modo schematico e riduttivo” .
- Una riduzione dei salari reali comporta una redistribuzione del reddito a danno dei lavoratori, che hanno una più alta propensione al consumo e a favore delle classi che hanno una minore propensione al consumo; dunque la riduzione dei salari comporterebbe una riduzione della domanda aggregata e perciò dell’occupazione.
- Una diminuzione dei salari e la conseguente riduzione dei costi può migliorare la competitività del paese e quindi può favorire una espansione della domanda aggregata, compensando l’effetto negativo sui consumi. Tale effetto positivo sulla domanda può essere realizzato solo se all’estero non si verifica un processo analogo di riduzione salariale e naturalmente dipende dal grado di apertura commerciale dell’economia.
- E’ necessario valutare l’effetto sulle aspettative che comporta una diminuzione dei salari: se le aspettative sono di un’ulteriore riduzione si avrà un effetto depressivo sulla domanda, se viceversa le aspettative sono di un ritorno alla crescita salariale l’effetto sulla domanda sarà espansivo.
In ogni caso gli effetti di variazioni dei salari, sia reali che monetari, sono indiretti, complessi e contradditori; diventa dunque problematico ritenere che tali variazioni abbiano la capacità di portare all’equilibrio del mercato del lavoro. Il livello dell’occupazione non può dunque essere determinato in linea di principio dal livello dei salari; è la domanda globale a determinare l’occupazione.
Ma poiché la domanda globale in un sistema capitalistico è intrinsecamente instabile, dato che è influenzata da forze contrastanti, anche l’occupazione è instabile. La disoccupazione sorge dunque a causa degli squilibri che caratterizzano l’economia di mercato e, pur essendo un fenomeno che riguarda il mercato del lavoro, non è generata dal suo funzionamento. Da queste constatazioni deriva la necessità dell’intervento pubblico per raggiungere il pieno utilizzo delle potenzialità produttive del sistema. Dunque emerge l’importanza di politiche economiche, fiscali e monetarie, per portare il sistema all’equilibrio di piena occupazione.
3.6 Alcune considerazioni sulla teoria keynesiana
L’opera di Keynes è profondamente influenzata dai problemi concreti che hanno caratterizzato il suo periodo storico. Senza dubbio la prolungata recessione e l’elevata disoccupazione degli anni trenta hanno segnato le teorie e le riflessioni di Keynes. Oggi tuttavia si tende troppo spesso ad insistere su questo aspetto e da più parti si considera come “datata” la sua teoria. E’ mia opinione, viceversa, che l’ossatura teorica e gli strumenti di analisi contenuti nella Teoria Generale costituiscano ancora oggi un punto di riferimento essenziale per la comprensione del funzionamento del sistema economico e per l’elaborazione della politica economica.
Nel quarto di secolo che ha seguito la fine della seconda guerra mondiale l’insegnamento keynesiano è stato recepito dai governi dei paesi occidentali e le politiche economiche volte a stimolare la domanda aggregata nei periodi di disoccupazione crescente hanno permesso una crescita sostenuta dell’economia Molti paesi hanno conosciuto una lunga fase caratterizzata dalla piena occupazione e dalla diminuzione delle disuguaglianze. In quel periodo, come sottolinea Cozzi nella sua introduzione alla Teoria Generale,“gli si riconosceva, quasi universalmente, il merito di aver insegnato il modo di regolare l’economia così da esorcizzare lo spettro della disoccupazione di massa garantendo condizioni di crescita sostenuta e di relativa stabilità dei prezzi”. Ma negli anni settanta il rallentamento nel tasso di crescita delle economie occidentali e l’aumento dell’inflazione e, successivamente, la crescita del tasso di disoccupazione hanno portato a un crescente rifiuto delle teorie keynesiane e da più parti si è addossata alle politiche keynesiane la colpa di tutti i mali che affliggevano le economie. L’ortodossia classica, messa in disparte per lungo tempo dalla maggior parte degli economisti è tornata in auge ed i suoi dettami sono stati presi a modello da numerosi politici. I risultati non sono certo stati brillanti, la disoccupazione ha continuato a crescere quasi ovunque e sono aumentate povertà e disuguaglianze all’interno dei paesi. Secondo alcuni la performance negativa delle economie dipende dal fatto che non si sono perseguite politiche sufficientemente liberiste E’ mia opinione invece che l’abbandono delle politiche keynesiane abbia provocato gravi problemi all’economia e, in particolare, che la disoccupazione di massa che affligge i principali paesi europei da circa vent’anni richiederebbe un ripensamento delle politiche e una riflessione sugli insegnamenti keynesiani. Nel mondo contemporaneo si stanno infatti verificando fenomeni non molto diversi da quelli che caratterizzarono gli anni Venti e Trenta e che certamente ispirarono l’opera keynesiana: ristagno, disoccupazione, squilibri finanziari.
Un insegnamento essenziale che emerge dall’opera di Keynes è che crisi e fluttuazioni sono il risultato del funzionamento di un’economia capitalistica, e che l’occupazione può assestarsi per lunghi periodi su livelli ben lontani dal pieno impiego, per cui solo l’intervento pubblico può attenuare gli elementi di instabilità del sistema capitalistico e permettere una distribuzione più equa delle risorse.
Capitolo 4
Dalla sintesi neoclassica alla curva di Phillips
La teoria keynesiana è stata è stata oggetto di numerose interpretazioni, che spesso hanno finito per snaturare il suo aspetto rivoluzionario. I tratti fondamentali della teoria keynesiana, infatti, sono stati progressivamente incorporati nell’ambito del pensiero neoclassico nel tentativo di conciliare l’approccio di Keynes con l‘impostazione teorica classica. L’interpretazione più nota della teoria keynesiana in un’ottica riconciliatrice con la teoria neoclassica è quello di Hicks , che fin dal 1937 iniziò ad interpretare la teoria di Keynes nel quadro della teoria dell’equilibrio economico generale di Walras. Ad esso seguirono numerosi contributi, fra cui particolare rilievo assumono quelli di Modigliani (1944) e Patinkin (1965). Non è questa la sede per discutere se e in quale misura la sintesi neoclassica costituisca un’interpretazione del pensiero keynesiano. Secondo gli economisti della sintesi si tratta dell’interpretazione del pensiero di Keynes, secondo altri ne tradisce lo spirito e la sostanza.
4.1 La sintesi neoclassica
La più nota formulazione della sintesi neoclassica è quella del modello IS-LM, oggetto nel tempo di numerose rielaborazioni e ancora oggi proposto dalla maggior parte dei manuali di macroeconomia. Nel modello IS-LM e nei suoi successivi sviluppi, il mercato del lavoro non ha un ruolo centrale, ma ha un ruolo passivo; il livello dell’occupazione è determinato, infatti, dall’equilibrio simultaneo del mercato della moneta e del mercato dei beni e servizi. La combinazione di tasso di interesse e reddito che determina tale equilibrio (cioè il punto di incontro fra IS e LM) non garantisce affatto che il mercato del lavoro si trovi in equilibrio, ovvero che al salario reale vigente la domanda di lavoro sia uguale all’offerta. Può esserci disoccupazione e non esistono meccanismi automatici che portano in equilibrio il mercato del lavoro. In altri termini, si può creare una situazione di “equilibrio con disoccupazione”, anche se formalmente si tratta di una situazione di squilibrio, dato che l’offerta di lavoro è superiore alla domanda. Il mercato del lavoro non si comporta quindi come un qualsiasi mercato concorrenziale in cui se vi è eccesso di offerta di un bene, il suo prezzo tende a calare finché non si realizza l’incontro fra domanda e offerta. Sul mercato del lavoro può esserci un eccesso di offerta (disoccupazione) che non produce automatismi diretti ad eliminarla; ciò avviene perché i disoccupati non premono per far scendere i salari.
Vediamo come può crearsi una situazione di equilibrio di sottoccupazione. Partendo da una situazione di equilibrio di piena occupazione, uno shock esogeno può causare un peggioramento delle aspettative degli imprenditori e quindi una diminuzione del rendimento atteso degli investimenti. Diminuisce quindi la domanda di investimenti e, di conseguenza, la domanda aggregata. Diminuisce dunque la produzione e l’occupazione, mentre i salari monetari rimangono stabili. Se anche i prezzi rimangono stabili, permane una situazione di disoccupazione. L’aggiustamento verso l’equilibrio di piena occupazione può avvenire tramite politiche fiscali, che influenzano direttamente la domanda aggregata, o variazioni dell’offerta di moneta, che incidono sul livello dei prezzi e sui salari reali (nonché sulla domanda attraverso variazioni del tasso di interesse), ma non si tratta aggiustamenti automatici.
Per quanto riguarda il problema della disoccupazione questo approccio diverge dalla teoria keynesiana perché individua la causa della disoccupazione nella rigidità dei prezzi, mentre per Keynes la causa principale della disoccupazione è la carenza di domanda aggregata. Nel modello della sintesi neoclassica dunque la sottoccupazione appare un fenomeno transitorio, perché nel lungo periodo prezzi e salari si aggiustano per riportare il sistema al pieno impiego; viceversa per Keynes la sottoccupazione è un fenomeno normale, perché non esistono meccanismi automatici in grado di riportare il sistema in una condizione di pieno impiego.
I tentativi di dare un fondamento all’ipotesi di rigidità salariali nel breve periodo, iniziati negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione della Teoria Generale e proseguiti fino ai giorni nostri, si basano su vari elementi, fra cui possiamo citare: la prevalenza di mercati non concorrenziali, le politiche di prezzo perseguite dalle grandi imprese, i costi delle continue variazioni di prezzo. Esamineremo in dettaglio le diverse spiegazioni delle rigidità salariali nel capitolo 6.
4.2 La curva di Phillips
Il modello della sintesi neoclassica costituisce uno schema interpretativo in situazione di prezzi fissi. Per quanto sia stato esteso e modificato per tenere conto delle conseguenze sull’equilibrio macroeconomico delle variazioni di prezzi e salari, non costituisce certo un modello utilizzabile per interpretare il fenomeno dell’inflazione. Probabilmente questo suo limite ha fatto sì che negli anni sessanta sia stata accolta con grande interesse la curva di Phillips che, evidenziando l’esistenza di una relazione inversa fra tasso di variazione dei salari monetari (e dei prezzi) e tasso di disoccupazione, sembrava inserire l’anello mancante dell’apparato teorico keynesiano.
Nel 1958 Phillips pubblicò un articolo in cui analizzava empiricamente la relazione fra variazione percentuale dei salari monetari e tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel periodo 1861-1957, in cui risultava una correlazione negativa non lineare fra tasso di crescita dei salari monetari e tasso di disoccupazione. Tale relazione risultava molto stabile anche nel lungo periodo.
Se indichiamo sull’asse delle ordinate la variazione dei salari monetari Δw/w e sull’asse delle ascisse il tasso di disoccupazione u, i punti che raffiguravano la situazione individuata nei diversi anni si collocano in prossimità di una curva inclinata negativamente che ha la forma illustrata nella figura 4.1
L’interesse per l’articolo di Phillips dipese non tanto dalla relazione individuata, che peraltro era già stata evidenziata a livello teorico ed era emersa in altre ricerche empiriche , quanto dalla stabilità di tale relazione nel lungo periodo, anche in presenza di cambiamenti economici rilevanti. Ricordiamo a questo proposito che la ricerca di Phillips ha coperto un arco di tempo di circa un secolo (1861-1957). Peraltro dopo la pubblicazione dell’articolo di Phillips, altre ricerche empiriche evidenziarono che la relazione messa in luce da Phillips per la Gran Bretagna risultava valida anche per gli Stati Uniti e per altri paesi.
Figura 4.1 La curva di Phillips
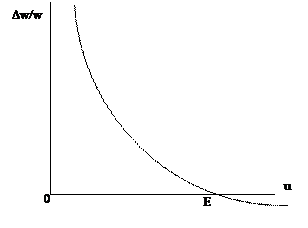
4.3 Le implicazioni della curva di Phillips
Dinamica salariale e tasso di inflazione sono strettamente correlati. Samuelson e Solow , dunque, suggerirono l’idea di interpretare i risultati evidenziati da Phillips come una relazione fra inflazione e disoccupazione, basandosi sull’ipotesi che il tasso di inflazione è pari al tasso di aumento dei salari monetari meno il tasso di aumento della produttività del lavoro. Ne risulta una curva che mantiene la stessa forma, ma traslata verso sinistra; la distanza in verticale fra le due curve è data dal tasso di variazione della produttività del lavoro.
La curva di Phillips considerata come trade-off fra inflazione e disoccupazione sembra aver individuato il passaggio che consente di completare la costruzione keynesiana e diventa perciò parte integrante del modello macroeconomico keynesiano. Nel modello keynesiano una crescita della domanda aggregata provoca un aumento del prodotto e, di conseguenza, dell’occupazione, secondo la curva di Phillips l’incremento dell’occupazione a sua volta genera inflazione salariale.
La relazione fra inflazione e disoccupazione sembrava dunque suggerire ai responsabili della politica economica la possibilità di scegliere fra le diverse combinazioni dei due grandi mali di cui può soffrire l’economia, cioè disoccupazione e inflazione. In pratica, si ritenne che una nazione avrebbe potuto garantire una disoccupazione minima se disposta a pagare il prezzo di un’inflazione più elevata o viceversa avrebbe potuto raggiungere un tasso di inflazione nullo a spese di un elevato tasso di disoccupazione. Una volta individuata la combinazione preferita di tasso di inflazione e tasso di disoccupazione, il compito dei responsabili di politica economica sarebbe stato quello di fissare i parametri fiscali e monetari tali da garantire il livello della domanda aggregata che avrebbe consentito di ottenere il mix di inflazione e disoccupazione desiderati.
Si diffuse così l’opinione che le scelte di politica economica dovessero basarsi sulla curva di Phillips e si affermò la convinzione che i governi di sinistra avrebbero privilegiato un basso tasso di disoccupazione, perché volti a proteggere le classi deboli, mentre i governi di destra avrebbe optato per un basso tasso di inflazione, perché l’inflazione danneggia i risparmiatori. Si tratta in realtà di una visione abbastanza schematica. Nella letteratura sul ciclo economico elettorale si è evidenziato infatti che, in prossimità delle elezioni, i governi sia di destra che di sinistra tendono a perseguire politiche espansive volte a ridurre la disoccupazione.
Se è vero, come emerge dall’interpretazione prevalente della relazione di Phillips, che il livello dei salari in ogni dato momento dipende dalla legge della domanda e dell’offerta, i sindacati e i movimenti dei lavoratori non avrebbero alcun ruolo nel determinare il livello dei salari. Si avrebbe così “una sorta di riaffermazione del primato dell’economia (sulla politica)“ . L’unica via per contenere l’inflazione salariale sarebbe dunque un contenimento della domanda effettiva e quindi dell’occupazione.
4.5 La validità empirica della curva di Phillips
Per circa un decennio dopo la pubblicazione dell’articolo di Phillips, l’ipotesi di un trade-off fra inflazione e disoccupazione sembrò funzionare senza problemi. Viceversa dall’inizio degli anni settanta la curva di Phillips si dimostrò incapace di interpretare la crescita simultanea di inflazione e disoccupazione che si verificò praticamente in tutto il mondo industrializzato a partire dal 1973 in seguito alla prima crisi petrolifera. Apparve chiaro a quel punto che l’aumento dei salari era generato dall’aumento dei prezzi e non dal calo della disoccupazione, dato che a fronte di un’inflazione crescente il numero dei disoccupati era in aumento.
E’ interessante notare, comunque, che prima che gli shock petroliferi mettessero in evidenza i limiti della curva di Phillips, la sua validità era già stata contestata, verso la fine degli anni sessanta dagli economisti Friedman e Phelps. Nel prossimo capitolo esamineremo la critica di Friedman e Phelps.
Il trade-off fra inflazione e disoccupazione in Italia negli anni sessanta
Abbiamo visto che una serie di ricerche empiriche che hanno seguito la pubblicazione dell’articolo di Phillips hanno evidenziato la validità della relazione individuata da Phillips anche in altri paesi. La curva di Phillips ha trovato conferma anche nella situazione italiana degli anni sessanta. Uno studio di Onofri e Salituro mette in evidenza come il trade-off fra inflazione e disoccupazione in tale periodo sia conforme con la relazione di Phillips; nei primi anni sessanta, la crescita economica sostenuta portò a un netto calo della disoccupazione, che scese dal 5,7% del 1960 al 3,9 del 1963 e fu accompagnata da una brusca impennata dell’inflazione, che passò dall’1,3 al 6,7%. Le politiche deflazionistiche che seguirono portarono a una netta riduzione dell’inflazione, che scese a valori intorno al 2,5% nella seconda metà degli anni sessanta, mentre il tasso di disoccupazione si assestò fra il 5,4 e il 5,9%. Nell’ottica della curva di Phillips, dunque, la crescita della disoccupazione sembrò il prezzo invitabile per frenare l’inflazione, così come l’aumento del tasso di inflazione parve la conseguenza necessaria di un aumento dell’occupazione.
Ma negli anni settanta, anche in Italia, come negli altri paesi industrializzati, è venuta meno la validità della curva di Phillips; si è verificata infatti una crescita simultanea di inflazione e disoccupazione.
Capitolo 5
La teoria monetarista e la nuova macroeconomia classica
In questo capitolo esamineremo sinteticamente le teorie sul mercato del lavoro dei monetaristi e dei teorici della nuova macroeconomia classica. Si tratta di importanti sviluppi della teoria economica proposti a partire dalla fine degli anni sessanta che fanno riferimento alle teorie pre-keynesiane.
Il successo che tali modelli hanno riscosso a livello teorico è in larga misura dovuto alla sfiducia rispetto alle teorie di stampo keynesiano, che si sono rivelate inadeguate a spiegare il fenomeno della stagflazione degli anni settanta.
Tali modelli costituiscono il riferimento teorico per le politiche economiche di stampo liberista che hanno conquistato uno spazio crescente a partire dagli anni ottanta, a causa delle difficoltà incontrate dai governi nella gestione di politiche economiche di stabilizzazione.
5.1 Le ipotesi di Friedman
Alla fine degli anni sessanta, quando ancora la curva di Phillips sembrava interpretare correttamente la realtà, si sviluppò la critica monetarista con i contributi teorici di Friedman e Phelps , che misero in discussione la validità della curva di Phillips nel lungo periodo. Essi sostennero infatti che il trade-off fra inflazione e disoccupazione non può essere che temporaneo e sottolinearono l’importanza delle aspettative di inflazione nella determinazione dei salari monetari. Secondo Friedman e Phelps il tasso di disoccupazione è correlato solo con l’inflazione non anticipata e non con il tasso di inflazione complessivo, come emergeva nella relazione originale individuata da Phillips. Quest’ultimo avrebbe infatti commesso l’errore di mettere in relazione una grandezza reale (il tasso di disoccupazione) e una grandezza nominale (il tasso di variazione dei salari monetari) ottenendo risultati che possono essere accettabili solo in un’analisi di breve periodo, ma non possono essere validi nel lungo periodo.
Il modello di Friedman si fonda sull’analisi del modello classico e sull’ipotesi di comportamenti ottimizzanti degli agenti. Le imprese operano in concorrenza perfetta e producono la quantità che consente loro di massimizzare il profitto.
Le imprese assumono lavoratori fino al punto in cui il prodotto marginale del lavoro è uguale al salario reale. La curva di domanda di lavoro coincide dunque con la curva del prodotto marginale del lavoro. Il prodotto marginale del lavoro diminuisce al crescere della quantità di lavoro impiegata. La curva di domanda di lavoro risulta dunque inclinata negativamente.
La funzione dell’offerta di lavoro si basa sul trade-off fra salario e tempo libero. Gli individui, all’interno di un dato periodo, possono scegliere fra consumo e tempo libero. Per accrescere i propri consumi gli individui devono lavorare di più, se intendono accrescere il tempo libero dovranno rinunciare a una parte dei loro consumi. Se aumenta il salario reale, gli individui saranno indotti a rinunciare a una parte del tempo libero. Quindi la curva di offerta di lavoro è inclinata positivamente.
Attraverso l’intersezione delle curve di domanda e offerta di lavoro si ottengono salario reale e occupazione di equilibrio. Il mercato del lavoro tende verso una posizione di equilibrio stabile e non esiste disoccupazione involontaria, nel senso che non esistono lavoratori disoccupati che sarebbero disposti a lavorare per un salario pari o inferiore a quello di equilibrio.
Il modello monetarista parte infatti dalle ipotesi del modello classico secondo cui i salari sono flessibili e si aggiustano per portare l’equilibrio fra domanda e offerta di lavoro. In questo contesto non può esistere la disoccupazione involontaria. Secondo i monetaristi la volontarietà della disoccupazione può avere varie cause: può dipendere dalla preferenza degli individui di dedicarsi all’attività di ricerca di lavoro piuttosto che accettare un impiego qualsiasi, può essere determinata dalla ricerca di lavoro, cioè dai continui flussi di entrata e uscita dai posti di lavoro, può essere causata dalla volontà di certi individui di dichiararsi disoccupati per ottenere il sussidio di disoccupazione
5.2 Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips
La critica monetarista alla curva di Phillips può essere illustrata partendo dal concetto di tasso naturale di disoccupazione che è il tasso di disoccupazione che si registra nell’economia quando vi è un sostanziale equilibrio fra domanda e offerta di lavoro, ovvero i posti di lavoro disponibili sono uguali al numero di lavoratori disoccupati e non esiste disoccupazione di tipo involontario. La disoccupazione esistente in corrispondenza del tasso naturale è disoccupazione volontaria. Il fatto che il tasso naturale di disoccupazione non sia nullo dipende dunque dalle frizioni esistenti sul mercato del lavoro e dalla ricerca da parte dei lavoratori di migliori opportunità occupazionali, in condizioni di informazione incompleta.
Il tasso naturale di disoccupazione è un fenomeno reale, che non può subire l’influenza di fenomeni di carattere monetario, come le variazioni dell’offerta di moneta. Friedman riprende l’ipotesi della teoria quantitativa della moneta secondo cui l’aumento dell’offerta di moneta ha un effetto solo sul livello dei prezzi e non sulle variabili reali e sostiene la validità di tale teoria nel lungo periodo.
Nel lungo periodo i mercati sono in equilibrio e lo è anche il mercato del lavoro, proprio come nell’analisi classica. Il tasso di disoccupazione di lungo periodo corrisponde dunque al tasso naturale. Nel lungo periodo, dunque, la curva di Phillips è verticale o, in altre parole, nel lungo periodo il tasso di disoccupazione è il tasso naturale, indipendentemente dal tasso di inflazione.
Nel breve periodo il sistema economico può invece allontanarsi dall’equilibrio. Quando il tasso di disoccupazione è al suo livello naturale, il tasso di inflazione risulta stabile. Se la disoccupazione è superiore a quella naturale, il tasso di inflazione tende a diminuire e viceversa.
Vediamo con un esempio perché ciò accade.
Si supponga che, grazie a una politica economica espansiva, aumenti la domanda aggregata e, come conseguenza, aumenti il livello dei prezzi e dei salari nominali. Finché i lavoratori non realizzano che è aumentato il livello generale dei prezzi, sono convinti che siano aumentati i salari reali e sono quindi disponibili a offrire più lavoro; il tasso di disoccupazione scende al di sotto del tasso naturale. A loro volta i datori di lavoro, finché non si rendono conto che è aumentato il livello generale dei prezzi, sono convinti che l’aumento del prezzo dei loro prodotti dipenda da una variazione a loro favore dei prezzi relativi e saranno quindi propensi ad aumentare l’offerta dei loro prodotti e quindi ad assumere nuovi lavoratori. Si ha quindi nel breve periodo il trade-off fra inflazione e disoccupazione evidenziato da Phillips. Ma tale situazione non può essere permanente. Col tempo i lavoratori si accorgeranno di essersi ingannati, e diminuirà l’offerta di lavoro e il tasso di disoccupazione tornerà al livello naturale. Parimenti dovrebbe ridursi l’offerta delle imprese e il PIL dovrebbe tornare al livello di piena occupazione e la disoccupazione al suo tasso naturale, indipendentemente dal tasso di inflazione.
Ecco spiegati i motivi della verticalità della curva di Phillips nel lungo periodo.
Nel breve periodo invece il tasso di disoccupazione dipende dalle aspettative.
Friedman suppone l’esistenza di aspettative adattive, cioè adattate ai valori passati di riferimento. Se c’è un’aspettativa di inflazione, per esempio del 5%, perché in passato il tasso di inflazione era del 5%, un aumento dei salari monetari del 5% non provocherà alcun calo del tasso di disoccupazione, che rimarrà quindi al suo livello naturale. Un aumento dei prezzi oltre il 5% accompagnato da un pari aumento dei salari monetari comporterà invece un aumento dell’offerta di lavoro, perché i lavoratori non si rendono conto che il loro salario reale è rimasto immutato.
Perciò non si può parlare di un’unica curva di Phillips, ma di un fascio di curve di Phillips, una per ogni livello dell’inflazione attesa. Se, ad esempio, il tasso di inflazione è costantemente positivo, come è successo quasi ovunque a partire dagli anni sessanta, questo viene incorporato nelle aspettative e non ha alcun effetto sul tasso di disoccupazione.
Se il governo attua una misura di politica economica finalizzata ad aumentare la domanda aggregata al di sopra del livello di piena occupazione, i prezzi aumentano, perché la domanda supera il livello di produzione iniziale. Si supponga che il tasso di inflazione passi dallo 0 al 3%. L’aumento del livello dei prezzi provoca una riduzione del salario reale. La caduta del salario reale porta le imprese ad assumere un maggior numero di lavoratori. I lavoratori saranno indotti ad offrire una maggior quantità di lavoro solo se sono convinti che il salario reale aumenti, mentre le imprese saranno disposte ad assumere nuovi lavoratori solo se l’aumento dei salari monetari risulta inferiore all’aumento del livello dei prezzi, cioè nel nostro caso al 3%. Cosa accadrà a questo punto? Supponiamo che le imprese offrano aumenti dei salari monetari dell’1%. I lavoratori non conoscono il reale andamento dell’inflazione e prendono le decisioni sulla quantità di lavoro da offrire in base al salario reale atteso. Il salario reale atteso è dato dal rapporto fra salario monetario e livello dei prezzi attesi; dato che non si rendono conto che il livello dei prezzi è aumentato, utilizzano il livello del prezzi del periodo precedente per formare le loro aspettative sul livello dei prezzi nel periodo corrente. Si convincono perciò che siano aumentati i salari reali e offrono dunque più lavoro. Nel periodo successivo i lavoratori rivedono le loro aspettative inflazionistiche: se il tasso di inflazione è stato pari al 3%, il tasso di disoccupazione tornerà al suo livello naturale se prezzi e salari aumentano entrambe del 3%. In tal caso il sistema economico tornerà al livello di piena occupazione, ma l’economia sarà caratterizzata da una nuova curva di Phillips. Se il governo vuole far calare il tasso di disoccupazione dovrà dare un nuovo impulso alla domanda aggregata provocando nuovi aumenti del livello dei prezzi. Di nuovo nel periodo successivo muteranno le attese inflazionistiche e si avrà un ulteriore spostamento verso l’alto della curva di Phillips.
Si ottiene così un fascio di curve di Phillips, una per ogni livello di inflazione attesa.
In conclusione, solo se il tasso di disoccupazione si mantiene al suo livello naturale, il tasso di inflazione rimane costante. Se invece il tasso di inflazione è superiore al tasso di inflazione atteso, il tasso di disoccupazione scende sotto il suo livello naturale e il tasso di inflazione tende ad aumentare. Viceversa quando il tasso di inflazione è inferiore al suo livello atteso, il tasso di disoccupazione è superiore al tasso naturale e il tasso di inflazione tende a diminuire.
Dunque nel modello di Friedman il trade-off fra inflazione e disoccupazione esiste solo nel breve periodo. Quando varia il tasso di inflazione atteso la curva di Phillips si sposta. Nel lungo periodo invece la curva di Phillips è verticale, perché non esiste alcun trade-off fra inflazione e disoccupazione.
5.4 L’ipotesi del tasso naturale di disoccupazione
Secondo la tradizionale visione dei “classici” il mercato del lavoro non si comporta diversamente da un qualsiasi mercato, in quanto il lavoro viene considerato una merce come le altre. Al pari degli altri mercati, il mercato del lavoro è regolato dalla legge della domanda e dell’offerta. Se in un qualsiasi mercato parte della merce prodotta rimane invenduta, ciò significa che il suo prezzo è troppo elevato e che l’eccesso di offerta verrà eliminato grazie alla riduzione del prezzo; viceversa un eccesso di domanda rispetto alla produzione comporta un aumento del prezzo. La legge della domanda e dell’offerta opera nello stesso modo anche nel mercato del lavoro. Un eccesso di offerta di lavoro causa la diminuzione delle retribuzioni e un eccesso di domanda ne provoca l’aumento. Il mercato del lavoro tende dunque verso un equilibrio stabile e la disoccupazione non può che essere volontaria. La stabilità dell’equilibrio implica al massimo la presenza di disoccupazione frizionale. Secondo questa visione la presenza di disoccupazione involontaria non può che dipendere da fattori che ostacolano il funzionamento corretto della libera concorrenza e il tasso di disoccupazione tende comunque nel lungo periodo al suo valore “naturale”
L’idea dell’esistenza di un tasso naturale di disoccupazione costituisce uno dei punti più deboli del monetarismo. L’esperienza dei paesi industrializzati nel dopoguerra appare in aperta contraddizione con l’idea del tasso naturale. Il tasso di disoccupazione, infatti, è costantemente cresciuto per oltre un quarto di secolo a partire dagli anni settanta nella maggior parte delle economie industrializzate, in particolare nei paesi europei, e non sembrano essersi verificate tendenze riequilibratici. Appare perciò problematico attribuire la crescente disoccupazione che ha caratterizzato le economie dei paesi europei negli ultimi trent’anni a temporanee frizioni esistenti nel mercato del lavoro. L’analisi neoclassica, tuttavia, a partire dai contributi di Friedman e Phelps, ha tentato di recuperare l’idea di “tasso naturale” attraverso un’opera di ricostruzione della macroeconomia sulla base dei fondamenti microeconomici, che permetterebbero di considerare in una diversa ottica il concetto stesso di offerta di lavoro e di piena occupazione. L’offerta di lavoro nell’analisi tradizionale dipende dalle tendenze demografiche di lungo periodo; nelle teorie che fanno riferimento all’ipotesi del tasso naturale, l’offerta di lavoro dipende dal comportamento dei singoli individui che possono scegliere se restare o ritirarsi temporaneamente dal mercato del lavoro. In quest’ottica la disoccupazione è solo volontaria i disoccupati sono individui che razionalmente scelgono di ritirarsi dal mercato del lavoro
5.5 Gli sviluppi della Nuova Macroeconomia Classica
La nuova macroeconomia classica (NMC) si sviluppa negli anni settanta; la prima formulazione di tale scuola di pensiero viene fatta risalire ai contributi di Robert Lucas del 1972 e del 1973 . La NMC si richiama esplicitamente all’approccio dei monetaristi integrandolo con tre ipotesi essenziali:
- gli operatori formano razionalmente le loro aspettative, sfruttando tutte le informazioni disponibili ;
- i prezzi e i salari sono perfettamente flessibili e i mercati tendono continuamente verso condizioni di equilibrio, anche nel breve periodo;
- la funzione dell’offerta di lavoro dipende dal trade-off fra tempo libero corrente e tempo libero futuro.
Queste ipotesi hanno importanti implicazioni. Ci limiteremo in questa sede a considerare le conseguenze di queste ipotesi sull’analisi del mercato del lavoro.
Consideriamo in primo luogo l’ipotesi di aspettative razionali.
Nel modello di Friedman le aspettative sono adattive e quindi l’andamento dei salari presenta sempre un certo ritardo rispetto alla dinamica dei prezzi, per cui viene ipotizzata la presenza di un trade-off fra inflazione e disoccupazione almeno finché gli agenti non si accorgono degli errori di aspettativa e la correggono. In un contesto di aspettative razionali, in cui gli agenti utilizzano tutte le informazioni in loro possesso per formare le loro previsioni, non c’è spazio per errori sistematici. Non c’ è motivo dunque per pensare che gli agenti non siano in grado di valutare l’andamento del tasso di inflazione e che vengano sistematicamente tratti in inganno. I teorici della NMC sono peraltro convinti che non esista un’asimmetria informativa fra i cittadini e le autorità di politica economica. Se le autorità di politica economica attuano una politica espansiva, gli agenti si rendono conto che questa provocherà un aumento nel livello dei prezzi e questo viene quindi incorporato nelle aspettative. Ciò implica che non esiste un trade-off fra tasso di inflazione e tasso di disoccupazione, neppure nel breve periodo. Le autorità di politica economica infatti non sono in grado di determinare alcun divario fra aspettative di inflazione e inflazione effettiva e quindi non sono in grado di portare il tasso di disoccupazione al di sotto del tasso naturale. Solo nel caso di una variazione imprevista della domanda si può realizzare una situazione di breve periodo come quella delineata nel modello di Friedman, cioè può esserci temporaneamente una discrepanza fra tasso di inflazione atteso e tasso di inflazione effettivo e quindi uno scostamento temporaneo del tasso di disoccupazione da quello naturale. Ma non può trattarsi che di una situazione temporanea determinata dall’effetto “sorpresa”, che svanisce non appena vengono riviste le aspettative. Dunque solo nel caso di una variazione imprevista della domanda si può ipotizzare l’esistenza di una curva di Phillips inclinata negativamente nel breve periodo. Altrimenti, secondo i teorici della NMC, applicando le aspettative razionali alla curva di Phillips aumentata con le aspettative di Friedman, anche nel breve periodo la curva di Phillips è verticale.
La seconda ipotesi fondante della NMC è che il sistema economico si trovi continuamente in equilibrio di concorrenza perfetta. In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro, questo è sempre in equilibrio di piena occupazione, anche nel breve periodo, e la disoccupazione è sempre volontaria. Come abbiamo visto sopra, può scostarsi dall’equilibrio di piena occupazione solo nel caso di variazioni impreviste della domanda.
L’ipotesi secondo cui la funzione dell’offerta di lavoro dipende dalla sostituzione intertemporale o, in altri termini, dal trade-off fra tempo libero corrente e tempo libero futuro serve a spiegare le fluttuazioni nel tasso di disoccupazione. Nel modello di Friedman la funzione dell’offerta di lavoro dipende dal trade-off tra consumo e tempo libero. Secondo i teorici della NMC, l’offerta di lavoro non è sensibile alle variazioni permanenti del salario reale, perché il trade-off fra consumo e tempo libero è debole, mentre esiste una forte sostituibilità fra tempo libero corrente e tempo libero futuro. Perciò l’offerta di lavoro è molto sensibile a variazioni temporanee del salario reale. Un aumento temporaneo del salario reale induce infatti gli individui ad aumentare temporaneamente l’offerta di lavoro, per poter disporre di maggiore tempo libero in futuro. Viceversa un aumento permanente del salario reale non comporta una variazione nell’offerta di lavoro. Questa ipotesi è stata utilizzata in alcuni lavori di teorici della NMC per spiegare le fluttuazioni cicliche dell’occupazione, senza utilizzare il concetto di disoccupazione involontaria. Dato che nelle fasi espansive i salari reali aumentano, aumenta anche l’offerta di lavoro; nelle fasi depressive, viceversa, la diminuzione dei salari reali induce i lavoratori a diminuire l’offerta di lavoro per usufruire maggiormente del tempo libero, dato che il lavoro è remunerato meno che nelle fasi espansive.
Non ci addentreremo in questa sede in un’analisi dettagliata, ma ovviamente questo approccio richiede una valutazione sul grado di informazione degli agenti relativo non solo al salario reale presente, ma anche a quello futuro. Se, infatti l’informazione è perfetta, gli agenti sono in grado di valutare non solo se una variazione del salario monetario corrisponde ad una variazione del salario reale, ma anche se una variazione dei salari reali è temporanea o permanente. Se invece l’informazione è imperfetta, com’è in effetti nel mondo reale, si possono considerare diverse ipotesi. Per esempio, gli agenti possono non essere in grado di conoscere il salario reale attuale, ma solo quello monetario e hanno un’informazione incompleta sul livello dei prezzi; oppure può darsi il caso in cui gli agenti conoscono il salario reale presente ma non quello futuro e devono fare valutazioni sull’offerta di lavoro sulla base di stime sull’andamento futuro dei salari reali.
Le verifiche empiriche sulle ipotesi di sostituzione intertemporale sembrano far sorgere seri dubbi sulla validità del modello . Si è anche notato che le fluttuazioni dell’occupazione sono più accentuate per i lavoratori scarsamente qualificati, che sembrano essere decisamente poco propensi a sostituire volontariamente il lavoro con il tempo libero quando i salari reali scendono.
5.6 Le implicazioni dei modelli dei monetaristi e della NMC
Con la critica monetarista alla curva di Phillips, Friedman riporta la ricerca teorica nell’ambito della tradizione pre-keynesiana. Nel modello di Friedman si distingue fra un lungo periodo, in cui valgono i risultati dei classici e un breve periodo, in cui, a causa di imperfezioni nel flusso di informazioni, si possono verificare degli scostamenti dal tasso naturale.
L’idea di fondo è che il sistema economico è fondamentalmente stabile e le forze di mercato sono in grado comunque di condurlo lungo il sentiero della piena occupazione, ovvero al “tasso naturale di disoccupazione”, anche quando shock o perturbazioni provocano scostamenti dal tasso naturale di disoccupazione.
I teorici della NMC si spingono oltre, affermando che l’equilibrio di piena occupazione caratterizza non solo il lungo, ma anche il breve periodo.
I modelli di stampo monetarista e quelli della NMC presentano differenze anche di rilievo, perché si basano su ipotesi differenti sulla formazione delle aspettative, ma hanno in comune alcune ipotesi teoriche fondamentali (tendenza verso l’equilibrio dei mercati, negazione dell’esistenza della disoccupazione involontaria); le conclusioni di politica economica a livello teorico sono parzialmente diverse, ma li accomuna una analoga concezione del ruolo della politica economica per cui tratteremo congiuntamente le implicazioni di tali modelli.
Secondo i monetaristi le manovre di politica economica hanno un effetto solo nel breve periodo, ma non sono in grado di abbassare in modo permanente il tasso di disoccupazione, che tende comunque sempre verso il suo livello naturale. Le manovre discrezionali di politica economica hanno un effetto imprevedibile e possono provocare fluttuazioni dell’economia e dell’occupazione, perché lo Stato non possiede sufficienti informazioni, i processi di raccolta delle informazioni sono lenti e costosi, la burocrazia statale è spesso inefficiente.
Nei modelli della NMC la politica economica risulta inefficace, anche nel breve periodo, a meno che non si verifichino shock casuali, perché le variazioni previste della domanda aggregata non cambiano gli equilibri del sistema.
Monetarismo e NMC concordano dunque nell’affermare che è necessario evitare l’intervento dello stato nell’economia, i monetaristi perché può essere destabilizzante, i teorici della NMC perché è inutile.
E’ facile intuire, e lo vedremo nel prossimo paragrafo, che i risultati e le deduzioni del modello monetarista e di quello della NMC hanno sollevato numerose obiezioni. Non ne vanno sottovalutati i meriti. Il modello di Friedman ha mostrato l’instabilità del trade-off fra inflazione e disoccupazione e ha aperto la strada a nuovi indirizzi di ricerca. La NMC ha avuto il merito di introdurre l’ipotesi di aspettative razionali, ipotesi che è stata utilizzata e sviluppata successivamente anche in modelli diametralmente diversi da quelli della NMC. In questa sede però ci interessa considerare il mercato del lavoro e il significato di questi modelli e delle loro implicazioni di politica economica in relazione al problema occupazionale.
La disoccupazione nell’analisi del monetarismo e della NMC
Nei modelli di tipo monetarista viene negata l’idea dell’esistenza disoccupazione involontaria, che costituisce invece uno degli elementi essenziali del pensiero keynesiano; la disoccupazione involontaria è concepita da Keynes come un fenomeno che si manifesta sul mercato del lavoro ma non dipende dal comportamento o dalla volontà dei lavoratori, bensì è legata, come abbiamo visto, all’instabilità del sistema capitalistico. Per i monetaristi e i teorici della NMC la disoccupazione costituisce un “non problema”, dato che non esiste la disoccupazione involontaria e le persone scelgono di rimanere inoccupate per disporre di maggior tempo libero.
Se la disoccupazione non può essere che volontaria, l’analisi si sposta alla comprensione dei motivi per cui ci sono persone che scelgono di rimanere disoccupate. Sta di fatto che un economista, un politico o uno studente di scienze politiche vuole capire perché una persona alla ricerca di occupazione non riesce a trovare lavoro pur essendo disposta a lavorare al salario corrente e trova assai meno rilevante capire i motivi per cui ci sono persone che scelgono volontariamente di non essere occupate. L’evidenza empirica mostra che la maggior parte dei disoccupati vorrebbe lavorare e non trova lavoro, e non per eccessive pretese o perché preferisce dedicare il suo tempo all’ozio, ma molto semplicemente perché non ci sono sufficienti opportunità lavorative. E le teorie dei monetaristi e della NMC, negando questa evidenza, non forniscono alcuna spiegazione.
Nelle teorie monetariste e della NMC, dunque, le politiche per l’occupazione proposte vengono ricondotte a interventi volti a rimuovere gli ostacoli ad un corretto funzionamento del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro viene trattato alla stregua del mercato dei beni. Come sottolinea Tarantelli, per i monetaristi “Il lavoro non è un soggetto, con le sue istituzioni, il suo sindacato e la sua politica, ma un oggetto, servizio (servus) di produzione”.
Il lettore potrebbe chiedersi a questo punto perché ci siamo soffermati così a lungo su teorie che giudicano la disoccupazione un “non problema”, se vogliamo spiegare perché c’è disoccupazione e quali politiche per l’occupazione possono essere messe in atto.
Nel capitolo 19 della Teoria Generale Keynes affronta dettagliatamente il tema delle variazioni dei salari monetari.
Cfr. F. Vicarelli Keynes. L’instabilità del capitalismo , Etas Libri, Milano, 1977 pag. 164-165. Lo schema proposto da Vicarelli è sintetizzato in N. Accocella Fondamenti di politica economica, Carocci editore, Roma 1999 pag. 233 -234
Cfr. J.R. Hicks Mr Keynes and the ‘Classics’: a suggested interpretation, Econometrica, v. 5, 1937, pag 147-159.
Cfr. F. Modigliani Liquidity preference and the theory of interest and money, Econometrica v.12, 1944, pag 45-88
Per una breve rassegna del dibattito su questo tema si veda ad esempio B. Jossa, M. Musella Macroeconomia: teorie per la politica economica, NIS, Roma 1996 pag. 48-60
In questa sede si fa riferimento al modello della sintesi neoclassica così come esposto normalmente nei libri di testo di macroeconomia, senza distinguere tra i diversi approcci proposti nei vari contributi di questo filone.
Nel modello IS-LM, tale situazione si identifica con uno spostamento verso il basso della funzione degli investimenti e, di conseguenza della curva IS. L’equilibrio si sposta in un punto in cui, rispetto alla situazione di partenza, risultano più bassi sia il tasso di interesse che il reddito. La diminuzione del reddito implica un calo dell’occupazione; si raggiunge così una situazione di equilibrio di sottoccupazione, che può permanere nel breve periodo.
A. V. Phillips The relationship between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957, Economica v.25, 1958 pag.283-299
Cfr. Fisher I.A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes in “International Labour Review”, June, 1926. A livello teorico tale relazione era stata individuata già da Marx nella sua teoria dell’esercito industriale di riserva
P. A. Samuelson , R. M. Solow Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy, American Economic Review, v.50, 1960
P. Onofri e B. Salituro . “Inflazione e politiche di stabilizzazione in Italia” in “Politica economica” n.2 1985
M. Friedman The Role of Monetary Policy, American Economic Review, marzo 1968, E. Phelps Money Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium in E. Phelps (editor) “Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory”, Norton, New York 1970.
Gli individui massimizzano la loro utilità, quindi uguagliano il saggio marginale di sostituzione fra consumi e tempo libero al salario reale.
Cfr. R. E. Lucas Expectations and theNeutrality of Money, Journal of Economic Theory, 4, April 1973; R. E. Lucas Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, American Economic Review, 3, June 1973.
L’elemento di maggiore rilievo nella NMC è proprio l’ipotesi di aspettative razionali. Un’ottima trattazione a livello manualistico di tale ipotesi si trova in C. Casarosa Manuale di macroeconomia, NIS, Firenze 1991.
Esiste però un altro motivo per cui è importante soffermarsi sull’approccio monetarista. Le teorie dei nuovi economisti keynesiani, che vedremo più avanti, si sono sviluppate sulla base della critica alle nuove teorie classiche e ne hanno parzialmente assorbito i contenuti. Non sarebbe quindi possibile capire l’evoluzione della teoria dell’occupazione senza una riflessione sul monetarismo e sulla NMC.
Capitolo 6
La nuova macroeconomica keynesiana
Da alcuni anni la corrente dominante in campo macroeconomico è la nuova macroeconomia keynesiana (NMK). Fra i principali esponenti della NMK possiamo citare Joseph Stiglitz, Olivier Blanchard, Stanley Fisher, Gregory Mankiw. Il principale contributo di tale impostazione in relazione al mercato del lavoro sta nella spiegazione della persistenza della disoccupazione basata sulla rigidità salariale. La NMK spiega la rigidità salariale sulla base di fondamenti razionali che fanno si che i soggetti non abbiano interesse a mutare i loro comportamenti.
Gli orientamenti dei “nuovi keynesiani” vengono spesso visti come antitetici rispetto a quelli dei monetaristi e dei teorici della NMC e sono considerati come uno sviluppo dell’impostazione di Keynes fondato su basi più rigorose. In realtà la NMK poggia su basi molto simili a quelle dei monetaristi. Entrambe i modelli adottano una prospettiva microeconomica per analizzare il mercato del lavoro, che viene considerato come un mercato a sé e non come risultato della performance dell’economia. L’elemento di disaccordo con la tradizione monetarista sta invece nel modo in cui viene trattato il mercato del lavoro, che viene trattato come un mercato caratterizzato da rapporti peculiari fra imprese e lavoratori non assimilabile ai mercati delle merci. Si tratta dunque di un approccio che si pone al confine fra la teoria keynesiana e quella dei monetaristi e della NMC.
La contrapposizione fra i nuovi keynesiani e gli economisti monetaristi e della NMC si basa sulla controversia relativa alla rigidità di prezzi e salari e alla volontarietà della disoccupazione. Come abbiamo visto nel paradigma classico prezzi e salari sono flessibili, i mercati sono sempre in equilibrio e le politiche di stabilizzazione giocano un ruolo irrilevante. Viceversa nella NMK prezzi e salari sono rigidi o “vischiosi”, spesso i mercati non sono in equilibrio e l’intervento dello Stato gioca un ruolo di primo piano nella stabilizzazione dell’economia.
6.1 L’impostazione della NMK
I nuovi keynesiani si propongono di formulare una teoria dell’occupazione, ponendone i fondamenti nella microeconomia del mercato del lavoro. In realtà, cercando di soddisfare il loro proposito, essi si allontanano progressivamente dall’insegnamento di Keynes, a cui viene indebitamente attribuita la convinzione che la rigidità dei salari sia causa della disoccupazione, quando invece Keynes sosteneva che una teoria generale dell’occupazione deve prescindere dalla flessibilità salariale. Come abbiamo visto, infatti, la performance del mercato del lavoro nelle tradizionali teorie Keynesiane è il risultato dell’interazione fra mercati dei beni e mercati finanziari e quindi deve essere messa in relazione con l’andamento della domanda aggregata.
Il punto di partenza della NMK è il modello della sintesi neoclassica, in cui si ipotizzava la rigidità di prezzi e salari. Ma, secondo i monetaristi e la NMC nella sintesi neoclassica manca una spiegazione razionale di tali rigidità; la NMK nasce come risposta a tale critica e cerca di fornire una spiegazione razionale e microfondata alle rigidità presenti nell’economia.
Secondo i nuovi economisti keynesiani i salari non si aggiustano in modo sufficientemente rapido per portare costantemente in equilibrio il mercato del lavoro. Tanto minori sono le fluttuazioni del salario reale, tanto maggiori sono le fluttuazioni dell’occupazione. Quando, al salario reale vigente, l’offerta di lavoro supera la domanda si crea disoccupazione; la viscosità dei salari non permette di riassorbire la disoccupazione riportando in equilibrio domanda e offerta di lavoro. Si consideri la figura 5.1. Se i salari reali sono rigidi e superiori al livello di equilibrio, l’offerta di lavoro eccede la domanda. La domanda di lavoro, infatti, è pari a L1 mentre l’offerta di lavoro è pari a L2. Ne risulta perciò un livello di disoccupazione pari a (L2-L1).
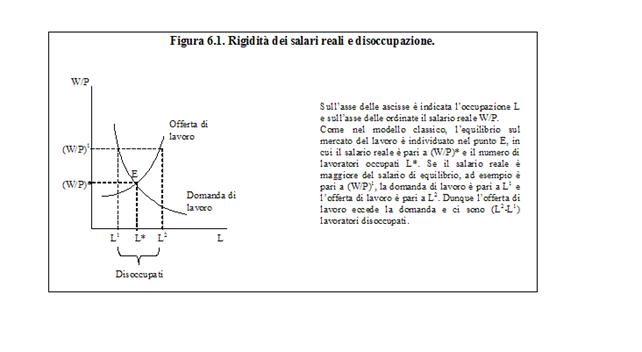
Riassumendo, i nuovi economisti keynesiani ritengono che quando la rigidità salariale non permette di bilanciare domanda e offerta di lavoro si genera disoccupazione. Il dibattito si sposta a questo punto sulle ragioni della rigidità salariale e sui motivi per cui i salari effettivi tendono nel tempo a rimanere al di sopra del salario di equilibrio, causando perciò una persistenza nella disoccupazione. Particolare attenzione viene posta sui fondamenti microeconomici e sulla razionalità economica di tali rigidità.
I motivi addotti per spiegare le rigidità salariale sono numerosi. Vedremo nei prossimi paragrafi alcune fra le principali teorie sulle rigidità salariali. La letteratura economica in proposito è vastissima, qui abbiamo selezionato le teorie più note e significative. Resta aperta la questione se davvero la rigidità dei salari sia causa della disoccupazione e se la flessibilità salariale sia in grado di promuovere il pieno impiego; questa assunzione contiene in effetti degli elementi di arbitrarietà, ma su questo argomento torneremo più avanti.
6.2 I contratti impliciti
La teoria dei contratti impliciti, sviluppata a partire dalla metà degli anni settanta, costituisce un primo tentativo di mettere in relazione la vischiosità dei salari con la disoccupazione in un ambito di scelte ottimizzanti di lavoratori e imprese. Tale approccio assume un particolare rilievo, perché apre la strada a una letteratura che pone l’accento sul fatto che il mercato del lavoro non può essere trattato alla stregua di un qualsiasi mercato dei beni, perchè caratterizzato da rapporti di lavoro duraturi e continuativi.
La mobilità del lavoro non risulta conveniente né per le imprese né per i lavoratori. Per le imprese è costoso sostituire un lavoratore per vari motivi: la ricerca di un lavoratore adatto a ricoprire il posto vacante può essere lunga e difficile, spesso l’impresa deve sostenere costi per formare il nuovo assunto, i nuovi lavoratori impiegano tempo ad adattarsi al nuovo posto di lavoro. Anche il cambiamento del posto di lavoro per i lavoratori può risultare costoso. In primo luogo, la ricerca di un nuovo lavoro può risultare lunga e complessa e il lavoratore può rimanere disoccupato per un certo periodo, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta. Ma anche se c’è piena occupazione e il periodo di disoccupazione risulta limitato o nullo, di regola i lavoratori preferiscono non cambiare posto di lavoro perché normalmente i nuovi assunti vengono pagati meno dei lavoratori inseriti da tempo in un’impresa e perchè il cambiamento del posto di lavoro può creare disagi.
Date queste premesse, nei modelli dei contratti impliciti il motivo chiave per cui vengono stipulati contratti duraturi e continuativi va ricercato nel diverso atteggiamento rispetto al rischio. I lavoratori sono normalmente avversi al rischio di fluttuazioni dei salari a causa delle difficoltà che incontrano a diversificare il loro portafoglio, che è costituito essenzialmente dal capitale umano in loro possesso; perciò preferiscono un salario sicuro e costante piuttosto che un salario che oscilla a seconda delle variazioni del prodotto marginale del lavoro. Le imprese sono invece meno avverse al rischio (di solito in questa letteratura si suppone che siano neutrali), poiché gli azionisti possono diversificare il loro portafoglio e gli imprenditori i loro investimenti. Un altro motivo per cui le imprese hanno una maggiore propensione al rischio rispetto ai lavoratori può essere ricercato nel fatto che chi ha maggiore propensione al rischio tende a scegliere l’attività imprenditoriale, mentre chi è più avverso al rischio sceglie il lavoro dipendente. Sulla base di questo diverso atteggiamento, risulta vantaggioso sia per i lavoratori che per le imprese stipulare contratti che implicitamente contengono un aspetto assicurativo: le imprese si impegnano a non ridurre e aumentare i salari, o a licenziare per poi riassumere lavoratori in relazione alle fluttuazioni della domanda dei loro prodotti; i lavoratori accettano un salario più basso di quello che altrimenti potrebbero percepire in cambio della stabilità del salario e del posto di lavoro. Il salario si discosta quindi normalmente dal prodotto marginale del lavoro e risulta più elevato nei periodi negativi per gli affari dell’impresa e più basso nei periodi positivi.
Il contratto implicito di cui si parla in questi modelli è un accordo tacito secondo cui le imprese evitano di licenziare i lavoratori quando si verifica un calo della domanda dei loro prodotti, se non nei casi strettamente necessari, e i lavoratori tendono a rimanere stabilmente all’interno di un’impresa. Poiché tale aspetto dei contratti non è esplicitamente sottoscritto dalle parti, deve esserci una reciproca convenienza perché sia rispettato. Tale convenienza risiede nel fatto che il mancato rispetto del contratto crea un cattiva reputazione all’impresa e quindi le rende difficile assumere nuovi lavoratori e i lavoratori che rimangono stabilmente nell’impresa possono beneficiare dei vantaggi legati alla carriera e all’anzianità .
La teoria dei contratti impliciti ha il merito di introdurre nella teoria economica l’idea che il funzionamento del mercato del lavoro non si basa su rapporti impersonali fra lavoratori e datori di lavoro e spiega perché i salari tendono a essere rigidi nelle diverse fasi del ciclo economico. Tuttavia non è in grado di dare una spiegazione della disoccupazione, neppure nell’ottica secondo cui la disoccupazione sarebbe generata da un livello dei salari più elevati rispetto a quello di equilibrio; infatti nella teoria dei contratti impliciti il salario medio è quello di equilibrio.
6.3 I salari di efficienza.
Il presupposto su cui si basa la teoria dei salari di efficienza è che la produttività dei lavoratori sia correlata positivamente col salario reale. L’idea di un legame fra la paga del lavoratore e la sua produttività è nata per spiegare come nei paesi in via di sviluppo una retribuzione più elevata sia in grado di migliorare l’alimentazione e quindi lo stato di salute e di efficienza fisica dei lavoratori, rendendoli così più produttivi. Si è constatato però che anche nei paesi sviluppati, se pure per motivi diversi, esiste un legame fra salari reali e produttività del lavoro. L’impegno dei lavoratori dipende in larga misura dal livello dei salari. Salari alti possono invogliare i lavoratori a lavorare bene. Quindi a più alti salari reali corrisponde una più elevata produttività del lavoro, per cui è razionale per le imprese pagare salari più elevati di quelli di equilibrio.
Si deve poi considerare che i lavoratori hanno diversi livelli di efficienza e le imprese hanno difficoltà a valutare le capacità del lavoratore prima dell’assunzione. La carenza di informazioni sulle effettive capacità dei lavoratori fa sì che le imprese siano restie ad assumere lavoratori che si accontentano di bassi salari, perché temono che non siano abbastanza efficienti.
Esiste poi un altro tipo di problema informativo: le imprese hanno difficoltà a controllare a costi ragionevolmente bassi lo sforzo lavorativo degli addetti. Questi possono tenere comportamenti sleali (moral hazard) e non impegnarsi adeguatamente sul lavoro. Salari elevati disincentivano tali comportamenti, perché se i lavoratori vengono colti in fallo nei comportamenti sleali e licenziati per scarsa produttività, hanno difficoltà a trovare un’impresa che offra loro un salario altrettanto elevato o, se c’è elevata disoccupazione, a trovare un altro posto di lavoro.
In genere le imprese non abbassano i salari in presenza di un eccesso di offerta di lavoro. Una diminuzione dei salari spinge i lavoratori, specie i migliori, ad abbandonare il posto di lavoro per cercarne uno meglio retribuito presso un‘altra impresa e ciò comporta due effetti negativi per il datore di lavoro: allontana dall’impresa i lavoratori più efficienti e accresce il turnover dei lavoratori all’interno dell’impresa. Un aumento del turnover comporta per l’impresa un aumento dei costi di ricerca e di addestramento.
Per i motivi sopra menzionati è possibile che una contrazione dei salari provochi una diminuzione dei profitti attesi. Si pone a questo punto il problema di quale sia per l’impresa il salario efficiente, cioè il salario che permette di massimizzare i profitti. Ovviamente il salario efficiente può variare a seconda delle imprese e delle circostanze; tuttavia la teoria suggerisce che il salario reale tenda ad essere piuttosto rigido e superiore al salario che rende uguali domanda e offerta di lavoro.
Un elemento rilevante della teoria dei salari di efficienza riguarda l’interdipendenza fra i salari di imprese diverse. Se alcune imprese abbassano i salari mentre altre li mantengono più elevati, quelle che abbassano i salari vedranno ridurre l’efficienza dei loro lavoratori e perderanno i lavoratori più produttivi. Ciò spiega perché i salari tendono ad essere rigidi verso il basso in modo generalizzato.
La teoria dei salari di efficienza fornisce dunque una spiegazione articolata dei motivi per cui le imprese non abbassano i salari anche in presenza di un eccesso di offerta di lavoro. Ed è anche in grado di spiegare alcune caratteristiche del funzionamento del mercato del lavoro: spiega ad esempio perché esistono mercati del lavoro dualistici con un settore primario, in cui vengono pagati salari più elevati e un settore secondario, in cui i salari sono più bassi.
Vediamo ora perché la teoria dei salari di efficienza è in grado di colmare alcune lacune interpretative del modello classico.
Con l’introduzione dei salari di efficienza, i salari pagati dalle imprese sono fissi e quindi le variazioni dell’occupazione non possono essere attribuite a variazioni del salario reale. I salari di efficienza spiegano anche perché in fasi recessive le imprese preferiscono ridurre la manodopera occupata piuttosto che abbassare i salari. Infatti salari più bassi riducono la qualità delle prestazioni dei lavoratori e quindi la loro produttività. Risulta perciò razionale per le imprese, cioè compatibile con l’obiettivo di massimizzazione dei profitti, ridurre l’occupazione piuttosto che i salari.
Resta il dubbio che, come le altre spiegazioni della rigidità salariale, la teoria dei salari di efficienza sia in grado spiegare le cause della disoccupazione. Anzi, si potrebbe affermare che i salari di efficienza possano nel lungo periodo avere un effetto positivo sull’occupazione, perché favoriscono processi di accumulazione delle esperienze fra i lavoratori, consentono il migliorare l’organizzazione del lavoro e possono costituire uno stimolo ai processi innovativi. Tali processi migliorano la competitività delle imprese e quindi ne favoriscono la crescita, anche in termini occupazionali.
6.4 La teoria dei contratti a lungo termine
Esaminiamo ora gli approcci che fanno riferimento alle caratteristiche generali dei contratti di lavoro, che, a nostro parere, costituiscono uno fra gli elementi più interessanti proposti dalla NMK per spiegare la rigidità o il lento aggiustamento dei salari monetari. Si tratta di teorie che spiegano la viscosità dei salari nominali, non di quelli reali.
Nelle moderne economie le imprese o le associazioni imprenditoriali fissano la struttura dei salari, contrattandola con le associazioni dei lavoratori, e la mantengono immutata per un certo lasso di tempo. La maggior parte dei contratti di lavoro copre periodi di tempo piuttosto lunghi, i contratti hanno quasi sempre una durata pluriennale e possono prevedere incrementi salariali che entrano in vigore a date stabilite. In certi casi è prevista una qualche forma di indicizzazione al tasso di inflazione, ma tale indicizzazione in pratica non è mai completa. L’andamento dei salari stipulati nei settori sindacalizzati tende a essere preso a modello, anche se non completamente, nei settori non sindacalizzati dell’economia. Dunque per tutto il periodo in cui il contratto resta in vigore, i salari nominali tendono ad essere piuttosto rigidi, anche se non completamente. La rigidità dei contratti salariali per tutto il periodo di durata del contratto non permette un adeguamento dei salari al mutare delle condizioni dell’economia. Ad esempio, a fronte di un calo della domanda le imprese non possono diminuire i salari e diminuiscono perciò la manodopera occupata. Si può generare perciò disoccupazione e calo della produzione. Vengono accentuate perciò le fluttuazioni cicliche dell’economia e ciò ovviamente comporta un costo per l’intera società. Ciò non significa però che la contrattazione a lungo termine non sia basata su comportamenti razionali. La contrattazione salariale comporta infatti dei costi tanto per gli imprenditori quanto per i lavoratori. Nei periodi dei rinnovi contrattuali sia le imprese che i sindacati devono impegnarsi nella formulazione di previsioni, le une sull’andamento futuro della produzione e delle vendite, gli altri sull’andamento dei prezzi nell’economia. Se poi esistono motivi di disaccordo, i sindacati possono ricorrere allo strumento dello sciopero, che comporta un costo per entrambe i contraenti. I lavoratori perdono la retribuzione nelle ore di sciopero e le imprese devono interrompere i processi produttivi quindi vedono diminuire il loro fatturato. Dunque sia gli imprenditori che i lavoratori tendono a evitare di dover affrontare con troppa frequenza i costi della negoziazione.
Esiste un altro motivo per cui i contratti a lungo termine risultano razionali: se imprese e lavoratori conoscono con anticipo il livello dei salari possono fare le loro scelte sulla base di informazioni certe.
6.5 La teoria dei contratti periodici
La situazione analizzata nel paragrafo precedente si complica, poi, se i salari non vengono negoziati tutti simultaneamente. E’ questo l’oggetto su cui indaga la teoria dei contratti periodici. Tale teoria si basa sulla constatazione che i contratti di lavoro non solo sono rinnovati a scadenze fisse con intervalli di tempo piuttosto lunghi, ma normalmente la contrattazione è scaglionata nel tempo.
Si supponga che i contratti salariali valgano per un periodo di due anni e che metà della forza lavoro contratti il salario all’inizio di un anno e l’altra metà all’inizio dell’anno successivo. Quindi all’inizio di ogni anno metà dei lavoratori può concordare il salario monetario sulla base degli eventi passati e delle aspettative per il futuro, mentre l’altra metà è vincolata dal contratto di lavoro stipulato l’anno prima. Si ha così una parziale rigidità dei salari monetari, perché solo metà di essi si adegua alla situazione corrente. In presenza di shock o politiche economiche previste o impreviste, dunque, una parte dei salari non può adeguarsi alle nuove condizioni.
Inoltre è necessario tenere conto dei meccanismi di “rincorsa salariale”. Se i contratti sono scaglionati, gli agenti sono influenzati non solo dalle condizioni economiche attuali e dalle aspettative rispetto al futuro, ma anche dai salari contrattati dai lavoratori che hanno stipulato il contratto l’anno precedente. Per comprendere questo meccanismo ricorriamo a un esempio. Si supponga che lo scorso anno sia stato concluso il contratto dei metalmeccanici sulla base di un’aspettativa di inflazione del 3% e che quest’anno debba essere stipulato il contratto dei chimici. Ammettiamo che le condizioni dell’economia siano mutate e che si siano ridotte le aspettative di inflazione, ad esempio che l’inflazione attesa sia l’1%. A rigore i nuovi contratti dei chimici dovrebbero prevedere salari più bassi di quelli dei metalmeccanici. E’ probabile che ciò avvenga, ma che l’adeguamento alle nuove condizioni non sia completo. Infatti se i salari dei chimici sono sensibilmente più bassi di quelli dei metalmeccanici, i lavoratori chimici cercheranno di cambiare occupazione e di andare a lavorare in un’azienda metalmeccanica, che offre un salario maggiore ed è probabile che almeno una parte ci riesca. Ciò finirebbe col creare problemi alle imprese chimiche che, per trattenere i lavoratori dovrebbero aumentare i salari. Solo se le differenze salariali fra chimici e metalmeccanici non sono particolarmente rilevanti, i lavoratori non saranno spinti a cercare un altro lavoro nel settore metalmeccanico, dato che il passaggio da un lavoro ad un altro può comportare dei costi per i lavoratori. Questo non è che un esempio, basato su un’ipotesi di contratti scaglionati per settori. Si possono pensare situazioni analoghe anche per i contratti scaglionati a livello di imprese.
Quindi appare razionale tenere conto non solo delle attuali condizioni dell’economia ma anche dei contratti stipulati precedentemente.
Se poi, il periodo di durata dei contratti è più lungo, e i contratti sono scaglionati in un numero maggiore di periodi, il tempo di adeguamento alle mutate condizioni macroeconomiche si allunga.
Si può obiettare a questo punto che lo scaglionamento dei contratti di lavoro non è né razionale, né efficiente, tuttavia questa è la realtà in quasi tutti i paesi e come tale bisogna tenerne conto.
I contratti di lavoro in Giappone
Il Giappone rappresenta un caso interessante per la verifica delle teorie dei contratti a lungo termine e dei contratti periodici. In Giappone la maggior parte dei rinnovi contrattuali avviene simultaneamente e con scadenza annuale durante la cosiddetta “Offensiva di Primavera”. Inoltre nei contratti è prevista una quota consistente di salario variabile, legata alla performance dell’impresa. Quindi l’adeguamento dei salari alle mutate condizioni economiche appare molto rapido. Ci troviamo dunque di fronte a un caso di flessibilità dei salari sia reali che nominali. La quota di salario variabile, legata all’andamento economico dell’impresa, consente di far diminuire anche in modo consistente il salario monetario nelle fasi congiunturali negative. Certamente la flessibilità salariale ha costituito per un lungo periodo un potente ammortizzatore delle fluttuazioni cicliche dell’economia. Ma ciò è avvenuto in un periodo in cui l’economia giapponese presentava tassi di crescita particolarmente elevati. Si pensava allora che la flessibilità dei salari fosse un potente strumento per mantenere la piena occupazione.
Negli anni novanta la situazione economica giapponese è radicalmente mutata. Con la grave recessione che ha colpito il Giappone, la disoccupazione ha cominciato a crescere e ha continuano ad aumentare per circa un decennio. Va osservato che il calo dei salari reali (dovuto al venir meno della quota variabile legata alla performance delle imprese) non ha contribuito al rilancio della domanda di consumi e può aver costituito un ostacolo alla ripresa economica.
In ogni caso va osservato che le modalità di formazione dei salari in Giappone si inseriscono in un mercato tutt’altro che concorrenziale, che lo stato interviene a protezione delle imprese più deboli e dell’occupazione e che, per evitare licenziamenti, ha incentivato riduzioni dell’orario di lavoro. Ciò spiega perché la crescita della disoccupazione in Giappone è stata relativamente contenuta. E’ opportuno perciò usare molta cautela quando si cita il modello giapponese per dimostrare che quanto maggiore è la flessibilità salariale, tanto minori sono le fluttuazioni dell’occupazione.
6.6 I modelli di contrattazione sindacale
I modelli che fanno riferimento al ruolo dei sindacati si basano sull’ipotesi che i salari determinati attraverso la contrattazione fra imprese e lavoratori tendano ad essere rigidi e rendano perciò più probabili le fluttuazioni dell’occupazione.
I modelli di contrattazione sindacale si basano sull’ipotesi che i sindacati abbiano una funzione obiettivo ben precisa, che massimizza l’utilità dei propri membri. Tale assunzione implica che tutti i membri del sindacato siano trattati allo stesso modo sia dal sindacato che dall’impresa e che abbiano la stessa funzione di utilità. I modelli di contrattazione sindacale si differenziano per la scelta delle variabili che sono oggetto di contrattazione fra le parti sociali. Possiamo a questo proposito individuare quattro filoni di analisi: i modelli di “right to manage”, in cui sindacati e imprese contrattano insieme il salario, i modelli di monopolio, in cui i sindacati fissano il salario e le imprese decidono il livello di occupazione, i modelli di contrattazione efficiente, in cui imprese e sindacati contrattano congiuntamente salari e occupazione e infine i modelli insider-outsider.
Nell’approccio “right-to-manage” si suppone che il salario sia negoziato congiuntamente da imprese e sindacati. Restando sulla curva di domanda di lavoro, le imprese scelgono unilateralmente il livello dell’occupazione che consente di massimizzare i profitti. Ci sono diversi modelli che illustrano il processo di contrattazione fra sindacato e imprese. Consideriamo il modello più noto, cioè quello di Jackman . Si ipotizza che il sindacato riceva dall’impresa un’offerta di un salario pari a w1; esso si porrà il problema di quanto a lungo potrà sostenere uno sciopero per ottenere un’offerta più elevata, ed esempio pari a w2. Il sindacato dovrà perciò valutare i costi derivanti dallo sciopero e i benefici che deriverebbero dall’ottenere un salario pari a w2. Analogamente l’impresa valuta i benefici che derivano dal pagare il salario w1 e i costi (cioè i minori profitti) derivanti dallo sciopero che dovrà subire. Si suppone che sia più disponibile all’accordo chi ha un potere contrattuale più debole, cioè la parte che è disponibile a sostenere i costi dello sciopero per un periodo più breve.
Una versione estrema del modello “right-to-manage” è il modello del sindacato monopolista. Secondo tale approccio, il sindacato, tenendo conto della curva di domanda di lavoro delle imprese, è in grado di fissare unilateralmente e senza nessuna contrattazione, il livello dei salari, massimizzando la sua funzione di utilità. L’impresa successivamente determina il livello dell’occupazione. Il livello dei salari stabilito dal sindacato è ovviamente condizionato dalla posizione dei suoi aderenti.
McDonald e Solow (1981) hanno sottolineato come nei modelli tipo “right-to-manage” si ottengano soluzioni inefficienti. Nel modello di contrattazione efficiente si ipotizza che il sindacato sia interessato tanto al salario quanto all’occupazione; in tal caso sindacato e impresa potrebbero ottenere un miglioramento paretiano, definendo una soluzione contrattuale che non trascuri l’obiettivo dell’occupazione.
Una critica importante al tipo di modelli di comportamento del sindacato che abbiamo considerato riguarda il fatto che si collocano in un contesto statico e quindi non sono in grado di tenere conto degli effetti degli obiettivi sindacali sull’andamento del tasso di sindacalizzazione. Alcuni tentativi sono stati fatti per spiegare l’evoluzione delle adesioni al sindacato, ma comunque questi modelli sembrano ancora scarsamente aderenti alla realtà.
Le battaglie portate avanti da molti sindacati europei per combattere la disoccupazione, anche attraverso la riduzione degli orari di lavoro, mostrano come i sindacati possono essere interessati a favorire aumenti dell’occupazione, accettando politiche di moderazione salariale. In Italia nelle negoziazioni fra sindacati e imprese spesso è presente una richiesta da parte sindacale di nuove assunzioni. Le finalità del sindacato sono diverse a seconda delle tradizioni, del tipo di sindacato, del momento storico. Se guardiamo alle strategie sindacali nel nostro paese possiamo affermare che esse sono guidate da una pluralità di obiettivi, che appaiono difficilmente sintetizzabili in un modello semplificato. In ogni caso la realtà in Italia, così come in molti paesi europei, evidenzia oggi una particolare attenzione al problema dell’occupazione, in un’ottica che va ben oltre la difesa dei livelli occupazionali esistenti, ma che comporta una particolare attenzione nei confronti dei disoccupati.
6.7 I modelli insider-outsider
I modelli insider outsider costituiscono una variante dei modelli sul ruolo del sindacato.
Secondo i modelli insider outsider i salari sono rigidi anche in presenza di disoccupazione per l’opposizione degli occupati (insider) che non hanno alcun interesse ad una diminuzione dei salari che permetta di assorbire la disoccupazione. I disoccupati (outsider) sarebbero disposti a lavorare a salari più bassi di quelli degli occupati e gli imprenditori potrebbero essere disposti ad assumerli, magari licenziando un occupato. Tuttavia ciò non accade per vari motivi, fra i quali possiamo citare:
- Gli insider hanno una posizione contrattuale più forte, perché sono già in possesso delle qualificazioni richieste dall’impresa.
- Esistono costi di licenziamento e di assunzione, di cui gli imprenditori devono tenere conto.
- Gli insider terrebbero un comportamento ostile nei confronti sia dei lavoratori assunti a salario più basso a parità di mansione, coi quali si rifiuterebbero di cooperare, sia nei confronti dell’impresa che si è comportata in modo sleale.
- Gli outsider non offrono le loro prestazioni lavorative a salari inferiori rispetto a quelli degli insider perché sanno che incontrerebbero l’ostilità degli insider.
Dunque gli insider sono in una posizione contrattuale più forte e hanno interessi diversi da quelli degli outsider. Questi ultimi vorrebbero ottenere un posto di lavoro, gli insider vogliono mantenere l’occupazione e aumentare il salario reale. Gli insider si rendono conto che la loro forza dipende dall’agire collettivamente come un gruppo, e quindi sono interessati in primo luogo a evitare licenziamenti. Se allora il tasso di disoccupazione è basso, e gli occupati sono quindi relativamente numerosi, gli insider contratteranno un salario relativamente basso, dato che salari più alti implicherebbero una riduzione del personale. Viceversa, se la disoccupazione è elevata e gli occupati sono relativamente pochi, gli insider potranno contrattare un salario più elevato, dato che ogni occupato è prezioso per l’impresa. Gli insider hanno quindi sostanzialmente un potere monopolistico e un elevato livello di disoccupazione non può influenzare i salari.
Anche in questo modello si sottolinea l’ipotesi di razionalità e come il comportamento razionale da parte degli insider non permetta il riassorbimento della disoccupazione.
La modellistica insider outsider, che qui abbiamo brevemente sintetizzato, è stata oggetto di notevole attenzione nell’ambito della NMK. Tuttavia appare poco realistica e può essere oggetto delle stesse obiezioni che abbiamo visto a proposito dei modelli sul ruolo del sindacato L’evidenza empirica mostra che le richieste salariali non aumentano quando la disoccupazione è più elevata, caso mai accade l’opposto e che, in ogni caso, gli insider non sono indifferenti all’andamento dell’occupazione, anche quando non ne sono direttamente toccati.
6.8 La rigidità salariale è davvero causa di disoccupazione?
I modelli che spiegano la rigidità salariale sono spesso illuminanti e razionalmente fondati; senza dubbio hanno dato un contributo di rilievo alla teoria economica; tuttavia tali modelli non dimostrano affatto che le rigidità salariali siano causa della disoccupazione. L’attenzione dei nuovi economisti keynesiani nei confronti del tema della rigidità salariale dipende dalla convinzione che la causa della disoccupazione debba essere attribuita alla rigidità dei salari e, di conseguenza che la flessibilità salariale dovrebbe essere in grado di promuovere la piena occupazione, anche se questa proposizione non è quasi mai esplicitata nei modelli della NMK. Gli economisti della tradizione keynesiana, come peraltro lo stesso Keynes, invece, non hanno rivolto grande attenzione al tema della rigidità salariale, perché persuasi che la flessibilità dei salari non fosse uno strumento adeguato per creare la piena occupazione. E’ importante però evidenziare che, nonostante l’ambizione della NMK di essere più realistica della scuola monetarista e della NMC, l’idea che la rigidità salariale sia causa di disoccupazione non si basa affatto su un’evidenza empirica persuasiva.
E’ opportuno a questo punto indicare una serie di eventi, che sembrano smentire o almeno ridimensionare la proposizione secondo cui le rigidità salariali sono causa di disoccupazione.
Come abbiamo visto nell’approfondimento sul caso del Giappone, la flessibilità salariale, garantita sia della brevità dei contratti di lavoro che dalla presenza di una quota legata all’andamento dei risultati dell’impresa, non ha impedito l’aumento della disoccupazione durante la grave recessione che colpisce il Giappone ormai da anni.
Lo scarso livello di sindacalizzazione e la breve durata dei contratti di lavoro negli Stati Uniti garantiscono una notevole flessibilità salariale e nello scorso decennio molti sostenevano che proprio la flessibilità salariale ha permesso di mantenere basso il tasso di disoccupazione negli Stati Unti. Ciò non è servito a contrastare l’ondata di licenziamenti e il rapido aumento del tasso di disoccupazione che si è verificato negli ultimi tre anni.
Anche in Spagna il potere sindacale è limitato e la diffusione di contratti a tempo determinato è molto elevata, copre infatti circa un terzo della forza lavoro dipendente. I contratti temporanei permettono un’elevata flessibilità salariale. Ciononostante, il tasso di disoccupazione continua ad essere il più elevato d’Europa ed in passato ha superato il 20%, proprio in concomitanza con la diffusione dei contratti a tempo determinato.
Varie ricerche, incluse quelle dei Job Study dall’OCDE, inoltre, sembrano confermare che non esiste una correlazione positiva fra aumento dell’occupazione e aumento della flessibilità salariale.
6.9 Un approfondimento: il NAIRU
Nella NMK disoccupazione e inflazione vengono esaminate attraverso l’analisi del funzionamento del mercato del lavoro e dei beni in regime di concorrenza imperfetta. L’attenzione degli economisti neokeynesiani è rivolta a mantenere fermi due principi fondamentali:
- i modelli devono essere microfondati, cioè i processi macroeconomici devono essere il risultato dell’aggregazione di processi individuali razionali,
- gli agenti sono razionali e hanno comportamenti ottimizzanti.
Dunque i processi individuati a livello macroeconomico sono il risultato di scelte razionali operate a livello microeconomico.
E’ importante notare che la NMK, pur abbandonando l’ipotesi dell’uguaglianza fra domanda e offerta di lavoro, non implica il concetto di disequilibrio, bensì una nuova concezione di equilibrio inteso non come una situazione in cui domanda e offerta sono bilanciate; condizione di equilibrio viene invece considerata quella in cui nessun soggetto economico ha interesse a cambiare il suo comportamento.
Con la NMK il concetto di tasso naturale di disoccupazione viene sostituito dal NAIRU (non accelerating inflation rate of unemployment), cioè il tasso di disoccupazione compatibile con un tasso di inflazione costante.
Il tasso naturale di disoccupazione, come abbiamo visto, è definito come il tasso di disoccupazione determinato da una situazione di uguaglianza fra domanda e offerta di lavoro ed è costruito su fondamenti microeconomici che si basano sull’equilibrio concorrenziale dei mercati (in cui prezzi e salari sono dati).
Il concetto di NAIRU è invece fondato sull’ipotesi di concorrenza imperfetta e non implica l’uguaglianza fra domanda e offerta di lavoro. Il NAIRU è quel valore del tasso di disoccupazione che rende compatibili le richieste salariali dei lavoratori con le richieste di profitto da parte delle imprese. Si supponga che tali richieste non risultino compatibili e che la somma delle richieste dei lavoratori e delle imprese sia superiore al prodotto disponibile; poiché sia le imprese che i lavoratori hanno un potere di mercato, si determina un conflitto distributivo fra lavoratori e imprese per accaparrarsi una quota di prodotto. I lavoratori cercano di ottenere salari reali più elevati mentre le imprese cercano di aumentare i prezzi, ne risulta perciò un aumento del tasso di inflazione.
Vediamo ora come si determina il potere contrattuale di imprese e lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, si assume che queste fissino il livello dei prezzi in base alla regola del mark-up, cioè stabiliscono un ricarico dei prezzi sui costi di produzione.
I salari monetari sono fissati attraverso la contrattazione fra sindacati e datori di lavoro. I lavoratori sono interessati ai salari reali; perciò i sindacati contrattano il livello dei salari monetari sulla base delle aspettative sul livello dei prezzi atteso nel periodo di validità degli accordi. Il potere contrattuale dei lavoratori dipende principalmente dal tasso di disoccupazione. In presenza di elevati tassi di disoccupazione, i salari risultano relativamente bassi perché il potere di contrattazione salariale risulta limitato, mentre man mano che la disoccupazione diminuisce, i salari tendono ad aumentare grazie alla maggior forza contrattuale dei lavoratori.
Tanto più elevato è il tasso di disoccupazione, tanto minore è il potere contrattuale dei lavoratori e perciò tanto più basse sono le rivendicazioni salariali; ad un diminuzione del tasso di disoccupazione corrisponde un aumento della forza contrattuale e quindi delle richieste salariali.
Il salario reale fissato dalle imprese in base al mark-up non dipende dal tasso di disoccupazione, esso infatti dipende dalle decisioni delle imprese relative alla fissazione dei prezzi.
Esiste un solo tasso di disoccupazione di equilibrio, il NAIRU, che rende compatibili le richieste salariali dei lavoratori con il costo del lavoro desiderato dalle imprese. Tale tasso di disoccupazione non implica l’equilibrio fra domanda e offerta in tutti i mercati. In genere in corrispondenza del NAIRU esiste disoccupazione involontaria.
Il modello del NAIRU ipotizza che le imprese stabiliscano il prezzo quando già è stato contrattato il salario; quindi esse possono sempre raggiungere il loro obiettivo.
Vediamo meglio perché il NAIRU rappresenta l’unico livello del tasso di disoccupazione che permette la costanza del tasso di inflazione.
Se il salario contrattato è superiore a quello che comporta l’equilibrio del NAIRU, aumenta il salario fissato dalle imprese in base al mark-up e aumenta quindi il tasso di inflazione.
Poiché le imprese fissano i prezzi dopo che è stato contrattato il salario, ad un aumento del salario contrattato le imprese reagiscono aumentando il livello dei prezzi per poter mantenere invariato il mark-up sui costi unitari del lavoro. Ciò comporta un aumento del tasso di inflazione. L’aumento del tasso di inflazione erode gli aumenti salariali, per cui si verificano nuove richieste di aumenti salariali. A questo punto si crea un meccanismo di rincorsa prezzi-salari che determina un’accelerazione continua del tasso di inflazione.
Dunque solo quando le richieste dei lavoratori coincidono con l’offerta salariale delle imprese, l’inflazione rimane costante.
E’ evidente l’analogia di questo modello con il modello di Friedman. Tuttavia esistono alcune differenze di rilievo. Il concetto di NAIRU appare più realistico di quello di tasso naturale di disoccupazione sia perché assume un modello di concorrenza imperfetta, sia perché non esclude la presenza di disoccupazione involontaria anche in situazioni di equilibrio.
Il modello del NAIRU ripropone l’alternativa fra inflazione e disoccupazione presente nella curva di Phillips. Se il governo vuole abbassare il tasso di disoccupazione con politiche espansive, deve fronteggiare un tasso di inflazione crescente. In questo ragionamento è sottintesa l’idea che un indebolimento del potere contrattuale dei sindacati e un aumento della flessibilità del mercato del lavoro favorirebbe la diminuzione del NAIRU. Ciò spiega l’attenzione rivolta dai teorici della NMK al problema delle rigidità salariali. Non si tiene conto però dell’effetto depressivo sulla domanda aggregata di un abbassamento dei salari conseguente a un indebolimento dei sindacati o a un aumento della flessibilità; un calo dei salari potrebbe infatti determinare un calo dell’occupazione per carenza di domanda.
6.10 Conclusioni
Come abbiamo visto, esistono diversi elementi di convergenza fra la NMC e la NMK, in particolare l’importanza attribuita ai fondamenti microeconomci della macroeconomia e, in numerosi approcci della NMK, si accetta l’ipotesi di aspettative razionali. La NMK rigetta però non solo l’ipotesi della NMC secondo cui i mercati tendono all’equilibrio continuo e istantaneo, ma anche l’assunto neoclassico secondo cui il sistema economico può essere analizzato con un modello di concorrenza perfetta e la performance dell’economia è regolata prevalentemente dal sistema dei prezzi. La NMK cerca di spiegare razionalmente, basandosi sui fondamenti microeconomici, le rigidità e le imperfezioni dei mercati, tenendo conto dell’esistenza delle condizioni di incertezza e dei costi delle informazioni. Il risultato è un approccio assai più realistico.
In particolare il mercato del lavoro viene analizzato come un mercato diverso da tutti gli altri, in cui contano i rapporti personali, i contratti a lungo termine, le norme sociali, la buona reputazione. Ciò fornisce un indubbio contributo alla comprensione del funzionamento del mercato del lavoro. Certamente la NMK si distacca fondamentalmente dalla tradizione keynesiana e anche in parte dalla sintesi neoclassica perché, per spiegare la disoccupazione, concentra l’attenzione sul mercato del lavoro, mettendo in un angolo quella che per Keynes era la determinante fondamentale del livello di occupazione, e cioè la domanda effettiva. I keynesiani ortodossi inoltre dubitano che la flessibilità di prezzi e salari sia in grado di ridurre la disoccupazione involontaria. Anzi, in un’ottica keynesiana si potrebbe affermare che la rigidità dei salari potrebbe avere un effetto positivo sull’occupazione; infatti in presenza di salari rigidi variazioni della domanda dovrebbero avere l’effetto moltiplicativo sul reddito evidenziato dal modello keynesiano per cui, proprio grazie alla rigidità salariale, una politica economica espansiva potrebbe ridurre la disoccupazione senza eccessive tensioni inflazionistiche.
Capitolo 7
L’equilibrio con razionamento
Le teorie fin qui analizzate concentrano la loro attenzione sul mercato del lavoro per spiegare il problema della disoccupazione, volontaria per i monetaristi e gli esponenti della NMC, involontaria per i teorici della NMK. In parallelo, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, sono stati sviluppati modelli che descrivono la disoccupazione come il risultato di carenze di coordinazione dei mercati e fanno riferimento a problemi di disequilibrio. La teoria macroeconomica del disequilibrio è abbastanza vasta, ma raramente viene presentata a un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori a causa della sua complessità e dell’elevato livello di formalizzazione. Va detto, però, che essa è in grado di cogliere la molteplicità delle interazioni fra le variabili macroeconomiche che spesso non emerge nei contributi teorici più accessibili che abbiamo esaminato nei capitoli precedenti. La letteratura del disequilibrio, o almeno una parte di essa, è forse il filone teorico più vicino al pensiero keynesiano, in quanto mette in luce come la disoccupazione sia il risultato di processi che non dipendono dal mercato del lavoro, ma in generale dalla performance del sistema economico.
In questo capitolo analizzeremo uno dei primi contributi alla teoria della disoccupazione che si inserisce nel filone delle teorie del disequilibrio, e cioè quello di Malinvaud, sviluppato fra gli anni settanta e ottanta. Tale teoria costituisce uno dei contributi più interessanti e significativi allo studio della disoccupazione.
Le teoria del disequilibrio di Malinvaud , detta anche, forse più propriamente, teoria dell’equilibrio con razionamento, integra il contributo keynesiano alla teoria della disoccupazione con l’apporto delle teorie classiche.
7.1 Razionamento e rigidità dei prezzi
La teoria dell’equilibrio con razionamento si prefigge l’obiettivo di spiegare la disoccupazione involontaria, che viene individuata come la disoccupazione che si genera sul mercato del lavoro quando l’offerta eccede la domanda. In caso di disoccupazione involontaria gli offerenti sono razionati, nel senso che alcuni non trovano lavoro. La disoccupazione deve dunque essere spiegata con una teoria del razionamento.
E’ possibile che le imprese producano ciò che viene domandato dalla collettività, ma che ai prezzi correnti vorrebbero offrire una quantità maggiore di prodotto. In questo caso l’offerta viene razionata per carenza di domanda effettiva. Dato che il fabbisogno di lavoro è legato al livello della produzione, se c’è carenza di domanda effettiva gli imprenditori impiegano meno lavoratori di quanti ne impiegherebbero se potessero vendere tutto ciò che desiderano. Il razionamento sul mercato dei beni provoca quindi un razionamento sul mercato del lavoro (e perciò disoccupazione involontaria). L’eccesso di offerta di lavoro dipende dunque in questo caso dal fatto che le imprese sono razionate sul mercato dei beni. A sua volta la domanda di beni è dipendente dai redditi da lavoro, dato che i lavoratori sono anche consumatori.
Mercato dei beni e mercato del lavoro sono interdipendenti e vanno analizzati simultaneamente. Perciò la disoccupazione non può essere considerata solo nell’ottica dell’equilibrio del mercato del lavoro. Questo ragionamento è espressione degli elementi introduttivi della teoria di Keynes.
La teoria del razionamento non è applicabile in un modello di concorrenza perfetta con piena flessibilità di prezzi e salari. Se infatti si assumesse un’ipotesi di concorrenza perfetta e completa flessibilità dei prezzi, gli squilibri verrebbero istantaneamente eliminati. E’ sufficiente abbandonare una di queste ipotesi per costruire un modello di equilibrio con razionamento.
Malinvaud assume nel suo modello la rigidità dei prezzi nel breve periodo; egli sottolinea infatti che l’idea secondo la quale i prezzi reagiscono velocemente alle variazioni di offerta e di domanda appare inadeguata per un’analisi macroeconomica di breve periodo. Rapidi aggiustamenti dei prezzi possono verificarsi nei mercati delle materie prime e dei prodotti agricoli, mentre i prezzi dei manufatti e dei servizi nel breve periodo tendono ad essere rigidi. I salari tendono a variare con la variazione della domanda di lavoro, come evidenzia la curva di Phillips, ma la variazione dei salari tende ad essere piuttosto limitata rispetto alla dimensione degli squilibri che la determinano. Quindi variazioni della domanda o dell’offerta hanno un’influenza sulle scorte, sugli ordinativi, sulle ore lavorate e sull’occupazione, mentre hanno un impatto limitato su prezzi e salari che si aggiustano invece lentamente; gli aggiustamenti nelle quantità (di produzione e di occupazione) sono di dimensioni più ampie di quelle di prezzi e salari. Ciò è documentato da numerosi studi econometrici.
7.2 Come si determinano le transazioni
E’ necessario a questo punto capire come si realizza l’aggiustamento delle quantità scambiate, assumendo dati i prezzi .
Nella teoria di equilibrio con razionamento è importante distinguere chiaramente i concetti di domanda e offerta da quelli di acquisti e vendite. La domanda rappresenta ciò che si vorrebbe acquistare, l’acquisto è ciò che effettivamente si compra. L’offerta è ciò che si vorrebbe vendere, la vendita è ciò che realmente viene venduto. Nel cosiddetto “equilibrio walrasiano”, in cui si assume che siano i prezzi ad aggiustarsi, la domanda coincide con gli acquisti e l’offerta con le vendite; in una situazione di equilibrio con razionamento ciò non è più vero.
In qualsiasi mercato è il “lato corto” che determina l’ammontare delle transazioni, mentre il “lato lungo” è sottoposto a razionamento. Questo significa che se la domanda di un bene eccede l’offerta, le transazioni effettive saranno pari all’offerta (lato corto) e la domanda è razionata, se viceversa l’offerta eccede la domanda, il lato corto sarà la domanda, cioè le transazioni saranno pari alla domanda e l’offerta è razionata. Facciamo un esempio: se, dato il prezzo di un bene, la quantità domandata è pari a 10 e la quantità offerta è pari a 8, le transazioni di quel bene sono pari a 8, domina quindi l’offerta, che in questo caso costituisce il “lato corto” e l’acquisto risulta inferiore alla domanda. Se invece la quantità domandata è pari a 4 e la quantità offerta è pari a 5, le transazioni di quel bene sono pari a 4; in questo caso il lato corto è la domanda e la vendita è inferiore all’offerta.
Il principio del lato corto deriva dal fatto che in ogni scambio deve esserci un accordo fra venditore e compratore e, poiché nessuno può essere obbligato a scambiare più di quanto desidera, i volumi scambiati saranno vincolati dalle quantità minori.
Si definisce mercato dominato dai compratori (o, più semplicemente, mercato del compratore) un mercato in cui il lato corto è quello dalla domanda, nel senso che la domanda dei compratori viene pienamente soddisfatta mentre i venditori sono razionati. Analogamente un mercato dominato dai venditori (o mercato del venditore) è un mercato in cui il lato corto è quello dell’offerta.
Una importante conseguenza che deriva dall’esistenza di situazioni di razionamento è che vincoli alla domanda o all’offerta che si producono in un mercato inducono gli agenti a tenere conto di ciò nei propri comportamenti su altri mercati. Ad esempio se le imprese sono razionate nelle vendite, nel senso che non riescono a vendere tutto ciò che vorrebbero offrire ai prezzi correnti, ne tengono conto nel mercato del lavoro; assumono quindi meno lavoratori di quanti ne assumerebbero se non fossero razionati nelle vendite. Analogamente se esiste razionamento sul mercato del lavoro, i lavoratori disoccupati che quindi non percepiscono un salario acquisteranno meno beni di quanti ne comprerebbero se fossero occupati.
Possiamo quindi affermare che domande e offerte effettive su un mercato dipendono non solo dal livello dei prezzi ma anche dai vincoli presenti sul mercato stesso e su altri mercati.
7.3 Tipologie di equilibri
La teoria dell’equilibrio con razionamento può essere illustrata attraverso un semplice schema. Sia d la domanda aggregata di beni e servizi, y* il livello di produzione risultante dal pieno utilizzo della capacità produttiva, N l’offerta di lavoro, β la produttività del lavoro, e quindi β N la produzione di pieno impiego. Nel breve periodo, data la capacità produttiva e assumendo che la produttività del lavoro sia data e rigida , il valore della produzione y è dato da:
y = Min ( d , y* , β N )
Se i tre valori sono uguali ci troviamo in una situazione di equilibrio walrasiano , in cui c’è piena occupazione e pieno utilizzo della capacità produttiva. Se i tre valori sono diversi, è necessario distinguere tre casi:
Caso 1. Se d è il più piccolo dei tre le vendite sono razionate per carenza di domanda effettiva. In questo caso tanto il mercato del lavoro quanto il mercato dei beni sono dominati dai compratori.
“Il mercato del lavoro è dominato dai compratori” significa che la domanda di lavoro determina l’occupazione e, dato che l’offerta di lavoro supera la domanda, c’è disoccupazione; gli individui si trovano razionati sul mercato del lavoro. “Il mercato dei beni è dominato dai compratori” significa che le vendite sono razionate per carenza di domanda effettiva. Il razionamento delle vendite vincola l’utilizzo del lavoro.
La domanda di lavoro risulta inferiore all’offerta di lavoro e la capacità produttiva non viene completamente utilizzata. E’ questo il caso di ”disoccupazione keynesiana” perché è il tipo di disoccupazione individuata da Keynes ed è determinata dal fatto che le imprese fissano la domanda di lavoro in relazione al livello delle vendite. Nel caso di disoccupazione keynesiana c’è manodopera disoccupata e contemporaneamente capacità produttiva inutilizzata.
Caso 2. y* è il valore minore. Come nel caso precedente è la domanda di lavoro che determina l’occupazione e c’è un eccesso di offerta di lavoro, ma in questo caso le imprese offrono tutto il prodotto potenziale. In questo caso ilmercato del lavoro è dominato dai compratori e il mercato dei beni è dominato dai venditori. Quindi, come nel caso precedente, è la domanda di lavoro che determina l’occupazione e c’è disoccupazione dato che l’offerta di lavoro supera la domanda. Viceversa il mercato dei beni è dominato dai venditori, cioè le imprese vendono tutto i beni che sono in grado di produrre utilizzando completamente gli impianti e i macchinari disponibili.
In questo caso il razionamento nell’utilizzo del lavoro è dovuto a scarsità di capacità produttiva e può essere spiegato da un’insufficiente accumulazione di capitale nel periodo precedente, che ha determinato una crescita troppo bassa della capacità produttiva rispetto allo sviluppo della forza lavoro. E’ questo il caso della cosiddetta “disoccupazione classica”.
Nel caso di disoccupazione classica gli individui sono sottoposti a razionamento sia sul mercato dei beni che sul mercato del lavoro: certi soggetti non trovano lavoro, altri non riescono ad acquistare tutti i beni desiderati.
Caso 3. Se β N è il valore più piccolo c’è un eccesso di domanda di beni, così come un eccesso di domanda di lavoro. Sia il mercato dei beni che il mercato del lavoro sono condizionati dai venditori. E’ il caso in cui c’è piena occupazione e ovviamente le imprese si trovano razionate nella domanda di lavoro e quindi non possono offrire più di ciò che producono, anche se la capacità produttiva non è pienamente utilizzata; il livello della produzione, e quindi dell’offerta, è determinato dall’offerta di lavoro. E’ questo il caso di inflazione repressa, nel senso che in tale situazione prezzi e salari non sono cresciuti a sufficienza per assorbire gli eccessi di domanda. In questo caso gli individui non sono razionati sul mercato del lavoro, ma sono razionati sul mercato dei beni.
Teoricamente esiste anche il caso in cui il mercato del lavoro è dominato dal venditore e il mercato dei beni dal compratore, ma non è economicamente significativo perché se le imprese sono vincolate nelle vendite, ovvero c’è carenza di domanda, non hanno convenienza ad assumere lavoratori aggiuntivi.
Abbiamo dunque individuato tre casi economicamente significativi in cui si determina una situazione di equilibrio con razionamento, in cui cioè domina il “lato corto”.
La figura 7.1 illustra tali casi.
Figura 7.1
|
|||
|
Mercato del bene |
||
Mercato del compratore |
Mercato del venditore |
||
Mercato del |
Mercato del compratore |
Disoccupazione keynesiana |
Disoccupazione classica |
Mercato del venditore |
/////////////////////////////////////// |
Inflazione repressa |
|
Si noti che i consumatori/lavoratori sono razionati in tutti e tre i casi: sul mercato del lavoro, nel caso di disoccupazione keynesiana, sul mercato dei beni nel caso di inflazione repressa, in entrambe i mercati nel caso di disoccupazione classica.
Semplificando, possiamo affermare che la disoccupazione keynesiana deriva essenzialmente da un livello dei prezzi troppo elevato, ovvero da un potere d’acquisto dei salari troppo basso. La disoccupazione classica sembra avere come causa principale un costo del lavoro troppo elevato, che è causa di una profittabilità troppo bassa e quindi di una crescita insufficiente della capacità produttiva. Nel caso di inflazione repressa il livello dei prezzi troppo basso provoca una domanda di consumi troppo elevata e, simultaneamente, il livello dei salari troppo basso provoca un eccesso di domanda di lavoro.
Volendo concentrare l’attenzione sul problema della disoccupazione, nell’analisi che segue verrà tralasciato il caso dell’inflazione repressa.
Si noti che questa analisi implica una curva di domanda di lavoro, che mette in relazione occupazione L e salari reali w/p, che ha un andamento ben diverso da quella inclinata negativamente che normalmente viene proposta nei testi di macroeconomia. La curva di domanda di lavoro risulta spezzata, perché è crescente nel caso di disoccupazione keynesiana, dato che un aumento dei salari reali determina una crescita dell’occupazione, e decrescente nel caso di disoccupazione classica, perché un aumento dei salari comporta viceversa una riduzione dell’occupazione. Nella figura 7.2 è illustrata la funzione di domanda di lavoro in relazione ai salari reali. E rappresenta il punto dell’equilibrio di piena occupazione; nel tratto al di sotto del punto E si registra disoccupazione keynesiana, nel tratto al di sopra del punto E si ha invece disoccupazione classica. La situazione rappresentata nella figura 7.2 è naturalmente una situazione estrema, in cui si assumono caratteristiche omogenee in tutti i settori produttivi e si prescinde perciò dalle caratteristiche specifiche dei diversi settori. dell’economia. Se si tiene conto delle differenze fra settore e settore, la funzione rappresentata nella figura non presenta una punta in E, ma ha andamento smussato.
7.4 La disoccupazione keynesiana
Nel caso di disoccupazione keynesiana vi è un eccesso di offerta potenziale di beni rispetto alla domanda. I meccanismi che generano disoccupazione “keynesiana” sono quelli evidenziati da Keynes nella Teoria generale, che sono stati analizzati nel capitolo 3.
Se il volume di consumi e investimenti è tale da creare una domanda effettiva insufficiente, la domanda di lavoro risulta inferiore all’offerta di lavoro disponibile al salario reale vigente. Infatti, se le imprese non riescono a vendere tutto ciò che possono produrre, si genera disoccupazione causata dalla carenza di domanda di beni; si può dunque creare una situazione in cui vi sono lavoratori disposti a lavorare al salario corrente che non trovano lavoro a causa della carenza di domanda. Le aspettative degli imprenditori rivestono un ruolo fondamentale nella determinazione del livello di occupazione. Se la capacità produttiva non viene pienamente utilizzata perché gli imprenditori non si aspettano di vendere tutte le merci che sono in grado di produrre, si determina una situazione in cui il livello di attività è più basso di quello potenziale e c’è disoccupazione involontaria. La presenza di disoccupati e quindi di un livello di domanda minore rispetto a quella che si determinerebbe in una situazione di piena occupazione può generare a sua volta una riduzione del livello di attività economica e il sistema si può trovare a lungo intrappolato in una situazione di equilibrio di sottoccupazione senza che entrino in gioco meccanismi automatici per riportare il sistema alla piena occupazione.
La disoccupazione keynesiana deriva dunque da insufficienza di domanda effettiva. Partendo da una situazione di piena occupazione essa, come noto, può insorgere a causa del rallentamento di una componente della domanda: investimenti, spesa autonoma, consumi, domanda estera. Certamente è disoccupazione keynesiana quella che emerge nelle fasi congiunturali negative e il segnale con cui inizialmente si manifesta è un calo degli ordinativi ricevuti dalle imprese.
C’è una causa di disoccupazione keynesiana che oggi è opportuno considerare con particolare attenzione ed è la crescita della produttività del lavoro non associata ad un corrispondente aumento dei salari. Le innovazioni tecnologiche che comportano l’introduzione di tecnologie labour-saving sono causa di un aumento della produttività e quindi, a parità di output, diminuisce la domanda di lavoro: si determina, in altre parole, la cosiddetta “disoccupazione tecnologica”. Si tratta di un fenomeno particolarmente evidente nelle grandi imprese del settore industriale, ma anche in alcuni comparti del terziario avanzato, che ha causato un netto ridimensionamento dell’occupazione. Esistono ovviamente elementi che possono contrastare tale tendenza; tuttavia è importante tenere conto del fatto che la diminuzione della domanda di lavoro comporta non solo una redistribuzione del reddito a svantaggio dei lavoratori, ma anche una diminuzione della produzione causata dalla diminuzione della domanda dei salariati, dato che la propensione marginale al consumo è più alta per i salariati che per gli altri percettori di reddito. Come conseguenza si riduce la domanda e quindi la produzione.
Si noti che oggi la crescente mobilità del lavoro e l’utilizzo crescente di contratti a tempo determinato indeboliscono nettamente questo approccio.
Chi ha familiarità con la teoria dei “costi di menu” noterà una evidente analogia. Si noti comunque che la teoria dei contratti periodici è precedente a quella dei “costi di menu”, che può essere considerata una estensione della teoria dei contratti periodici.
R. Jackman “Money wage rigidity in an economy with rational trade unions” in G. Hutchinson and J. Treble (eds.) “Recent Advances in Labour Economics”, Croom Helm, London, 1984.
Un ottimo approfondimento di questo tema e una rassegna dell’evidenza empirica su flessibilità salariale e occupazione si trova in M. Zenezini La disoccupazione immaginata, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997, capitolo 4.
Se il mercato dei beni fosse perfettamente concorrenziale il prezzo sarebbe determinato dal costo marginale; poiché si assume che le imprese abbiano un potere di mercato, il prezzo risulta superiore al costo. Non ci soffermeremo in questa sede sull’analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi in regime di concorrenza imperfetta. Ricordiamo che comunque l’evidenza empirica mostra che in concorrenza imperfetta i prezzi risultano poco sensibili a variazioni della domanda.
In questo si distacca anche dalla tradizione keynesiana, secondo cui tali rigidità e imperfezioni vengono assunte sulla base dell’evidenza empirica.
Il suo contributo principale è: E. Malinvaud, The theory of unemployment reconsidered, Basil Blackwell Publisher 1977, trad. italiana La teoria della disoccupazione, Liguori editore, Napoli, 1987.
Per semplicità faremo l’assunzione di prezzi fissi, ma l’equilibrio con razionamento può essere definito anche per situazioni in cui i prezzi non sono fissi, ma semplicemente soggetti a vincoli.
Per equilibrio walrasiano, o equilibrio economico generale, si intende la condizione di un sistema economico in cui i prezzi assicurano l’uguaglianza fra domanda e offerta in tutti i mercati; in tale situazione sia i consumatori che i produttori non hanno alcun interesse a modificare la propria posizione sui diversi mercati.
Le politiche necessarie per contrastare la disoccupazione keynesiana sono le tipiche politiche macroeconomiche espansive (aumento della domanda pubblica di beni e servizi, riduzione delle imposte, aumento dei trasferimenti alle famiglie, abbassamento del tasso di interesse), ma anche gli strumenti di politica dei redditi e dei prezzi. Per esempio una politica di aumenti salariali ha un effetto di stimolo alla domanda di consumi grazie all’aumento del potere d’acquisto dei consumatori, specie se si considera che un aumento dei salari nominali, in presenza di rigidità dei prezzi, comporta una redistribuzione del reddito a favore dei salariati, che, come già detto, hanno una propensione al consumo più elevata degli altri percettori di reddito.
Viceversa in presenza di disoccupazione keynesiana, le politiche di contenimento dei salari quali quelle portate avanti con determinazione in vari paesi europei, in particolare in Italia, nell’ultimo decennio e spesso motivate dall’idea che un calo dei salari stimola la domanda di lavoro, hanno un effetto controproducente. Infatti una riduzione dei salari reali comporta una redistribuzione del reddito a danno dei lavoratori e a favore delle classi che hanno una minore propensione al consumo; dunque la riduzione dei salari comporta una riduzione della domanda effettiva. La sola motivazione a favore di un contenimento dei salari in presenza di disoccupazione keynesiana è legato alla domanda estera. Infatti una diminuzione dei salari e la conseguente riduzione dei costi potrebbe migliorare la competitività del paese e quindi potrebbe favorire una espansione della domanda aggregata, compensando l’effetto negativo sui consumi. Tale effetto positivo sulla domanda può essere realizzato solo se all’estero non si verifica un processo analogo di riduzione salariale. Inoltre deve essere valutato in relazione alla specializzazione produttiva del paese. Se guardiamo al caso italiano, è evidente che molte imprese producono beni in competizione con i paesi di nuova industrializzazione, dove il costo del lavoro è nettamente più basso; in tali settori una diminuzione del costo del lavoro non è dunque in grado di migliorare in modo significativo la competitività dell’industria italiana dato che, per quanto si comprima il costo del lavoro, non è pensabile di poter raggiungere i livelli salariali presenti in tali paesi.
7.5 La disoccupazione classica
La disoccupazione classica si manifesta in presenza di un eccesso di domanda di beni e di offerta di lavoro. Tale situazione può apparire poco probabile se si assume che la formazione dei prezzi avvenga in base alla regola del mark-up; se, infatti, gli imprenditori prevedono una domanda superiore all’offerta e ci sono lavoratori disoccupati, anche in presenza di costi crescenti possono aumentare la produzione, assumendo nuova forza lavoro e trasferire sui prezzi l’aumento dei costi. Tuttavia esiste la possibilità logica che le imprese non ritengano remunerativo assumere tutta la forza lavoro disponibile nonostante un eccesso di domanda dei loro prodotti. Ciò può verificarsi nel caso in cui le imprese producano utilizzando pienamente la capacità produttiva e che ci sia una forte complementarietà fra lavoro e capitale. In tale circostanza le imprese potrebbero ritenere non conveniente ampliare la capacità produttiva e occupare un maggior numero di lavoratori per far fronte all’eccesso di domanda. Tale situazione viene definita talora da Malinvaud “disoccupazione marxiana”, perché comporta l’esistenza di un esercito di riserva di lavoratori che risultano disoccupati a causa di un’insufficiente precedente accumulazione di capitale. In altri termini, se in un periodo di tempo prolungato la redditività è bassa o sono basse le aspettative di redditività, le imprese non assumono il rischio di ampliare la capacità produttiva che potrebbe rimanere poi inutilizzata; anzi spesso procedono ad una eliminazione prematura della capacità produttiva esistente. Ciò limita le possibilità produttive nel periodo successivo, rendendo elevato il costo variabile di una unità marginale di prodotto. Si noti che in economia aperta l’eccesso di domanda non si manifesta necessariamente in modo evidente come potrebbe avvenire in economia chiusa attraverso la competizione fra gli acquirenti, ma la mancanza di capacità produttiva si traduce in aumento della domanda di prodotti di importazione e quindi in un disavanzo della bilancia commerciale.
La disoccupazione classica è spesso generata dunque da una riduzione dei tassi di profitto che scoraggia gli investimenti. Nel caso di disoccupazione classica sono necessarie misure volte a stimolare investimenti che accrescano la capacità produttiva e la redditività. La moderazione salariale può favorire la ricostituzione dei profitti, il che può costituire una base per il rilancio degli investimenti e ciò permetterebbe col tempo un riassorbimento della disoccupazione. Questo punto di vista può essere riassunto con le parole di Helmut Schmidt, che fu cancelliere nella Repubblica Federale tedesca fra il 1972 e il 1982: “I profitti di oggi sono gli investimenti di domani e gli investimenti di domani creano l’occupazione di dopodomani”. Tuttavia, come si vedrà in seguito, tale proposizione non può essere data per scontata, dato che una politica di moderazione salariale può generare disoccupazione keynesiana per insufficienza di domanda e, in tal caso, le imprese non sono certo incentivate a investire in nuova capacità che potrebbe rimanere inutilizzata.
Tipiche cause della disoccupazione classica sono gli shock negativi dal lato dell’offerta; tali shock si manifestano attraverso una riduzione del prodotto ottenuto a parità di spesa per l’acquisto dei fattori produttivi. Perturbazioni di questo genere si sono verificate verso la fine degli anni sessanta a causa della rapida crescita dei salari e successivamente negli anni settanta e ottanta in seguito alle due crisi petrolifere. Ma la disoccupazione classica può essere generata anche da cause che si manifestano in modo graduale. Per esempio, ed è quanto è avvenuto in Italia nell’ultimo quarto di secolo, può determinarsi una insufficienza di importanti fattori come la carenza di infrastrutture, la mancanza di capacità imprenditoriale, l’insufficienza delle risorse destinate alla ricerca che non consentono un adeguato sviluppo degli investimenti volti ad ampliare la capacità produttiva.
7.6 Disoccupazione settoriale
Nella realtà risulta piuttosto complesso distinguere fra disoccupazione classica e disoccupazione keynesiana, perché una grande varietà di situazioni coesistono nello stesso paese. Quasi sempre esistono settori caratterizzati dalla presenza di disoccupazione classica, in cui vi sono imprese che si trovano nella situazione di non poter soddisfare la domanda per mancanza di capacità produttiva e nello stesso tempo lavoratori che potrebbero essere occupati in tali imprese e che invece rimangono disoccupati. Ma contemporaneamente ci possono essere imprese che non utilizzano appieno la capacità produttiva per carenza di domanda. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che non si possono accoppiare mercato del lavoro e mercato dei beni; esiste infatti una notevole mobilità della manodopera non specializzata, che può spostarsi da un settore all’altro senza problemi, mentre l’offerta di lavoro altamente specializzato è spesso legato a settori specifici. Dunque la presenza di squilibri non è la stessa in tutti i settori e normalmente disoccupazione classica, disoccupazione keynesiana e inflazione repressa sono presenti contemporaneamente in una stessa economia, ma in proporzioni differenti. E’ dunque importante identificare quali sono le proporzioni di questi tre regimi. E’ possibile individuare quale tipo di regime è prevalente o se esistono situazioni in cui c’è un bilanciamento fra due dei tre regimi, analizzando gli indicatori di razionamento, quali il tasso di disoccupazione e il grado di utilizzo della capacità produttiva, nonché la reattività della disoccupazione a variazioni del costo del lavoro.
E’ importante tenere presente che ogni settore ha caratteristiche proprie, ma che contemporaneamente tutti i settori sono interessati dall’attività economica nel suo complesso. Le imprese che sono vincolate da carenza di domanda e quelle che sono vincolate da carenza di capacità produttiva si comportano in modo diverso, almeno per quanto riguarda gli investimenti, ma la differenza può essere meno definita di quanto ci si potrebbe aspettare, dato il ruolo che le aspettative hanno sugli investimenti. Le aspettative, infatti, sono legate non solo all’andamento delle variabili di settore ma anche all’andamento delle variabili macroeconomiche.
7.7 Al di là del breve periodo
Guardando al di là del breve periodo, è necessario considerare la flessibilità di prezzi e salari nominali, tenendo conto che prezzi e salari sono più flessibili verso l’alto che verso il basso; è realistico inoltre assumere che la velocità di aggiustamento dei salari è più lenta di quella dei prezzi.
In caso di inflazione repressa, l’eccesso di domanda di beni e servizi e l’eccesso di domanda di lavoro comportano una tendenza all’aumento sia dei prezzi che dei salari nominali e quindi si determina una tendenza verso l’equilibrio walrasiano, anche se non si può escludere che sfoci in una situazione di disoccupazione classica o keynesiana, a seconda delle dinamiche di aggiustamento di prezzi e salari.
Nel caso di disoccupazione keynesiana l’eccesso di offerta sul mercato dei beni e sul mercato del lavoro fa sì che, in assenza di politiche correttive di sostegno alla domanda, la situazione di depressione tenda a persistere indefinitamente. Infatti la disoccupazione comporta una stagnazione dei salari monetari e quindi si protrae la situazione di carenza di domanda da parte dei salariati; la viscosità dei prezzi verso il basso a sua volta non permette un aumento del potere d’acquisto, per cui le imprese si trovano vincolate dalla domanda e quindi non aumentano la produzione e l’occupazione. Ma se anche prezzi e salari fossero flessibili verso il basso l’aumento del potere d’acquisto dei salari (e quindi la crescita della domanda da parte dei salariati) sarebbe controbilanciato dalle aspettative negative e dai fallimenti provocati della diminuzione dei prezzi.
Mentre l’economia può rimanere intrappolata a lungo in una situazione di disoccupazione keynesiana, in teoria la disoccupazione classica è un fenomeno transitorio. Se infatti c’è disoccupazione e eccesso di domanda, i prezzi tendono a salire e quindi, se i salari nominali crescono meno dei prezzi, come è realistico assumere in presenza di disoccupazione, i salari reali tendono a scendere; ciò dovrebbe ripristinare la redditività delle imprese e indurre a fare nuovi investimenti , il che dovrebbe comportare una crescita dell’occupazione. Tuttavia bisogna tenere conto che la costruzione di nuova capacità produttiva non è un processo istantaneo, ma può richiedere molto tempo. Inoltre non è detto che la disoccupazione si risolva con una situazione di pieno impiego; in realtà è plausibile ritenere che la disoccupazione classica sfoci in disoccupazione keynesiana prima che si sia ripristinata la piena occupazione. Infatti il livello insufficiente degli investimenti e l’elevato tasso di eliminazione della capacità produttiva esistente che derivano da una situazione di disoccupazione classica possono comportare una crescita della capacità produttiva troppo lenta rispetto alla crescita del potenziale produttivo della forza lavoro, per cui si entrerà in una fase di disoccupazione keynesiana.
Se la disoccupazione classica è stata causata da un costo del lavoro relativamente elevato rispetto al costo del capitale che ha comportato un livello troppo ridotto della profittabilità delle imprese, queste tendono non solo a limitare la costruzione di nuova capacità produttiva, ma anche ad introdurre tecnologie labour saving che, come si è visto, tendono a generare disoccupazione keynesiana che va a sostituirsi e, talora, ad aggiungersi alla preesistente disoccupazione classica.
7.8 La persistenza della disoccupazione
Il tema della persistenza della disoccupazione che dagli anni settanta affligge i paesi europei è stato ampiamente affrontato dagli economisti negli ultimi vent’anni e ha portato allo sviluppo di una vasta letteratura sulla persistenza della disoccupazione o “isteresi”. Come abbiamo visto nel capitolo 2, le principali spiegazioni dell'isteresi si rifanno essenzialmente a tre temi: a) le rigidità salariali, b) la perdita di competenze del capitale umano, c) l’erosione della capacità produttiva in seguito al rallentamento dell’attività economica.
La spiegazione dell’isteresi basata sull’erosione della capacità produttiva appare la più convincente, ma comunque non è esauriente. Se la persistenza della disoccupazione viene analizzata nell’ambito della teoria dell’equilibrio con razionamento, il fenomeno dell’isteresi appare più chiaro e l’erosione della capacità produttiva appare come un elemento della spiegazione dell’isteresi che deve essere comunque inquadrato in un approccio più generale. L’erosione della capacità produttiva non è che una manifestazione della disoccupazione classica. La persistenza di aree di disoccupazione classica sta diventando un fenomeno sempre più diffuso, perché deriva da una redditività degli investimenti troppo bassa rispetto a impieghi alternativi sui mercati internazionali. Ma questo non è che uno degli elementi che spiegano la persistenza; l’altro fattore di cui è necessario tenere conto è che la disoccupazione classica tende a sfociare in disoccupazione keynesiana e, come si è visto, nel caso di disoccupazione keynesiana, non esistono automatismi per riportare il sistema verso la piena occupazione. Quindi, in assenza di adeguate politiche economiche, la disoccupazione tende a diventare un fenomeno persistente. Analizzato in questa ottica appare evidente che l’isteresi non è un fenomeno anomalo, come viene considerato dalla letteratura sull’argomento, ma è il risultato di situazioni di disequilibrio che normalmente caratterizzano il sistema economico.
Come si vedrà più in dettaglio, i paesi industrializzati, in seguito agli shock dal lato dell’offerta degli anni settanta, hanno effettivamente conosciuto una fase di disoccupazione classica che è gradualmente sfociata in disoccupazione keynesiana. Le politiche economiche restrittive perseguite nella maggior parte dei paesi europei a partire dagli anni ottanta non hanno permesso il riassorbimento della disoccupazione. Negli anni novanta, poi, con la crescente integrazione commerciale e finanziaria, si sono allargate le aree di disoccupazione classica.
7.9 La disoccupazione in economia aperta
La teoria dell’equilibrio con razionamento è stata formulata negli anni settanta e ottanta quando il grado di liberalizzazione commerciale e finanziaria a livello internazionale non aveva ancora raggiunto i livelli attuali.
Oggi, in presenza di piena libertà di movimenti delle merci e dei capitali, dei crescenti processi di finanziarizzazione, della dimensione “globale” della concorrenza, il problema della disoccupazione appare più complesso e di più difficile soluzione. La teoria dell’equilibrio con razionamento continua a mantenere tutto il suo valore esplicativo, ma va integrata considerando il contesto internazionale. La strategia di investimento delle imprese deve tenere conto di variabili reali e finanziarie a livello mondiale in situazione di incertezza e di informazione incompleta e le scelte delle imprese sono quasi sempre irreversibili.
La possibilità di impieghi sui mercati finanziari internazionali in presenza di libertà di movimenti di capitali, che permettono di ottenere margini di guadagno superiori e meno dilazionati nel tempo rispetto agli investimenti in capacità produttiva, possono scoraggiare gli investimenti destinati all’aumento di attrezzature e macchinari, favorendo i movimenti di capitale finanziari. Ciò è tanto più plausibile quanto più sono incerte le aspettative di crescita della domanda.
La crescente tendenza a dislocare le attività produttive nei paesi meno industrializzati, per esempio quelli dell’Europa Orientale, limita la crescita della capacità produttiva nelle aree sviluppate in particolare nei settori che competono sul prezzo e utilizzano forza lavoro non qualificata. Tale tendenza si manifesta per due motivi: a) in tali mercati la dinamica della domanda è più sostenuta o comunque c’è l’aspettativa di un tasso di crescita della domanda più elevato rispetto alle economie più industrializzate, dato che si tratta di economie in espansione; è quindi strategicamente importante la presenza su tali mercati, b) i costi di produzione sono meno elevati rispetto alle economie più avanzate, grazie non solo ai salari più bassi, ma anche a normative più permissive riguardanti le norme di sicurezza e la tutela dell’ambiente e un carico fiscale molto più leggero.
La comparsa di disoccupazione classica appare dunque un evento più probabile che in passato: l’insufficiente accumulazione di capitale che genera disoccupazione classica può derivare da una redditività troppo bassa rispetto a impieghi alternativi all’estero.
Tuttavia, politiche di moderazione salariale possono avere un effetto estremamente limitato sull’occupazione nei settori caratterizzati da disoccupazione classica, mentre tendono ad accelerare la disoccupazione keynesiana. L’esigenza di comprimere i costi per far fronte alla competizione di imprese localizzate in paesi in cui il costo del lavoro è più basso può determinare l’obsolescenza delle tecnologie produttive esistenti e la loro sostituzione con tecnologie labour saving e ciò accade anche in presenza di salari reali stagnanti, dato che, per quanto si abbassi il costo del lavoro, non è pensabile abbassarli fino ai livelli dei paesi di nuova industrializzazione. Ciò è evidente soprattutto nei paesi le cui produzioni sono in concorrenza con quelle dei paesi emergenti. Si genera così disoccupazione keynesiana, che ha origine sia dall’introduzione di innovazioni volte a risparmiare l’utilizzo del lavoro, sia dalle politiche di contenimento dei salari, che frenano l’espansione della domanda.
E’ emblematico, a questo proposito, il caso italiano: una larga parte dell’industria italiana, non potendo contare su tecnologie avanzate, è specializzata nelle produzioni tradizionali, caratterizzate da una serrata concorrenza da parte dei paesi emergenti. Ciò ha creato una spinta a manovre volte alla liberalizzazione del mercato del lavoro e alla flessibilità dei salari, che di fatto hanno comportato una riduzione dei salari reali. Come risultato, in assenza di politiche espansive, si è creata insufficienza di domanda ed è cresciuta la disoccupazione keynesiana, che è andata ad aggiungersi alla disoccupazione classica.
In sintesi, in un contesto di crescente integrazione economica internazionale, i paesi industrializzati che, come l’Italia, non hanno saputo cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti tecnologici in atto e innovare l’apparato produttivo e impegnarsi in nuove produzioni, sono esposte in modo crescente a disoccupazione classica. Questa tende a essere persistente in certi settori mentre, attraverso le pressioni sui salari, determina disoccupazione keynesiana.
Ci si può chiedere a questo punto quali politiche possono essere perseguite in una situazione così complessa. Senza pretendere di offrire una soluzione, è possibile considerare alcune proposte.
Per incentivare l’aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da disoccupazione classica è necessario creare un clima favorevole agli investimenti e ciò non può essere fatto semplicemente attraverso misure volte ad aumentare la redditività delle imprese nel breve periodo, quali diminuzione delle imposte alle imprese, flessibilità del lavoro, contenimento dei salari. E’ importante invece creare infrastrutture e perseguire una politica industriale adeguata in grado di assicurare la redditività nel medio periodo. Fattori decisivi oggi sono la ricerca e la capacità di tradurre i suoi risultati in innovazioni vincenti; è necessaria a questo proposito una politica istituzionale in grado di incanalare le potenzialità occupazionali che derivano dalle nuove tecnologie. Non si deve trascurare, poi, come sottolinea anche Malinvaud, la riduzione dell’orario di lavoro che rappresenta uno strumento utile per alleviare il problema della disoccupazione di massa e contribuisce al progresso sociale. Infine, in presenza di disoccupazione keynesiana, non vanno trascurate le tradizionali politiche keynesiane di stimolo alla domanda.
Approfondimento
La disoccupazione in Italia alla luce della teoria dell’equilibrio con razionamento
Quando le performance del mercato del lavoro in Italia, come del resto negli altri paesi europei, sono confrontate con quella statunitense, le differenze sono normalmente spiegate in termini di rigidità vs. flessibilità. La rigidità del mercato europeo e il suo generoso sistema di welfare avrebbero generato disoccupazione e crescita lenta mentre la flessibilità del mercato del lavoro statunitense avrebbero consentito un rapido aumento della crescita e dell’occupazione crescente. Tale impostazione sarebbe convincente se la disoccupazione fosse esclusivamente classica, ma è fuorviante rispetto alle cause della disoccupazione europea attuale: infatti la deregolamentazione del mercato del lavoro e la riduzione del sistema di welfare che ha caratterizzato l’economia europea negli anni novanta non hanno attenuato il problema, anzi lo hanno accentuato, dato che hanno creato insicurezza e, di conseguenza, una contrazione dei consumi. Pertanto tale impostazione indica terapie che alla prova dei fatti si sono rivelate fallimentari e fornisce indicazioni di politica economica che rischiano di aggravare il problema anziché risolverlo. La teoria elaborata dell’equilibrio con razionamento può costituire uno strumento adeguato per interpretare le vicende reali dell’economia italiana e per fornire utili spunti per una corretta politica economica. Ripercorriamo dunque le note vicende che hanno caratterizzato la nostra economia dagli anni settanta alla luce di tale teoria.
L’Italia, come i principali paesi della UE, ha conosciuto un aumento del tasso di disoccupazione a partire dall’inizio degli anni settanta (vedi tabella 1). Gli shock salariali di fine anni sessanta e la prima crisi petrolifera (1973) hanno causato una diminuzione della redditività delle imprese, dando inizio a una fase di disoccupazione classica. Tale situazione era peraltro aggravata dal quadro generale di incertezza che derivava dal crollo del sistema di Bretton Woods (1971). L’entità di tale perturbazione non va tuttavia sopravalutata. Il tasso di disoccupazione rimaneva a livelli che oggi sarebbero considerati contenuti. In particolare in Italia il tasso di disoccupazione, che era sempre stato più elevato rispetto agli altri paesi della Comunità europea, è passato dal 5,1% del 1971 al 7,1% del 1980. Con i disordini dell’economia mondiale del 1971 e le crisi petrolifere si è avuta una diminuzione del tasso di crescita della produttività. Tale evento era in qualche modo prevedibile, dato che la produttività fino a quel momento era cresciuta a tassi particolarmente elevati. L’aggiustamento dei salari alle mutate condizioni economiche è avvenuto con un certo ritardo. Nel corso degli anni settanta, in Italia, come in altri paesi europei, i salari reali hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti: fino al 1977 sono cresciuti a un tasso superiore a quello della produttività del lavoro; è aumentato dunque il costo del lavoro per unità di prodotto, causando una diminuzione dei livelli di profitto delle imprese. In questo contesto è rallentata la crescita degli investimenti.
A partire dagli anni settanta, ma ancor più nel decennio successivo, le imprese italiane, in seguito alla diminuzione della redditività, hanno attuato ampie ristrutturazioni industriali, introducendo una serie di innovazioni di processo mentre sono stati limitati gli investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva. I processi di riorganizzazione e l’introduzione di tecnologie labour saving hanno prodotto, nel corso degli anni ottanta, una crescita piuttosto sostenuta della produttività del lavoro nel settore manifatturiero . Come conseguenza si è avuto un rallentamento della domanda di lavoro e una crescita del tasso di disoccupazione, contrariamente a quanto avrebbe previsto la teoria neoclassica. Con l’aumento della disoccupazione, la dinamica salariale è rallentata e si è ridotta la crescita della domanda di consumi (vedi tabella 2). Il quadro che emerge analizzando la situazione negli anni ottanta è dunque quello di una disoccupazione classica che sfocia in disoccupazione keynesiana a causa degli investimenti labour saving che hanno comportato una riduzione della domanda di lavoro, con domanda stagnante o comunque poco dinamica. Altri fattori, peraltro, hanno contribuito al deterioramento della situazione occupazionale. Nei primi anni ottanta l’economia italiana ha dovuto affrontare i problemi conseguenti alla politica monetaria restrittiva degli Stati Uniti, che ha provocato un rialzo dei tassi di interesse in Europa e influito ovviamente sul tasso di investimento. Alla fine degli anni ottanta la riunificazione tedesca ha portato a un rialzo dei tassi di interesse in Germania, trasmessi successivamente agli altri stati europei e negli anni '90 sono state intraprese politiche economiche fiscali restrittive per rispettare i vincoli imposti dagli accordi di Maastricht e dal patto di stabilità. L'effetto di questi eventi è stato un netto rallentamento del tasso di crescita dell'economia e un aumento della disoccupazione keynesiana.
Negli anni novanta si verifica un grave peggioramento della situazione (vedi tabella 1): diminuisce l’occupazione di circa il 4%, mentre il tasso di disoccupazione raggiunge quasi il 12% alla fine del decennio. In questo periodo si evidenzia nettamente una disoccupazione causata da carenza di domanda. Fra il 1991 e il 2000 scende il CLUP reale del 13,8%, calano anche i salari reali dello 0,1% . Il tasso di crescita della domanda è sceso in tutte le sue componenti (vedi tabella 2).
L’aumento della disoccupazione, che ha minato il potere contrattuale dei lavoratori determinando un ristagno dei salari reali, a sua volta ha causato una netta diminuzione del tasso di crescita dei consumi privati. Contemporaneamente scendeva drasticamente anche il tasso di crescita dei consumi pubblici, data la necessità di ridimensionare i disavanzi di bilancio pubblico al fine di rientrare nei parametri previsti dal trattato di Maastricht. In questa situazione le imprese si sono trovate vincolate dal lato della domanda e hanno limitato l'espansione della capacità produttiva.
Le misure di politica economica non hanno tenuto conto delle caratteristiche degli shock con cui si veniva di volta in volta confrontando l'economia; sono state perseguite infatti prevalentemente politiche che forse avrebbero potuto essere efficaci a fronte di shock di offerta quando ormai le perturbazioni dal lato dell'offerta erano superate e si evidenziava invece una crisi di domanda.
Sono state perseguite con determinazione politiche di flessibilizzazione del mercato del lavoro, che tendono ad avere effetti depressivi sulla domanda di consumi, perché accrescono l’incertezza delle famiglie.
Si è anche cercato, e tuttora si sta tentando, di perseguire politiche fiscali tendenti a consolidare i profitti delle imprese, per stimolare gli investimenti. Ma tali politiche, che avrebbero potuto avere un effetto in passato, sono oggi indebolite dalla piena liberalizzazione di movimenti di capitali, che si spostano là dove il rendimento è maggiore. La crescita dei profitti che si è realizzata negli ultimi anni, grazie sia alle politiche fiscali sia alla stagnazione dei salari non ha quindi comportato un'accelerazione dell'accumulazione di capitale. Peraltro il contenimento del tasso di crescita dei salari ha causato, come si è visto, un rallentamento della crescita della domanda; le aspettative negative sull’andamento della domanda hanno ovviamente scoraggiato gli investimenti.
La presenza evidente di disoccupazione keynesiana non è in contrasto con la tesi, già sostenuta da Malinvaud alla fine degli anni settanta, secondo cui ha assunto un ruolo crescente la disoccupazione classica. In Italia in alcuni settori dell’industria la capacità produttiva è utilizzata a livelli prossimi al 100%. Evidentemente, data la situazione di incertezza e le basse prospettive di crescita, le imprese che operano in tali settori non ritengono remunerativo ampliare la capacità per far fronte all’eccesso di domanda che si è verificata in tali settori, eccesso di domanda che si traduce in un aumento delle importazioni.
Sorprendentemente, a differenza degli altri paesi europei, in tempi recenti, nonostante la stagnazione che ha investito la nostra economia, si è registrato un calo del tasso di disoccupazione, che nel gennaio 2004 è sceso all’8,7%. Questo evento, di per sé positivo, è associato a un dato piuttosto preoccupante: è diminuita la produttività del lavoro . Il calo del tasso di crescita della produttività è un fenomeno che ha toccato gran parte dei paesi industrializzati legato alla crescente terziarizzazione dell’economia. In molti settori del terziario, infatti, gli aumenti di produttività sono difficilmente realizzabili a causa della natura stessa del lavoro; si pensi per esempio ai lavori di assistenza e di cura, alla ricerca e sviluppo, al settore sanitario e alla formazione. L’aumento dell’offerta dei servizi forniti da questi settori impone necessariamente un aumento dei lavoratori occupati. Questo spiega l’aumento dell’intensità occupazionale della crescita nei paesi in cui aumenta il peso del terziario ed è in linea con quanto accaduto negli Stati Uniti nello scorso decennio . Ma, mentre un rallentamento del tasso di crescita della produttività è un fenomeno fisiologico in economie caratterizzate da una crescente terziarizzazione, il calo della produttività in Italia è allarmante ed è attribuibile al fatto che si è si è fortemente ridimensionata l’occupazione industriale, non solo in termini relativi : la crescita del settore manifatturiero è in netto declino, l’occupazione nelle grandi imprese continua a diminuire, si registra un calo della quota delle esportazioni italiane nel commercio mondiale. Una quota crescente di lavoratori viene assorbita in occupazioni che richiedono scarsa specializzazione, spesso precarie. Ciò ha consentito una lieve diminuzione del tasso di disoccupazione, ma il prezzo sembra molto elevato: precarizzazione, bassi salari, rallentamento dei consumi. Questo quadro sembra aprire la strada a una nuova crescita di disoccupazione keynesiana, se non verranno condotte politiche economiche adeguate. Infatti non si può pensare di sostenere la crescita dell’occupazione unicamente attraverso una diminuzione della produttività. E’ diffusa convinzione che sarebbe invece opportuno aumentare la competitività delle imprese attraverso maggiori investimenti in ricerca e in infrastrutture, e contemporaneamente portare avanti politiche di sostegno alla domanda.
Tabella 1 Indicatori economici dell’Italia – Il mercato del lavoro
Variazioni decennali di alcune variabili
1971-80 |
1981-90 |
1991-2000 |
|
Forza Lavoro |
+ 6,6 % |
+7,4% |
-4% |
Occupazione |
+4,1% |
+2,4% |
-4,1% |
Tasso di attività * |
+0,6 |
+0,5 |
-2,1 |
Tasso di occupazione * |
+0,7 |
-2,3 |
-1,9 |
Tasso di disoccupazione * |
+2,0 |
+1,5 |
+2,2 |
CLUP reale |
0 |
-7,6% |
-13,8% |
Produttività del lavoro |
+26,8% |
+16,9% |
+15,7% |
Salari reali |
+27,8% |
+4,2% |
-0,1% |
* Variazione espressa in punti percentuali
Fonti: OECD, Eurostat, Istat
Tabella 2 Indicatori economici dell’Italia – Componenti della domanda
Tasso di crescita medio annuo
|
1973-79 |
1979-89 |
1989-2000 |
Consumi privati |
4,3 |
3,4 |
1,9 |
Spese delle Amministrazioni pubbliche |
2,7 |
2,7 |
0,5 |
Investimenti fissi totali |
1,3 |
2,3 |
2,0 |
Costruzioni |
-0,8 |
0,4 |
0,4 |
Macchine e attrezzature |
5,1 |
4,8 |
3,3 |
Variazione delle scorte |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
Totale domanda interna |
3,5 |
3,1 |
1,6 |
Esportazioni nette |
0,6 |
-0,3 |
0,2 |
Esportazioni di beni e servizi |
8,0 |
3,4 |
6,1 |
Importazioni di beni e servizi |
4,8 |
5,7 |
5,8 |
PIL ai prezzi di mercato |
4,0 |
2,7 |
1,7 |
Fonte: OECD
Capitolo 8
I sistemi di relazioni industriali e il ruolo dei sindacati
Una parte considerevole della letteratura economica considera il sindacato come un elemento di disturbo, che impedisce il libero funzionamento del mercato del lavoro, contribuisce a mantenere i salari al di sopra del loro livello di equilibrio ed è quindi responsabile della disoccupazione. In questo capitolo vedremo che le organizzazioni sindacali hanno un ruolo complesso non riconducibile a semplice rivendicazioni economiche di breve periodo e che possono in larga misura contribuire alla stabilità dell’occupazione e alla determinazione degli equilibri macroeconomici.
8.1 Il sistema di relazioni industriali
Il sistema di relazioni industriali è quell’insieme di relazioni che regolano i rapporti fra imprese e loro organizzazioni da un lato e lavoratori e sindacati dall’altro. La contrattazione collettiva rappresenta lo strumento principale attraverso cui i rapporti di lavoro vengono regolamentati congiuntamente da sindacato e imprese, talora con la presenza dello stato in funzione di mediatore. All’interno del sistema di contrattazione collettiva si inserisce il sistema di contrattazione salariale che può essere definito come il complesso di procedure, leggi e istituzioni che regolano la determinazione dei salari.
Nelle moderne economie occidentali troviamo modelli di contrattazione sensibilmente diversi. Le caratteristiche del sistema di relazioni industriali variano da paese a paese in quanto dipendono dalla storia e dalle caratteristiche del paese, dall’organizzazione delle parti sociali e dalla matrice politica ed ideologica di queste ultime. Il modello di relazioni industriali adottato in ciascun paese ha effetti importanti sull’equità distributiva, sull’efficienza e anche sul livello dell’occupazione.
Nel corso degli ultimi vent’anni c’è stato un ampio dibattito fra gli economisti sull’impatto dei modelli di relazioni industriali sull’occupazione e sul sistema economico nel complesso. Tale dibattito risulta spesso influenzato da situazioni contingenti. Quando un paese o un gruppo di paesi mostra una buona performance occupazionale, gli studiosi evidenziano come il sistema di relazioni industriali dei paesi considerati abbia contribuito ai successi ottenuti; se le cose cambiano e si configurano situazioni occupazionali migliori in paesi caratterizzati da sistemi di relazioni industriali differenti, molti “esperti” cominciano a sottolineare i difetti dei sistemi che non danno più i risultati migliori e i pregi di quelli che hanno ottenuto buoni risultati. In realtà molti fattori concorrono a determinare la situazione occupazionale di un paese e il sistema di relazioni industriali può giocare un ruolo importante ma non decisivo. Per poter verificare effettivamente l’impatto dei sistemi di relazioni industriali sull’occupazione e sulla crescita occorre valutarne i risultati nel lungo periodo, ponendo una particolare attenzione alle fasi congiunturali negative. E’ in questi periodi infatti che è possibile valutare la solidità di un impianto di relazioni industriali senza che l’analisi sia deviata da dati contingenti.
Il neocorporativismo è sembrato a molti un ottimo sistema per combattere l’inflazione e tenere conto delle compatibilità macroeconomiche negli anni 70. Tale sistema di relazioni industriali si è sviluppato principalmente in Austria e nei paesi del nord Europa ed è basato su un sistema di contrattazione coordinata e centralizzata e sul coinvolgimento di sindacati e associazioni imprenditoriali e, nella maggior parte dei casi, anche dello stato nelle decisioni di politica economica e industriale. I sistemi neo-corporativi continuano a dimostrare buoni risultati in termini occupazionali. Si pensi che dal 1970 ad oggi il tasso di disoccupazione in Austria ha raggiunto un picco massimo del 5%. Nei paesi nordici in cui vige un sistema neocorporativo (soprattutto in Svezia e in Danimarca) la crisi occupazionale della prima metà degli anni novanta è stata superata con maggior successo rispetto agli altri paesi europei.
Una notevole attenzione negli anni ottanta è stata rivolta al sistema di relazioni industriali giapponese che sembrava garantire una crescita stabile e un tasso di disoccupazione estremamente ridotto grazie a un serie di fattori quali l’impiego a vita, le relazioni personalizzate all’interno dell’impresa, la compartecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa, i differenziali salariali limitati, le forti connotazioni redistributive nel sistema di welfare. Anche il sistema giapponese sembra essere in grado di salvaguardare l’occupazione anche in fasi congiunturali negative; basti pensare che, nonostante la profonda crisi che ha coinvolto l’economia giapponese dall’inizio degli anni novanta, il tasso di disoccupazione continua a mantenersi sotto il 6%.
Sempre negli anni ottanta in Germania il cosiddetto modello renano sembrava assicurare stabilità e occupazione e veniva considerato un caso esemplare per la sua capacità di far fronte alle recessione economica. Il modello tedesco si basa su un sistema di leggi che regolano le relazioni fra proprietari, dirigenti e lavoratori; il sistema riesce a bilanciare le esigenze dei dipendenti con quelle degli azionisti, costringendo i managers a mediare fra le diverse esigenze attraverso gli strumenti della cogestione di impresa e il vincolo di rispettare i salari contrattati a livello di categoria. Ma dagli anni novanta la Germania è stata investita da una crisi occupazionale e si sono così posti dubbi sulla sostenibilità del modello tedesco.
I problemi occupazionali e il rallentamento nel tasso di crescita in molti paesi europei e la crisi del Giappone hanno provocato il rifiuto dei modelli cooperativi da parte di molti studiosi e politici. Negli anni duemila, grazie alla buona performance dell’economia statunitense, è entrato in auge il modello americano della deregulation e della flessibilità, in cui la soluzione dei conflitti fra lavoratori e capitalisti è demandata al mercato, anche se viene riconosciuto che tale modello comporta un aumento crescente delle sperequazioni. Recentemente numerosi studiosi hanno sottolineano i numerosi fallimenti del mercato del lavoro e si chiedono se non sia il caso di introdurre nei paesi fortemente deregolamentati nuove forme di regolazione nei rapporti di lavoro e nelle relazioni industriali. Ma fino allo scoppio della crisi non solo negli Stati Uniti le spinte neoliberiste sono state sempre più accentuate, ma anche l’Unione Europea ha proposto un modello di deregulation parzialmente mitigato da correttivi che permettano di conservare parzialmente il welfare state.
8.2 Il sindacato
Il sindacato è un’istituzione che nasce come risposta al conflitto fra lavoratori salariati e capitalisti nella società industriale.
Alla nascita del capitalismo, le condizioni di lavoro della classe operaia erano durissime: orari di lavoro eccessivi, salari molto bassi, instabilità del posto di lavoro, utilizzo del lavoro minorile, mancanza di ogni tipo di tutela per i lavoratori. Mancava qualsiasi tipo di regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro ed erano vietate le forme di organizzazione collettiva dei lavoratori.
Val la pena ricordare che nel 1791, nella Francia rivoluzionaria, sulla base di un principio di individualismo radicale, venne votato il divieto di sciopero, di organizzazione collettiva dei lavoratori e di costituzione di associazioni operaie. Tale concezione si appellava ai principi di libertà e uguaglianza; in realtà il sindacato avrebbe dovuto rientrare nell’idea del terzo principio della rivoluzione francese, quello di fraternità, ma la fraternità veniva concepita in un ambito nazionale e non come solidarietà nell’ambito del lavoro. Il sindacato era invece considerato come un retaggio medievale, alla stregua delle istituzioni di tipo corporativo che rappresentavano i mestieri e ne garantivano i privilegi; era visto dunque come un elemento di conservazione, un’eredità della società pre-capitalistica da abolire.
In genere, il pensiero liberale del XVIII secolo ha ostacolato l’azione sindacale sulla base di un’idea di sviluppo del mercato fondata su una concezione individualistica; il sindacato rappresenta invece una sorta di rifiuto dell’individualismo, perché si richiama all’appartenenza sociale e ai principi di solidarietà. Il pensiero liberale lo ha considerato come elemento di conservazione e un ostacolo al libero funzionamento del mercato, lo ha trattato come un’istituzione tipica della società pre-capitalistica, assimilandolo alle corporazioni. In realtà il sindacato moderno, nato nella società industriale, non può essere considerato in un’ottica di continuità storica con le corporazioni mercantili o artigiane tipiche della società pre-capitalistica, la cui funzione era quella di proteggere gli interessi degli operatori in determinati settori produttivi e commerciali.
Solo dopo anni di lotte, scontri e tensioni fra datori di lavoro e salariati le coalizioni operaie ottennero un riconoscimento. Le Trade Unions , nate in Gran Bretagna dopo l’abolizione del divieto di sciopero e di associazione nel 1824, costituiscono la prima forma di moderno sindacato impegnato nella contrattazione delle condizioni di lavoro.
Nel corso del tempo e, in particolare, nella seconda metà del secolo scorso si sono consolidati i processi di regolamentazione del lavoro in forma collettiva attraverso la contrattazione fra sindacati e datori di lavoro. Non si devono considerare scontati i diritti acquisiti dai lavoratori, anzi in tempi recenti sembra essersi verificato un arretramento in Italia, come in altri paesi industrializzati. In effetti, il pensiero liberista, che oggi tende a essere dominante, considera il sindacato come elemento di disturbo del libero mercato e come causa della disoccupazione.
Come si è visto, una delle spiegazioni ricorrenti delle cause della disoccupazione è la mancanza di flessibilità del mercato del lavoro e la rigidità dei salari, che sarebbero ostacolate dall’azione dei sindacati. Da tale impostazione derivano indicazioni di politica economica rivolte alla deregolamentazione del mercato del lavoro e di riduzione del potere sindacale. Tale approccio si basa sull’ipotesi che il sindacato detenga un potere monopolistico, di cui si serve per portare il salario dei suoi membri al di sopra del valore di equilibrio di piena occupazione, causando perciò disoccupazione. Di conseguenza un indebolimento dei sindacati aumenterebbe l’efficienza economica e ridurrebbe la disoccupazione. L’indebolimento dei sindacati negli ultimi vent’anni in numerosi paesi sembra contraddire questa ipotesi, dato che la disoccupazione ha continuato a crescere. Ma, al di là dell’evidenza empirica, questo approccio manca anche di una base teorica convincente, in quanto assume che i sindacati detengano un potere monopolistico in un sistema di imprese concorrenziale, dove non esiste incertezza e l’informazione è perfetta. Se le condizioni fossero davvero queste, effettivamente il sindacato giocherebbe un ruolo distorsivo della concorrenza. Ma la realtà è profondamente diversa. Ed era diversa già agli albori della società industriale, come dimostra la citazione di Adam Smith riportata nel riquadro a fine capitolo.
Se guardiamo al sindacato oggi, è evidente che esso ha un ruolo complesso, certamente non riconducibile a una mera funzione conservatrice volta a ostacolare il funzionamento del mercato; anzi, può essere portatore di istanze innovative. Tuttavia senza dubbio il sindacato ha anche un ruolo di protezione dei lavoratori dal libero funzionamento del mercato del lavoro, in quanto ha una funzione di difesa dei diritti dei lavoratori, esercita una funzione di riequilibrio nei rapporti di forza fra imprenditori e lavoratori, mette i lavoratori al riparo dalla concorrenza di altri lavoratori ed è portare di principi di solidarietà. In ogni caso non si può considerare genericamente il sindacato come un’organizzazione con fini puramente economici, né la contrattazione collettiva può essere vista come un’istituzione solo economica.
Esistono tuttavia diversi tipi di sindacati, alcuni agiscono in un’ottica prettamente economica di breve periodo, altri hanno una prospettiva di lungo periodo e fini non strettamente economici. In prima approssimazione, possiamo distinguere fra due tipi di sindacalismo: il business unionism o sindacalismo negoziale il competitive unionism o sindacalismo competitivo.
Il sindacalismo negoziale privilegia gli obiettivi economici, opera prevalentemente a livello aziendale e tende a non avere rapporti se non occasionali con le istituzioni politiche. Tale forma di sindacalismo è presente soprattutto nell’esperienza statunitense.
Il sindacalismo competitivo si muove con obiettivi che vanno al di là del fine strettamente economico, si occupa di temi di carattere economico-sociale, ha spesso legami forti con i partiti politici, anche se tali legami non si concretizzano in rapporti di dipendenza. Una variante del sindacalismo competitivo è il sindacalismo partecipativo, che contraddistingue i sistemi neo-corporativi , quei sistemi cioè in cui le relazioni industriali sono caratterizzate da relazioni partecipative e collaborative, e spesso sono di tipo tripartito, coinvolgono cioè governo, sindacato e imprese.
Il sindacalismo competitivo ha contraddistinto lo sviluppo del sindacato nel xx° secolo, soprattutto in Europa, per cui è a questo modello che faremo riferimento parlando di sindacato
A partire dal secondo dopoguerra, e in particolare negli ultimi trent’anni, i sindacati, almeno nei paesi europei, hanno dimostrato di essere interessati ad obiettivi di lungo periodo e di interesse generale e non possono dunque essere considerati portatori solo di interessi particolari che distorcono il funzionamento dell’economia. Data la condizione di debolezza del singolo lavoratore di fronte all’impresa, la presenza del sindacato contribuisce a creare un equilibrio fra le controparti. In una situazione di incertezza, il sindacato può avere un ruolo stabilizzante che aumenta l’efficienza del sistema economico. L’azione sindacale, infatti, riduce l’incertezza dei lavoratori; senza l’intervento dei sindacati i lavoratori non troverebbero protezione dai licenziamenti ingiusti, non sarebbero tutelati e si troverebbero in condizioni di perenne insicurezza. Ciò avrebbe un effetto depressivo sui consumi, e quindi sulla domanda aggregata e sull’occupazione, perché i lavoratori sarebbero indotti dall’incertezza ad incrementare i risparmi per far fronte al rischio di diminuzione dei redditi futuri o a periodi di disoccupazione.
I sindacati hanno inoltre un importante ruolo nell’equità distributiva, in quanto mirano a garantire un’efficiente ed equa distribuzione dei risultati dell’attività produttiva e degli aumenti di produttività del lavoro fra imprenditori e lavoratori. I sindacati possono anche avere un ruolo sociale, poiché contribuiscono a evitare o, almeno, a limitare situazioni di marginalità di alcune componenti della forza lavoro. Va sottolineata infine la funzione democratica dei sindacati, che consentono una rappresentanza ai lavoratori.
Come si vedrà più avanti, i sindacati si sono notevolmente indeboliti negli ultimi decenni. Tale indebolimento non ha certo avuto un effetto positivo sull’economia. La situazione di maggiore incertezza che si è venuta a creare ha determinato un ristagno dei consumi e della domanda. Le imprese, a fronte di una controparte più debole, hanno perseguito strategie volte a una competizione basate sulla riduzione del costo del lavoro trascurando i processi innovativi, col risultato di perdere posizioni concorrenziali sui mercati internazionali. Viceversa, nelle situazioni in cui il sindacato è forte e particolarmente rivendicativo le imprese tendono a introdurre innovazioni labour saving, attraverso cui si consolidano i processi di modernizzazione dell’apparato produttivo. Dunque, anche se indirettamente, il sindacato ha un ruolo fondamentale di stimolo al progresso tecnologico e all’innovazione.
8.3 Le relazioni industriali in Italia: dal dopoguerra alla crisi del petrolio
In Italia, il regime fascista ha represso totalmente le organizzazioni e le libertà sindacali, riconoscendo solo le corporazioni, organizzazioni direttamente espresse dal regime e sottoposte al controllo statale. Il sindacalismo democratico si ricostruì con il Patto di Roma (3 giugno 1944), in cui si decise di dar vita a un’unica organizzazione sindacale, la Confederazione Generale del Lavoro (CGL).
Nell’immediato dopoguerra vennero prese le decisioni di politica economica che avrebbero orientato lo sviluppo dell’economia italiana, in particolare si decise di inserire la nostra economia nel sistema europeo, affidando un ruolo centrale all’industria esportatrice. A livello sindacale prevalse un orientamento di tipo rivendicativo, volto a migliorare le condizioni di lavoro e dei salari. Il sindacato accettò la linea imprenditoriale secondo cui i salari dovevano essere contenuti e il loro potere d’acquisto poteva essere protetto attraverso un contenimento dell’inflazione. Prevalse una linea di centralizzazione delle trattative, secondo il principio che questa costituiva uno strumento di uguaglianza e di forza dei lavoratori, e tale linea venne perseguita con determinazione, per cui venne frenato qualsiasi tentativo di contrattazione articolata su base aziendale o locale. Questa strategia permise così al governo di controllare tutti i lavoratori attraverso le trattative con il sindacato.
Nel 1946, in seguito all’accordo fra Confindustria e CGL, ebbe legalmente termine il blocco dei licenziamenti, ottenuto sull’onda della preponderanza operaia nell’insurrezione del 25 aprile. L’applicazione del blocco dei licenziamenti però in pratica continuò anche nel corso del 1947, specie in quelle fabbriche ove la combattività operaia risultava maggiore. La minaccia della disoccupazione pesò però in modo decisivo sull’azione sindacale. Altri accordi del dopoguerra sancirono la reintroduzione del cottimo, che era scomparso dalla Liberazione. Nell’autunno del 1946 il sindacato, per timore dell’inflazione e per sostenere la ripresa produttiva, firmò anche gli accordi per una tregua salariale di sei mesi, prorogata per altri sei mesi nel maggio del 1947. L’unico vero successo di quegli anni fu l’introduzione dell’indennità di contingenza, la cosiddetta scala mobile , per l’adeguamento automatico, anche se parziale, dei salari al costo della vita. Tale meccanismo prevedeva scatti di valore diverso a seconda di categoria, qualifica, età, sesso e zona geografica.
Lo sblocco dei licenziamenti trovò attuazione in concomitanza con la stretta creditizia attuata alla fine del 1947; il tasso di disoccupazione, l'anno successivo, crebbe fino a sfiorare il 20 per cento. Con il consolidamento della linea politica moderata frutto della vittoria della Democrazia Cristiana nel 1948, l’azione sindacale venne confinata entro un ambito sempre più ristretto.
Nel 1948 le correnti democristiana e socialdemocratica uscirono dalla CGL e diedero vita nel 1950 alla CISL e alla UIL. La rottura dell’unità sindacale fu determinata dallo sciopero della componente comunista per l’attentato al segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti, scelta non condivisa dalle componenti democristiana e socialdemocratica, ma certamente esistevano cause più profonde di dissenso fra le varie componenti sindacali.
Dopo il 1951 l’Italia conobbe uno sviluppo sostenuto, caratterizzato da una rapida espansione dell’industria e una contrazione del settore agricolo. I settori più dinamici furono quelli orientati verso le esportazioni, in particolare autoveicoli, gomma, elettrodomestici, mobili per ufficio, alcuni comparti dell’abbigliamento. Lo sviluppo di tali settori venne favorito dall’installazione di impianti di grandi dimensioni e dall’utilizzo di tecnologie moderne. Si trattava però di settori in cui l’occupazione mostrava bassi tassi di crescita, dato che nei settori dinamici dell’economia gli investimenti erano finalizzati più alla crescita della produttività che non dell’occupazione. La forza lavoro disoccupata venne parzialmente assorbita in un primo tempo dall’agricoltura e poi, con l’inizio dell’esodo dalle campagne, nell’edilizia, nel commercio e nella pubblica amministrazione. Tuttavia anche questi settori non erano in grado di assorbire tutta la forza lavoro disponibile per cui si verificarono notevoli flussi migratori verso l’estero. In questa situazione, la forza rivendicativa dei sindacati era necessariamente limitata, per cui la quota di reddito nazionale destinata ai salari è andata decrescendo per tutti gli anni cinquanta. Ciò non significa una caduta dei salari, bensì una crescita dei salari inferiore a quella dei profitti. La debolezza dei lavoratori si riscontrava soprattutto all’interno delle fabbriche: il controllo sui lavoratori avveniva non solo sul posto di lavoro, ma anche ella vita privata, per cui non fu infrequente il caso di licenziamenti per motivi politici.
La debolezza del sindacato negli anni cinquanta dipendeva anche dalle posizioni talora contrastanti dei diversi sindacati, dovute in larga misura ai loro legami con i partiti. Nella Cisl, legata alla Democrazia Cristiana, era prevalente la linea della contrattazione aziendale. La Cgil, legata al Partito Comunista, seguiva una linea fortemente accentratrice, che venne abbandonata in favore del decentramento delle trattative solo all’inizio degli anni sessanta.
Fino alla fine degli anni cinquanta, dunque, non vi furono rilevanti rivendicazioni di natura economica. Solo a partire dagli anni 59-60, con i grandi scioperi nazionali dell’industria, si concretizzarono le prime consistenti azioni sindacali rivendicative. Gli anni sessanta mostrano caratteristiche decisamente diverse rispetto al periodo precedente. Nel 1960-61 si registrò un rapido aumento dell’occupazione nelle regioni del Nord, che produsse una crescita dei salari. I sindacati mostrarono una forza crescente e si aprì un periodo di aspra conflittualità, caratterizzato da numerosi scioperi nell’industria manifatturiera; alle richieste di aumenti salariali cominciarono ad associarsi anche obiettivi di carattere normativo. Dal 1961 al 1963 la quota di reddito nazionale spettante a lavoratori dipendenti riprese a salire, recuperando in parte il terreno perso nel decennio precedente. La reazione imprenditoriale fu un aumento generale dei prezzi, a cui seguì una stretta creditizia, volta a contenere l’inflazione e il disavanzo commerciale. Si determinò così una caduta degli investimenti che portò con sé una notevole contrazione dell’occupazione. Ne seguì un forte indebolimento dei sindacati che ottennero miglioramenti salariali molto contenuti nei rinnovi dei contratti che seguirono la crisi del 1964-65. Nel corso della depressione avvenne una razionalizzazione produttiva, che implicò cambiamenti organizzativi, aumento dei ritmi lavorativi, uso degli straordinari e degli incentivi individuali. Ciò comportò un aumento della produttività in un situazione in cui gli investimenti erano modesti. I profitti ripresero a crescere più dei salari, per cui la redistribuzione del reddito a favore delle classi lavoratrici ottenuta con le lotte sindacali degli anni 1961-63 venne annullata. Nel 1966 iniziò una lenta ripresa.
Il 1969 fu un anno di svolta nella strategia sindacale; le trattative per il rinnovo dei contratti avvennero in un clima decisamente conflittuale. Nel 1969 la disoccupazione era ancora elevata anche perché i flussi migratori verso l’estero si stavano riducendo. Può stupire dunque il vigore delle lotte operaie nel cosiddetto “autunno caldo” del 1969. Va osservato però che i cambiamenti organizzativi attuati dopo la crisi avevano peggiorato le condizioni di lavoro all’interno delle fabbriche; contemporaneamente con la nuova ondata di migrazioni dal sud al nord nella seconda metà degli anni sessanta, peggiorava anche la qualità della vita dei lavoratori fuori dalla fabbrica, a causa dei problemi abitativi, delle carenze di trasporti, dell’insufficienza di scuole e della mancanza di posti negli ospedali; la situazione era particolarmente difficile nell’area del triangolo industriale, in cui era affluito un elevatissimo numero di emigranti dal meridione. Non a caso i lavoratori più accaniti in quel periodo furono proprio quelli immigrati dal sud, che si trovavano in condizioni estremamente disagiate. Anche gli obiettivi cambiarono rispetto al passato; le rivendicazioni non riguardavano solo l’aumento dei salari, ma anche aspetti normativi, quali la riduzione dei ritmi di lavoro, la limitazione della mobilità fra reparti (si tenga conto che la mobilità veniva spesso utilizzata in funzione antisindacale), restrizioni all’uso del cottimo e degli straordinari. Gli obiettivi di tipo normativo tendevano a partire “dal basso”, cioè direttamente dai lavoratori addetti a uno stesso impianto. Per tenere le fila della lotta operaia, i vertici sindacali avanzarono anche rivendicazioni di tipo sociale, gli “scioperi per le riforme”, cioè per la casa, per lo sviluppo del Mezzogiorno, per i trasporti urbani.
Questa citazione costituisce il punto di partenza per l’analisi contenuta in E. Malinvaud, Nuovi sviluppi della teoria economica della disoccupazione, in E.Malinvaud., Equilibrio intertemporale, ottimalità, occupazione, Il Mulino, Bologna 1990
Nell’ipotesi di rigidità dei salari reali, invece, anche la disoccupazione classica può diventare un fenomeno persistente. L‘aumento dei salari in linea con la crescita del livello dei prezzi può infatti impedire il ripristino di una condizione di profittabilità che consenta l’ampliamento della capacità produttiva.
E’ importante a questo proposito distinguere fra due casi. 1) y* < β N < d; se un aumento di y* più accelerato di β porterà in un primo tempo a y* = β N < d, in un secondo tempo si avrà y* = β N = d in seguito a un aumento dei prezzi. 2) y* < d < β N; se un aumento di y* più accelerato di d porterà a y* = d < β N si avrà una situazione di equilibrio di sottoccupazione. Questo caso fa sfociare la disoccupazione classica in quella keynesiana.
E’ emblematico, a questo proposito, il caso della Spagna: attraverso l’introduzione nel 1984 di numerose forme di contratti temporanei, a fine anni Ottanta faceva registrare il 30% di occupazione atipica. Dopo una prima fase (1986-90) di crescita occupazionale, si è registrato un tasso di disoccupazione stabile o crescente; dal 1997 sono state poste restrizioni al lavoro temporaneo e sono stati incentivati i passaggi dei lavoratori da temporanei a permanenti, per cui di fatto il mercato del lavoro spagnolo è diventato più rigido; a tale processo si è accompagnato un aumento dell’occupazione.
Nel periodo 1972-1991, la produttività del lavoro nell’industria in senso stretto è cresciuta in media del 4% annuo.
L’Italia è l’unico paese dalla UE in cui nel decennio 1991-2000 si verifica una diminuzione dei salari reali.
I settori con il maggior utilizzo della capacità produttiva (oltre il 99% nel 2000) sono: prodotti energetici, minerali non metalliferi, prodotti chimici e farmaceutici, prodotti in metallo, legno e mobili in legno, carta –stampa - editoria, gomma - materie plastiche.
Un altro fattore che può spiegare il calo del tasso di crescita della produttività del lavoro è l’aumento degli occupati a tempo parziale; tale aumento è stato tuttavia piuttosto contenuto e non può dunque essere considerato responsabile di un calo tanto significativo nel tasso di crescita della produttività.
In teoria si potrebbe pensare che le imprese scelgano tecniche a minore intensità di capitale a causa della diminuzione del costo relativo del lavoro, ma in realtà ciò non sembra essere accaduto, anzi si è accentuata l’intensità di capitale nelle produzioni manifatturiere.
Si aggiunge il prefisso “neo” al termine “corporativo” per distinguere le attuali esperienze partecipative, sviluppatesi in un contesto democratico dalle esperienze del corporativismo di tipo autoritario e fascista.
Il contenuto di questo e del prossimo paragrafo è basato principalmente sull’analisi di Augusto Graziani contenuta in vari suoi scritti. Si veda, ad esempio: A. Graziani Lo sviluppo dell’economia Italiana, Bollati Boringhieri, Torino, 1998
Gli esiti delle lotte dell’autunno caldo sono stati diversi a seconda degli obiettivi. Molte rivendicazioni i tipo normativo ebbero successo: venne limitata la mobilità del lavoro, furono abolite le “gabbie salariali” , vennero concesse ai lavoratori dell’industria 150 ore annuali per attività formative. Queste conquiste sfociarono nell’emanazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori (1970). Con lo Statuto dei lavoratori vennero sanciti i diritti all’opinione politica e sindacale, all’assemblea nei luoghi di lavoro, i diritti di partecipazione e di organizzazione sindacale in fabbrica e, col famoso articolo 18, il diritto al ripristino del rapporto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. Anche le rivendicazioni salariali ebbero un notevole successo. Le lotte per le riforme ebbero invece un esito più incerto e più diluito nel tempo.
La strategia imprenditoriale all’autunno caldo fu un processo di ristrutturazione attuato non solo all’interno delle fabbriche, ma soprattutto attraverso una strategia di decentramento produttivo. Nei casi in cui era tecnicamente possibile, la produzione delle grandi imprese venne esternalizzata e furono mantenuti all’interno solo i processi produttivi fondamentali; il peso relativo delle grandi unità produttive cominciava così a diminuire, mentre cresceva il peso delle piccole e piccolissime imprese e del lavoro a domicilio. Si riduceva così il costo del lavoro, perché nelle piccole imprese era, ed è ancor oggi, più facile sfuggire alle norme sul lavoro, comprese quelle relative agli orari, era più facile servirsi della manodopera in modo flessibile, licenziando e assumendo (o allungando e riducendo gli orari) a seconda delle esigenze del momento. Inoltre si indebolivano i sindacati, perché per il sindacato era più difficile organizzare i lavoratori nelle piccole imprese, anche in considerazione del fatto che i lavoratori delle piccole imprese sono più ricattabili.
8.4 Le relazioni industriali dopo il 1973
All’inizio degli anni settanta l’economia mondiale venne scossa da eventi particolarmente gravi: la crisi del sistema monetario internazionale del 1971-73 e il primo shock petrolifero del 1973-74. In Italia nel febbraio del 1973 viene decisa la fluttuazione della lira, che cominciò a svalutarsi; si creò così una spirale inflazione-svalutazione, aggravata dal notevole disavanzo commerciale causato dalla crisi petrolifera. Di fronte a questa situazione venne attuata, come d’altra parte negli altri paesi, una drastica politica deflazionistica al fine di ridurre la domanda di importazioni: vennero infatti adottate politiche fiscali e monetarie fortemente restrittive, che causarono una gravissima depressione.
Nel 1974 il tasso di inflazione sfiorò il 20% e ciò provocò un’azione sindacale volta ad una revisione del meccanismo della scala mobile. Venne introdotto il punto unico di contingenza , per cui l’indennità di contingenza venne pagata in uguale misura a tutti i lavoratori dell’industria; la maggior parte dei lavoratori si trovò perciò a godere di un completo adeguamento della retribuzione all’aumento dei prezzi, mentre al tempo stesso le differenze salariali si riducevano automaticamente, dato che la crescita relativa dei salari era tanto più alta quanto più bassa era la retribuzione . Si è osservato da più parti che tale meccanismo era causa di un rafforzamento dell’inflazione esistente e che poteva generare una spirale inflazionistica anche nel caso di aumento dei prezzi occasionale. Infatti un aumento occasionale dei prezzi induce automaticamente un aumento dei salari; se le imprese vogliono mantenere invariati i margini di profitto, ad ogni adeguamento dei salari aumentano nuovamente i prezzi, generando così una continua rincorsa prezzi - salari. Tuttavia gli imprenditori accettarono l’accordo, perché in una fase di cambi flessibili potevano aumentare i prezzi senza perdere quote di mercato all’estero; l’aumento del tasso di inflazione si traduceva infatti in un deprezzamento della lira e ciò manteneva inalterata la competitività internazionale. Peraltro l’accordo sul punto unico di contingenza riduceva la conflittualità inevitabilmente legata alla necessità di adeguare il salario al costo della vita in regime di inflazione elevata, soprattutto fra i lavoratori a basso reddito.
A livello politico, gli anni settanta in Italia furono caratterizzati da notevoli cambiamenti. Il Partito Comunista Italiano ottenne notevoli successi, in particolare nelle elezioni amministrative del 1975 e nelle politiche del 1976; i governi formatisi dal 1976 al 1979 furono i cosiddetti “governi di solidarietà nazionale” e si ressero sull’appoggio esterno del PCI. L’allargamento del consenso politico favorì la cosiddetta “normalizzazione” delle relazioni sindacali; in pratica, l’atteggiamento sindacale divenne più conciliante e meno conflittuale. Non a caso nel 1977, in occasione dell’assemblea dei quadri dei sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil tenutasi all’Eur a Roma, prevalse una linea di moderazione: i sindacati si dichiararono disposti ad accettare la moderazione salariale e un aumento della mobilità operaia per far fronte alla grave crisi dell’economia italiana e favorire la crescita dell’occupazione. Pochi giorni dopo, Luciano Lama, leader della Cgil, in un’intervista al quotidiano “Repubblica” divenuta famosa, affermò che la linea aggressiva che il sindacato aveva sostenuto in passato doveva considerarsi errata non solo nella pratica ma anche da un punto di vista teorico, che il salario non poteva considerarsi una “variabile indipendente”, in quanto variazioni del salario producono effetti sull’equilibrio economico generale. Lo schema interpretativo su cui si basava la “svolta dell’Eur” era basato sull’idea che la moderazione salariale avrebbe favorito l’aumento dei profitti, influenzando positivamente gli investimenti, che a loro volta avrebbero generato crescita e occupazione. Come si è visto nel capitolo 7
Nel 1979, con l’adesione dell’Italia al Sistema Monetario Europeo , l’atteggiamento degli imprenditori rispetto al meccanismo della scala mobile cambiò, dato che in cambi fissi un aumento dei prezzi avrebbe comportato una diminuzione della competitività. Nel 1982 il presidente della Confindustria Merloni diede disdetta dell’accordo sul punto unico di contingenza e, nel gennaio del 1983, venne raggiunto un nuovo accordo sul costo del lavoro che segnò un significativo cambiamento nelle relazioni industriali in Italia. Tale accordo prevedeva l’attenuazione del grado di copertura del punto di contingenza e importanti disposizioni normative volte a favorire la flessibilità del lavoro, quali l’introduzione dei contratti a tempo parziale e a tempo determinato, dei contratti di solidarietà e dei contratti di formazione lavoro. L’obiettivo era il contenimento dell’inflazione, una politica dei redditi concertata e una collaborazione fra le parti sociali nella conduzione delle politiche macroeconomiche. Tale accordo, secondo Tarantelli, “segna la prima tappa di un rafforzamento del grado di neocorporativismo nel nostro paese” .
Il 14 febbraio 1984 il governo Craxi, in accordo con Cisl e Uil e in opposizione con la Cgil promulgò il cosiddetto decreto di San Valentino, con cui si introduceva la predeterminazione del tasso di inflazione, che comportò il mancato pagamento di 4 punti di contingenza. Il decreto di San Valentino rappresentò un grave momento di rottura nei rapporti fra i maggiori sindacati, che si protrasse fino al 1988, dopo una fase in cui si era avviato un percorso di avvicinamento; nel 1972, infatti, era stato siglato un patto federativo fra Cgil, Cisl e Uil. La crisi del sistema di relazioni industriali fu un momento particolarmente grave per la storia del sindacato italiano, in primo luogo perché, dopo un lungo periodo di unità sindacale, Governo e Confindustria raggiungevano un accordo senza il consenso del maggiore sindacato, la Cgil, in secondo luogo perché le relazioni sindacali venivano disciplinate dall’alto, per decreto governativo. Il PCI e la Cgil promossero un referendum per abrogare tale decreto e persero, se pur di stretta misura.
Si arrivò poi con intese successive nel luglio 1992 e nel luglio 1993 a un nuovo accordo sul costo del lavoro, che segnò l’inizio di una strategia di concertazione che ha caratterizzato il sistema di relazioni industriali per quasi un decennio. Venne siglato con un patto fra Stato, organizzazioni di datori di lavoro e sindacati, il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno produttivo. Con tale protocollo il governo si impegnava a ridurre il tasso di inflazione a livello degli altri paesi industrializzati e a realizzare la stabilità valutaria, a ridurre il debito e il deficit pubblici e a mantenere una elevata crescita economica. L’accordo relativo al costo del lavoro prevedeva la soppressione della scala mobile; l’aumento dei prezzi sarebbe stato coperto in sede di contrattazione nazionale tenendo conto dell’inflazione programmata.
Con la soppressione della scala mobile, il tasso di inflazione fu rapidamente ridotto. Anche gli obiettivi della stabilità valutaria e della riduzione del deficit e del debito pubblico furono raggiunti, per cui l’Italia poté entrare a far parte della Unione Economica e Monetaria.
Non altrettanto soddisfacenti sono stati i risultati in termini di crescita del PIL, che nel decennio 1990-99 si è mantenuto intorno all’1% medio annuo, inferiore alla media annua dei paesi della UE (1,6%). Certamente i mediocri risultati in termini di crescita sono stati determinati dalle politiche fiscali restrittive necessarie per centrare i parametri di Maastricht.
Va sottolineato che il prezzo di questi risultati è stato ampiamente pagato dai lavoratori; dal 1993 non solo si è verificata una caduta della quota dei redditi da lavoro dipendente, ma sono diminuite anche le retribuzioni reali. In Italia dal 1993 al 2001 il reddito reale da lavoro dipendente pro capite si è ridotto del 3,4%, mentre in Gran Bretagna cresceva del 17,8%, in Francia del 7,4%, in Germania e in Spagna dello 0,9%. Tali risultati sono anche la conseguenza dell’aumento dell’occupazione atipica che ha subito un notevole incremento a partire dal 1997 in seguito all’introduzione di importanti misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro previste dal “pacchetto Treu”.
La moderazione salariale ottenuta in un clima di pace sociale dopo gli accordi del 1993 ha determinato, come si è detto, una riduzione dell’inflazione e ha permesso una crescita della redditività delle imprese. Tuttavia ha costituito un freno alla domanda interna che ha limitato il processo di crescita. Inoltre, come sottolinea l’ISTAT nel Rapporto sull’Italia 2003, “ha anche avuto il difetto di attenuare gli stimoli che la spinta retributiva normalmente esercita sulle imprese, forzandole all’investimento in macchinari e attrezzature, nella continua ricerca di soluzioni tecniche e organizzative più produttive e competitive. Le recenti traversie delle grandi imprese industriali evidenziano in modo drammatico i limiti insiti in una strategia di ricerca della competitività fondata in via primaria sul contenimento dei costi salariali.”
La politica economica del governo Berlusconi si è mossa in una direzione di rottura della strategia di concertazione. Il “Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia” redatto da Marco Biagi e Maurizio Sacconi e pubblicato dal Ministero del Welfare nel 2001 proponeva un abbandono della concertazione e il passaggio a un sistema di relazioni industriali di tipo decentrato, imperniato sulla rivalutazione del ruolo del contratto individuale. Le indicazioni contenute nel Libro Bianco sono state recepite dal “patto per l’Italia”, siglato nel luglio 2002 da associazioni imprenditoriali e sindacali comprese Cisl e Uil, ma non dalla Cgil, che non ne condivise il contenuto. Si verificava così un'altra grave fase di rottura fra i maggiori sindacati. Successivamente, nel 2003, sulla base delle proposte del Libro Bianco è stata varata la legge 30, la cosiddetta “legge Biagi”.
8.5 L’indebolimento dei sindacati
Oggi è evidente un indebolimento dei sindacati in quasi tutte le economie industrializzate. In Europa il calo del tasso di sindacalizzazione è iniziato circa due decenni fa, negli Stati Unti a partire dagli anni cinquanta. In Francia il tasso di sindacalizzazione si è dimezzato, in Gran Bretagna è sceso del 40%, è sceso ovunque in Europa, ad eccezione dei paesi scandinavi. In Italia il tasso di sindacalizzazione si è mantenuto relativamente stabile, ma cresce fra gli iscritti il numero dei pensionati ed è in calo il numero degli attivi.
Le cause della perdita del potere sindacale vanno ricercate in una serie di eventi:
- la crescente disoccupazione che ha investito la maggior parte dei paesi europei. Il timore di perdere il posto di lavoro ha indubbiamente abbassato il potere contrattuale dei lavoratori e si è indebolito uno dei tradizionali obiettivi del sindacato e cioè l’aumento o, almeno, la difesa del potere d’acquisto dei salari. In Italia l’oggetto della contrattazione si è perciò progressivamente spostato verso altre variabili macroeconomiche, in primo luogo l’occupazione, ma anche gli investimenti, la distribuzione del reddito, la difesa del welfare state. Questa estensione delle funzioni ha consentito al sindacato di mantenere un ruolo centrale nel sistema economico ma ha generato una situazione di difficoltà del sindacato dal lato della rappresentanza nei luoghi di lavoro. L’ambito di azione sindacale spesso viene avvertito come troppo “politico”, e la conseguenza è stato un calo delle iscrizioni al sindacato.
- I processi di internazionalizzazione delle economie che hanno reso sempre più complesso l’utilizzo delle politiche keynesiane di regolazione dell’economia tradizionalmente sostenute dai principali sindacati. Inoltre la possibilità di trasferire stabilimenti all’estero può diventare una continua minaccia per i lavoratori, di fronte a cui i sindacati sono impotenti; la necessità di ridurre i costi e, di conseguenza, i costi salariali per far fronte alla concorrenza internazionale, rende sempre più problematiche rivendicazioni salariali che permettano di mantenere il potere d’acquisto dei salari.
- La perdita di peso dei settori caratterizzati da alti livelli di sindacalizzazione. I settori in cui per tradizione sono più radicati i sindacati sono il manifatturiero e il settore pubblico; come noto il peso di tali settori è andato gradualmente calando, mentre è cresciuto il peso del terziario.
- La crescente diversità delle forme e dei tipi di lavoro. Il tradizionale modello “fordista” caratterizzato da stabilità dell’impiego e orari collettivi si è progressivamente frantumato, lasciando il posto ad una organizzazione del lavoro “flessibile” in termini di orari, contratti e condizioni di lavoro. L’eterogeneità dei lavori ha determinato un indebolimento dei sindacati, sia per la difficoltà di rappresentare e coordinare una molteplicità di forme di occupazione, sia per il venire meno di momenti di aggregazione collettiva dei lavoratori a causa della differenziazione degli orari, sia per le condizioni di precarietà che rendono più subordinati i lavoratori ai datori di lavoro (si pensi a questo proposito che non è insolita la pratica di non rinnovare i contratti a tempo determinato ai i lavoratori iscritti al sindacato).
Agli elementi sopra citati va aggiunto un fattore peculiare dell’economia italiana, e cioè la crisi delle grandi imprese, dove tradizionalmente è più radicato il sindacato.
Sulla base di queste considerazioni, possiamo chiederci se c’è un futuro per il sindacato. e, in ogni caso, se continuerà a esercitare la sua funzione di rappresentanza o se sia destinato a trasformarsi in un’istituzione completamente diversa. Certamente i sindacati hanno elaborato strategie di reazione a tale situazione. Ad esempio in Germania e nel Regno Unito si sono verificate delle fusioni sindacali, in Italia sono nati sindacati per a rappresentanza dei lavoratori atipici, si cerca di rafforzare il sindacato europeo. I principali sindacati cercano inoltre di incentivare le adesioni offrendo una serie di servizi ai propri iscritti, che possono includere l’assistenza fiscale e finanziaria, pacchetti turistici, ecc.
Non è dato sapere se queste strategie sono sufficienti a contrastare il declino dei sindacati; esiste comunque il rischio che il sindacato finisca con lo snaturare la sua funzione per diventare un’organizzazione di gestione di servizi per i lavoratori.
---------------------------------
Il sindacato nel neoliberismo
di Stefano Musso da Nuvole n.34- ottobre 2008
1. Il tramonto della contrattazione collettiva
Nel 2006, in un importante e dibattuto scritto, Michael Piore e Sean Safford hanno sostenuto che l'era della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali è ormai definitivamente tramontata negli Stati Uniti, dove si è consumata una svolta nel baricentro della mobilitazione sociale dalle identità economico/professionali connesse alla condizione di classe verso identità le cui radici stanno al di fuori del luogo di lavoro: il genere, la razza, la cultura, l’orientamento sessuale, l’età, la disabilità. Questi nuovi gruppi identitari sono mossi innanzitutto dal desiderio di riconoscimento sociale e da motivazioni morali e simboliche piuttosto che economiche. Il cambiamento è visto come la conseguenza della fine del modello di organizzazione sociale ed economico che sottostava alla contrattazione collettiva, un modello basato sulla separazione tra fabbrica e famiglia, tra la sfera della produzione con i suoi criteri razionali e scientifici e la sfera del consumo guidata da standard di affettività e personalità. Il collasso del modello delle relazioni industriali considerato sarebbe il risultato del disgregarsi dei confini di un tempo tra imprese, settori produttivi, mercati, famiglie. Fattori critici del cambiamento, in relazione alla famiglia, sarebbero stati la crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro e l’aumento del tasso di divorzio. Ne sarebbe risultata la sostituzione della contrattazione collettiva con un regime di diritti individuali intesi a garantire eguali opportunità di impiego. Questa interpretazione sfida l’ottica tradizionale tipica della teoria delle relazioni industriali secondo la quale il cambiamento epocale nel sistema economico e nel quadro politico deriverebbe semplicemente da un cambiamento nell’equilibrio dei rapporti di forza tra imprenditori e sindacati (Piore, Safford, 2006).
La prospettiva di Piore e Sanford invita a scavare nel mutamento socio-culturale profondo andando oltre la superficialità delle ottiche che vedono all’origine dell’indebolimento del sindacato il semplice cambiamento della composizione del lavoro dipendente con l’aumento del peso di categorie quali le donne e gli impiegati, tradizionalmente meno inclini all’organizzazione sindacale e alla militanza: una spiegazione, quest’ultima, in parte non vera e in parte riflettente piuttosto l’incapacità sindacale a innovare le proprie proposte e a entrare in contatto con le nuove componenti delle forze di lavoro, piuttosto che con la scarsa propensione di queste ultime all’azione collettiva. Studiosi militanti hanno proposto una stretta fusione nel movimento operaio tra obiettivi di lotta tradizionali e nuove esigenze identitarie (Clawson, 2003); altri ancora hanno discusso di come il movimento operaio dovrebbe tentare di rivitalizzarsi attraverso lo sforzo di penetrazione al di là dei tradizionali fortini industriali in direzione dei nuovi lavoratori dei servizi (Milkman, Voss, 2004).
2. Il cambiamento dei rapporti di forza tra imprese e lavoratori
Nella crescente disuguaglianza della distribuzione del reddito, non si può ritenere che il cambiamento dei rapporti di forza tra imprese e lavoratori non abbia giocato un ruolo fondamentale. Il punto è la spiegazione dei motivi del cambiamento dei rapporti di forza. Qui va richiamata innanzitutto la svolta epocale rappresentata da tatcherismo e reaganomics. All’epoca del compromesso keynesiano/fordista, negli anni cinquanta e sessanta, l’obiettivo primo della politica economica era la lotta contro la disoccupazione, mentre il potenziamento dei sistemi di sicurezza sociale e welfare ridistribuiva ricchezza attraverso la leva fiscale; le organizzazioni sindacali estendevano la propria forza contrattuale e la sindacalizzazione cresceva. Gli anni settanta, con la fine della convertibilità del dollaro e i due shock petroliferi, hanno rappresentato un decennio di crisi e passaggio che ha aperto, a partire dagli anni ottanta, la nuova epoca postfordista, postindustriale e neoliberista, nella quale l’obiettivo principale delle politiche economiche si è spostato dalla lotta contro la disoccupazione alla lotta contro l’inflazione, da perseguire anche sacrificando i tassi di occupazione e/o scontando un peggioramento delle condizioni contrattuali e retributive (Pollard, 1997). Mentre nella prima fase i redditi da lavoro hanno avuto una dinamica superiore a quella dei redditi da capitale, nella seconda fase è accaduto l’opposto. Ne è derivata una crescente debolezza del sindacato, dovuta da un lato ad attacchi diretti dei governi (i bracci di ferro ingaggiati dalla “signora di ferro”: Golden, 1997), dall’altro lato alla propaganda antisindacale delle forze di destra, con il sindacato accusato di difendere posizioni corporative e di privilegio: è stata messa in discussione la precedente convinzione secondo cui c’era un ampio scarto fra quello che i lavoratori ottenevano e ciò a cui avrebbero avuto diritto in base al loro contributo al progresso economico; alle richieste dei lavoratori è stata sempre più anteposta “la compatibilità rispetto alle condizioni dell’economia, al funzionamento efficace dell’impresa, all’andamento dei conti pubblici” (Baglioni, 2008). Ne è derivata una serie di riduzioni delle tutele giuridiche che hanno favorito l’aumento delle occupazioni irregolari e atipiche, mettendo a dura prova la capacità di tutela collettiva da parte del sindacato, con effetti di delusione per gli iscritti e disincentivazione alle nuove adesioni in quanto la contrattazione acquisitiva di migliori condizioni è stata spesso sostituita dalla contrattazione concessiva nelle imprese in difficoltà per evitare danni maggiori. Il sindacato è insomma rimasto ingabbiato dalla diffusa influenza neoliberista, dall’ambiente politico in senso lato ostile, dalla accanita resistenza del mondo imprenditoriale, dalla propria inerzia burocratica. Il fatto che i pensionati rappresentino largamente la categoria più numerosa (nelle tre grandi confederazioni italiane superano o si avvicinano alla metà degli iscritti) è un segnale evidente della difficoltà del sindacato a penetrare nelle nuove componenti delle forze di lavoro, le uniche in espansione numerica, nei servizi e tra i lavoratori atipici.
Tuttavia, non dovunque la debolezza sindacale si manifesta con la stessa intensità. Stati Uniti e Inghilterra vivono esperienze piuttosto diverse da quelle dell’Europa continentale. La storia e le tradizioni nazionali nelle relazioni industriali giocano un ruolo importante nella velocità e profondità del tendenziale passaggio dalla contrattazione collettiva alla regolazione di mercato. Questo passaggio è stato maggiore negli Usa e in Gran Bretagna che non in Germania, nei paesi scandinavi, in Belgio e in Italia. Non che in Europa manchino di certo i tentativi di accrescere la flessibilità nelle condizioni di lavoro e di retribuzione (soprattutto in Francia, dove però un livello di tutela relativamente elevato è offerto dal quadro legislativo e dal salario minimo), nonché il ricorso ai lavoratori interinali e ai contratti a termine. Inoltre, nei tentativi di addivenire a nuovi assetti contrattuali, le imprese tendono, per quanto possono, ad interloquire meno con i sindacati e a ricorrere maggiormente a nuove forme di consultazione e coinvolgimento diretto dei dipendenti (Feldenkirchen and Hilder, 2001), nell’ambito della tendenza allo slittamento dell’importanza relativa dei livelli contrattuali dal settore nazionale all’impresa per legare più strettamente i salari alla produttività. Nonostante queste tendenze, la tradizionale regolazione sindacale esercita ancora in Europa una influenza notevole, come mostrano, tra l’altro, la sostanziale tenuta dei tassi di sindacalizzazione, pur nel quadro di un generale ridimensionamento. La densità sindacale resta infatti assai elevata in Belgio e nei paesi scandinavi, dove i sindacati amministrano i fondi di disoccupazione, con quote abbondantemente superiori al 50%, e si riduce, negli ultimi vent’anni, non drammaticamente in Germania e Italia, dove si attesta poco sotto il 30%, mentre quote più basse si verificano in Inghilterra (20%), Stati Uniti (12%) e Francia, scesa sotto il 10%. In Italia, nel periodo 1986-2002, si registra una diminuzione, sensibile ma non drammatica, dei tassi di sindacalizzazione: il numero degli iscritti cade di poco più del 10%, come media tra Cgil e Cisl, mentre la caduta del tasso di sindacalizzazione sfiora il 20%, perché nello stesso periodo gli attivi sono cresciuti, per l’ampliamento del mercato del lavoro (in questa diminuzione, la Cisl ha una performance migliore: perde solo il 7% degli iscritti, contro il 15% della Cgil, e ha una caduta del tasso di sindacalizzazione del 14% contro il 21% della Cgil. Si può quindi pensare a una maggior tenuta della Cisl, dovuta alla cultura improntata al contrattualismo e al pragmatismo, al riconoscimento delle ragioni dell’impresa, al dialogo; ma forse la Cisl gode anche di un fenomeno strutturale, vale a dire l’aumento degli impiegati, nelle trasformazioni postfordiste e postindustriali, una categoria nella quale ha tradizionalmente avuto una maggior presenza e un maggior consenso che non tra gli operai).
In Europa la durata media del rapporto di lavoro con la stessa impresa (job tenure) si mantiene elevata, intorno ai dieci anni, quasi doppia di quella statunitense (con la Gran Bretagna, come al solito, a mezza via: Auer, Berg, Coulibaly, 2004), e deriva dalla tenuta della regolazione legislativa e sindacale, mentre in Giappone lo stesso effetto è prodotto da influenze culturali; inoltre, gioca probabilmente anche la differente struttura d’impresa: le aziende tedesche e giapponesi sono più accentrate e meno diversificate che negli Usa e nel Regno Unito (e, in parte, in Francia: Gospel, 2006, 2007).
3. Il ruolo delle differenze strutturali dell’occupazione
Oltre alle tradizioni culturali e istituzionali, va infine tenuta presente una decisiva differenza strutturale: il peso dell’occupazione manifatturiera sulla popolazione attiva si è ormai ridotto al 13% negli USA e al 14% nel Regno Unito (inclusi i settori minerari ed energetici, esclusa l’industria delle costruzioni, che pesa rispettivamente per l’8% circa in entrambi i paesi), mentre in Germania e Italia la manifattura si mantiene intorno al 24% (in Giappone è al 19%, in Francia al 16%).
Ne risulta che mentre negli Stati Uniti nuove forme di esasperata flessibilità vengono costantemente introdotte, specialmente nella grande distribuzione, con imprese all’avanguardia come Wal-Mart (Liechtenstein, 2006), sull’onda di quella che viene chiamata “l’ottimizzazione dell’orario di lavoro”, in Europa le cosiddette politiche attive del lavoro, pur introducendo forme di flessibilità, tentano di modularle secondo l’obiettivo della flexicurity nordica. In alcuni stati membri le direttive europee hanno favorito la riduzione delle tutele, come nel caso della proibizione dell’intermediazione privata della manodopera a scopo di lucro (risalente alla conferenza di Washington dell’ILO del 1919) e come in Italia, dove fino al 1997 è restato in vigore il monopolio statale del collocamento (Musso, 2004); in Gran Bretagna, invece, le direttive europee hanno implicato un incremento delle tutele tanto da far sì che si sia cercato di ritardarne l’introduzione e ridurne l’impatto (Kilpatrick, 2003).
Le forme più accentuate di flessibilità del lavoro e le difficoltà di penetrazione organizzativa del sindacato stanno nel terziario privato, dove si concentrano anche le nuove forme di impresa, piccola e reticolare, particolarmente diffuse nel cosiddetto terziario avanzato dei servizi alle imprese. Il sindacato entra in sofferenza con la diminuzione della centralità sociale dei suoi avamposti operai. Non è qui la sede per discutere le conseguenze del rafforzamento, a livello globale, degli strati operai nei paesi emergenti e degli sviluppi futuri. Una fonte di debolezza del mondo del lavoro tradizionale nei paesi avanzati sta sicuramente nella concorrenza esercitata sul mercato del lavoro dalla manodopera a basso costo dei paesi invia di sviluppo, a livello globale con le delocalizzazioni, a livello locale con i flussi di immigrazione. Infine, nell’economia dominata dai servizi, nella quale sfumano le distinzioni tra settori e i servizi sono sempre più incorporati nei prodotti, mutano le forme del lavoro in direzione di attività a più alto contenuto di conoscenza: benché difficilmente definibili e misurabili, una recente indagine sui lavoratori della conoscenza nei paesi avanzati ha concluso che essi sono ormai più numerosi dell’insieme degli operai, degli impiegati e dei contadini (Butera, Bagnara, Cesaria, Di Guardo, 2008).
Se la tradizione europea, un tempo incarnata nel capitalismo renano, fa sentire ancora la sua influenza e mitiga la riduzione del ruolo del sindacato, i fattori strutturali del suo indebolimento e la loro probabile futura evoluzione induce a considerazioni non ottimistiche. La tendenza alla convergenza dei paesi meno avanzati verso i paesi a struttura economica più evoluta (il catching up) pone il problema del se e quando l'Europa continentale convergerà verso i modelli americani e inglesi di regolazione dei rapporti di lavoro affidati prevalentemente al mercato.
4. Convergenza europea verso il modello anglosassone?
La convergenza si può osservare sotto tre angolature. La prima riguarda la distribuzione della popolazione attiva per settori, con la tendenza alla terziarizzazione dell'occupazione. I paesi che sono all’avanguardia nello spostamento verso i servizi hanno redditi pro-capite più elevati, con sacche di povertà e rischio di esclusione sociale consistenti ma minoritarie: la società postindustriale è una società dai mercati saturi, di sostituzione di gran parte dei prodotti tradizionali della produzione di massa, mercati ricchi che accentuano la competizione, una società nella quale l’industria del tempo libero ha un peso economico notevole, in cui le città cominciano a essere analizzate come “macchine per l’intrattenimento” (Lloyd, Clark, 2001). Lo sfaldamento delle grandi concentrazioni fordiste di lavoratori omogenei, unito alla pervasività del consumismo, determina il diffondersi di identità meno fondate sul lavoro, su quello che si fa per guadagnarsi da vivere e più fondate sui consumi, su quello che si ama fare nel tempo libero: si tratta di individualità meno collettive, più individuali (o massificate).
La seconda angolatura è quella dei sistemi di governo dell'impresa: Stati Uniti e Gran Bretagna si differenziano per l’ampia affermazione del modello shareholder value, ossia il valore per gli azionisti, secondo il quale compito primo dell'impresa e del manager è quello di rendere più elevato possibile l'utile che l'azionista ricava per il fatto che investe il suo denaro nell'impresa. Sono noti rischi e distorsioni insiti in questo modello che sacrifica alla crescita del valore finanziario delle azioni a breve la progettualità industriale di medio-lungo periodo, accentuando la tendenza a scelte di ristrutturazione, di scorporamento, di riduzione degli addetti che non sempre rispondono a logiche produttivo-industriali. Vi è chi interpreta il fenomeno come una sorta di tradimento dei manager rispetto alla tradizione tecnocratica (Casiccia, 2004), chi sottolinea piuttosto la inevitabile subordinazione dei manager ai dettati della finanziarizzazione dell’economia e dell’impresa (Gallino, 2005); ma in ogni caso, con le stock options si realizza una commistione di interessi tra manager e azionisti nel perseguimento di utili di breve periodo a scapito di scelte più ponderate sotto il profilo della coesione sociale e della responsabilità sociale dell'impresa. In Europa, la tradizione corporatista e la maggior diffusione della proprietà familiare favoriscono il persistere di resistenze alla piena accettazione del principio del valore degli azionisti, a favore dello stakeholder value (si vedano ad esempio il caso Porsche – Volkswagen del 2005 e il discorso di Marchionne all’assemblea annuale dell’AMMA del 2007 sui quali rispettivamente Colli, 2006 e Volpato, 2008); ma la visione finanziaria, quella che sembra ormai diventata il nuovo credo delle business schools a livello internazionale, in un mercato globale in cui il valore degli scambi finanziari ha superato di gran lunga il valore dello scambio di merci, appare sullo sfondo come la tendenza vincente.
La terza angolatura sotto la quale si può considerare la convergenza sono i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro variamente collegati alle nuove tecnologie, che comportano una moltiplicazione delle figure professionali e la nascita di percorsi di carriera basati su professionalità individuali che rendono più difficile la compattezza di un tempo delle categorie industriali. Il lavoro blue collar è tutt’altro che scomparso. Tuttavia, sul piano dei contenuti del lavoro, alcune mansioni operaie sono divenute più simili a quelle impiegatizie in conseguenza dei processi di “terziarizzazione interna” (dai trasporti alla gestione magazzini, al lavoro sui sistemi automatici integrati computerizzati, che richiedono attenzione e responsabilità); per converso, i lavori impiegatizi esecutivi sono stati maggiormente semplificati e proceduralizzati, innescando forme di declassamento degli impiegati esecutivi; infine, anche in rapporto alla crescente terziarizzazione dell’occupazione, aumentano le “mansioni di relazionalità”, che presentano caratteri ambigui: mansioni di per sé semplici richiedono scambi comunicativi e affidano a persone di basso inquadramento la responsabilità dello svolgimento di una fase, per quanto limitata, del funzionamento organizzativo; tali mansioni sono oggi simili nell’occupazione industriale e in quella terziaria. I livelli di scolarità delle nuove leve operaie sono cresciuti riducendo le distanze rispetto alle corrispondenti leve impiegatizie. La posizione sociale degli operai presenta così aspetti contraddittori: da un lato le scelte organizzative in direzione della “gerarchia piatta” riducono le distanze nel luogo di lavoro anche sul piano simbolico, mentre i giovani operai e impiegati non vestono né hanno stili di vita sostanzialmente differenziati; dall’altro lato le tradizionali distinzioni, radicate sul piano culturale e ribadite dai diversi ambiti di socialità nell’ambiente di lavoro (specie nelle imprese di maggior dimensione), contribuiscono a mantenere elevata la percezione della distanza tra colletti bianchi e blu, tra lavoro impiegatizio e operaio, tanto da riverberarsi nelle preferenze dei giovani riguardo alle attività formative e lavorative. Il lavoro operaio è diventato e diventerà sempre più appannaggio delle schiere di immigrati. In questa situazione l’identità operaia risulta indebolita. L’opacità della fabbrica non dipende solo dalla disattenzione dei media e degli studiosi in confronto agli anni della centralità operaia, ma ha origine nella stessa crisi della cultura operaia. Il venir meno delle strategie di riscatto sociale attraverso le mobilitazioni collettive (nonostante il bisogno di guadagni più elevati, spesso soddisfatto attraverso doppi lavori), l’affermarsi di mansioni ambivalenti, sono altrettanti fattori che rendono incerta la collocazione socio-culturale degli operai.
5. Le prospettive per il sindacato in Italia
In riferimento all’Italia, tutti questi fattori rendono e renderanno più difficile la riproposizione di obiettivi unificanti quali sono stati in passato lo Statuto dei lavoratori, le grandi riforme sociali, il superamento delle gabbie salariali, l’inquadramento unico. Il fenomeno della convergenza pone una sfida ai sindacati. Quale, tra la cultura del sindacalismo politico/oppositivo, territoriale/orizzontale, del sindacato di classe da un lato, e quella pragmatico/contrattualista, verticale di categoria, del sindacato degli iscritti dall’altro si è rivelata più efficace in età industriale? E le culture più efficaci nella difesa degli interessi dei lavoratori in età industriale sono parimenti le più adatte allo stesso obiettivo nell'età postindustriale? Vi è da dubitarne. In età industriale il contrattualismo cislino, fondata sulla preminenza delle categorie e dell’organizzazione verticale rispetto a quella orizzontale e sulla preminenza del contratto sulla legge, ha certamente segnato diversi punti a favore rispetto al sindacalismo politico della Cgil. Ha inoltre propugnato un utile pluralismo sindacale. Ma, se il nostro futuro sarà quello degli Stati Uniti o dell'Inghilterra, vale a dire una crescente precarizzazione del lavoro, una crescente instabilità dell'occupazione, se la durata del rapporto di lavoro con la stessa azienda è destinato a diminuire drasticamente, se il futuro sarà quello del passaggio dal lavoro ai lavori, di una maggiore mobilità del lavoro (non necessariamente precarietà) non sarà allora più adatta a cogliere la sfida l'organizzazione orizzontale/territoriale, tipica della cultura del sindacalismo politico della Cgil? Perché se non solo la classe non c’è più, ma anche la categoria rischia di non esserci più, l'organizzazione territoriale potrebbe risultare quella più adatta, così come lo sono state le Camere del lavoro alle origini dello sviluppo industriale italiano e nel primo quindicennio del secolo scorso, le quali raccoglievano molte più adesioni delle federazioni di categoria, perché il mercato del lavoro era caratterizzato da precarietà, instabilità, stagionalità, occasionalità, pluriattività, e la struttura territoriale era quella più adatta a organizzare e rappresentare la massa dei lavoratori fluttuanti.
Ancora: se si va verso la frammentazione delle categorie, allora un sindacato che rappresenti il lavoro nella nuova era non sarà un sindacato che dovrà puntare meno a una contrattazione collettiva sempre più difficile da costruire e imporre, anche a fronte del moltiplicarsi delle posizioni lavorative, e punterà invece ai diritti del lavoratore, compresi quelli contro le discriminazioni, che più che di un contratto hanno bisogno di leggi? Dunque un sindacato che punterà più alla legge che al contratto? Se è così, sembra destinata a maggiori successi una nuova cultura sindacale ricalcata sul modello della CGIL.
Nella interpretazione storica del movimento degli scioperi due modelli si sono confrontati (Boll, 1989, 1992): il primo ha sostenuto l’esistenza di una tendenza evolutiva verso conflitti limitati e regolati grazie alla crescente istituzionalizzazione delle relazioni industriali e alla capacità delle organizzazioni di valutare le mobilitazioni secondo il calcolo dei costi e benefici (Volkmann, 1978); il secondo modello nega l’esistenza di una evoluzione secolare e sottolinea l’emergere periodico e irregolare di cicli alti degli scioperi, con nuove ondate di conflittualità ogni volta che nuovi gruppi di lavoratori hanno vissuto problemi comuni e ne hanno rivendicato la soluzione (Cronin, 1979). Entrambe le interpretazioni poco si adattano alla caduta della tutela sindacale e al ciclo discendente delle mobilitazioni che da un trentennio ha conosciuto poche eccezioni. Tuttavia, se nuovi gruppi di lavoratori emergono nella società in mutamento, il ruolo del sindacato deve essere quello di facilitare l’affermarsi della dimensione collettiva nelle strategie di soddisfazione dei nuovi bisogni. Si tratta di una sfida difficile, ma il sindacato ha sempre funzionato al meglio quando si è trovato sotto attacco, costretto ad affrontare sfide decisive.
Bibliografia
Auer, Peter – Berg, Janine – Coulibaly, Ibrahim, (2004), Is a stable workforce good for the economy? Insights Into The Tenure-Productivity Employment Relationship, ILO - Employment Analysis and Research Unit - Employment Strategy Department, Working Papers, n. 15.
Baglioni, Guido, (2008), L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale, Bologna, il Mulino.
Boll, Friedhelm, (1989), Changing Forms of Labor Conflict: Secular Development or Strike Waves?, in Haimson - Tilly, op. cit., pp. 47-78.
Boll, Friedhelm, (1992), Arbeitskämpfe und Gewerkschaften in Deutschland, England und Frankreich. Die Entwicklung von 19. Zum 20. Jahrhundert, Bonn, Verlag Dietz.
Butera, Federico – Bagnara, Sebastiano – Cesaria Ruggero – Di Guardo, Sebastiano, (2008), Lavoro, lavoratori, società della conoscenza, Milano, Mondatori Università
Camera del Lavoro Metropolitana Firenze - Associazione Biondi-Bartolini, (2008), A proposito di Bruno. Quattro giornate di studio e riflessione ricordando Bruno Trentin, (s.d., s.l., ma Firenze).
Casiccia, Alessandro, (2004), Il trionfo dell’élite manageriale. Oligarchia e democrazia nelle imprese, Torino, Bollati Boringhieri.
Clawson, Dan, (2003), The Next Upsurge. Labor and the New Social Movements, Ithaca and London, Cornell University Press.
Colli, Andrea, (2006), Corporate governance e assetti proprietari. Genesi, dinamiche e comparazioni internazionali, Venezia, Marsilio.
Cronin, James, (1979), Industrial Conflict in Modern Britain, London, Croom Helm
Feldenkirchen Wilfred – Hilder Susanne (2001), Menschen und Marken, Duesseldorf, Henkel.
Gallino, Luciano, (2005), L’impresa irresponsabile, Torino, Einaudi.
Golden, A., Myriam, (1997), Heroic Defeats. The Politics of Job Loss, Cambridge, Cambridge University Press.
Gospel, Howard, (2006), The Development of Labour Management in Divisionalised Companies, mimeo, London, King’s College.
Gospel, Howard, (2007), Labour Management in Historical Perspective, in Jones – Zeitlin, op. cit.
Haimson, Leopold – Tilly, Charles (eds.), (1989), Strikes, Wars, Revolutions in an International Perspective: Strike Waves in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Cambridge, Cambridge University Press.
Jones, Geoffrey – Zeitlin, Jonathan (eds.), (2007), Handbook of Business History, Oxford, Oxford University Press.
Kaelble, Hartmut (ed.), (1978), Probleme der Modernisierung in Deutschland. Sozialhistorische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, Opladen, Westdeutscher Verlag.
Kilpatrick, Claire, (2003), Has New Labour Reconfigured Employment Legislation?, in “Industrial Law Journal”, vol. 32, pp. 135-163.
Milkman, Ruth – Voss, Kim (eds.), (2004), Rebuilding Labor. Organizing and Organizers in the New Union Movement, Ithaca and London, Cornell University Press.
Musso, Stefano, (2004), Le regole e l’elusione. Il governo del mercato del lavoro nell’industrializzazione italiana (1898-2003), Torino, Rosenberg & Sellier.
Piore, Michael J. – Safford, Sean, (2006), Changing Regimes of Workplace Governance, Shifting Axes of Social Mobilization and the Challenge to Industrial Relations Theory, mimeo, Cambridge MA, MIT.
Pollard, Sidney, (1997), The International Economy Since 1945, London – New York, Routledge (trad. it. Roma – Bari, Laterza, 1999).
Rorty, Richard, (1998), Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America, Cambridge, Harvard University Press.
Rorty, Richard – Nystrom, Derek – Puckett, Kent, (1998), Against Bosses, Against Oligarchies: A Conversation with Richard Rorty, Charlottesville, VA, Prickly Pear Pamphlets.
Volkmann, Heinrich, (1978), Modernisierung des Arbeitskampfes? Zum Formwandel von Streik und Aussperrung in Deutschland 1864-1975, in Kaelble, op. cit., pp. 110-170.
Volpato, Giuseppe, (2008), Fiat Group Automobiles. Un’Araba Fenice nell’industria automobilistica internazionale, Bologna, il Mulino.
Il futuro dei sindacati nel mondo globalizzato
di Marino Regini da Nuvole n.34- ottobre 2008
Non solo in Italia, ma in tutto il mondo sviluppato, i sindacati sono chiaramente in declino. Se nel 1980 quasi la metà (il 49.6%) dei lavoratori dipendenti italiani erano iscritti a un sindacato, poco più di 20 anni dopo erano scesi a un terzo (il 34% nel 2002). E nel resto del mondo le cose non vanno certo meglio per le associazioni che rappresentano i lavoratori. Fra i paesi maggiori l’Italia è comunque quello con il tasso di sindacalizzazione più elevato (neppure il 10% nella vicina Francia), mentre tassi sensibilmente più elevati si registrano solo nei paesi scandinavi e in qualche altro paese di piccola dimensione.
Oltre che un sensibile calo di iscritti, dovunque i sindacati registrano poi una perdita di influenza nei confronti delle loro controparti, imprenditori e governi. La contrattazione collettiva è ormai la fonte di regolazione del lavoro e di determinazione dei livelli salariali per una quota soltanto di lavoratori. E i “patti sociali” conclusi con successo, ovvero la concertazione con i governi, sono stati in Italia ben 5 negli anni ’90 ma solo 2 nei primi otto anni del nuovo millennio. La divisione fra i sindacati si è inoltre accentuata, indebolendoli ulteriormente nei confronti delle controparti: il “patto per l’Italia” del 2002 è stato firmato da CISL e UIL ma non dalla CGIL, e un analogo patto separato si preannuncia sulla questione decisiva della struttura della contrattazione. Infine, i sindacati, per decenni emblema della tutela dei lavoratori e degli strati più deboli della popolazione, caposaldo di un regime democratico e componente essenziale di quel “modello sociale” di cui l’Europa andava fiera, sono ormai in fondo alla scala di fiducia dei cittadini nei confronti delle diverse istituzioni.
Nell’opinione pubblica, e nel mondo dei media che ne coglie e ne amplifica gli umori, circola ormai apertamente la domanda: è ancora utile, e per chi, una rappresentanza collettiva degli interessi dei lavoratori? Esiste ancora uno spazio significativo per questa rappresentanza e per l’azione collettiva che su di essa si fonda? E che cosa possono fare i sindacati per dimostrare la loro utilità e la loro capacità di colmare questo spazio?
Vorrei azzardare un modesto tentativo di risposta a queste domande proponendo un punto di vista volutamente provocatorio, quindi sicuramente discutibile e confutabile, ma che obblighi almeno a ragionare seguendo percorsi diversi da quelli tradizionali, che appaiono incapaci di indicare prospettive realistiche e produttive di risultati.
Un’osservazione diffusa da cui si è soliti partire è che i sindacati dei paesi avanzati si sono generalmente indeboliti negli ultimi due decenni perché la propensione dei lavoratori ad aderire è quasi ovunque diminuita, e/o perché la riorganizzazione dei processi produttivi e la frammentazione del mondo del lavoro hanno ristretto la tradizionale area di rappresentanza. E’ a questo declino della capacità di rappresentanza economica e sociale dei sindacati che si fa generalmente riferimento per valutarne la residua capacità di influenza sulle controparti imprenditoriali e istituzionali. Dall’indebolimento della rappresentanza, si argomenta infatti, discende il minor potere contrattuale che i sindacati sono oggi in grado di esercitare nei confronti delle controparti. Queste ultime si dimostrano sempre più impazienti e determinate a ridurre drasticamente il ruolo dei sindacati nella vita economica e politica. Se non si sono ancora decise ad affrontarli frontalmente è solo perché la loro residua capacità di resistenza, o alcuni vincoli istituzionali, renderebbero questa scelta costosa in termini di conflitto o di perdita di legittimazione.
Da questa analisi (che naturalmente ho schematizzato in modo riduttivo) discendono anche le ricette, più o meno implicite. I sindacati europei devono riuscire a recuperare capacità di rappresentanza tutelando in modo più puntuale gli interessi della loro base tradizionale, ma soprattutto estendendo l’area dell’inclusione nel sistema di tutele agli outsiders. Solo così, aumentando l’efficacia e l’estensione della rappresentanza, riusciranno a resistere alle spinte verso una ulteriore de-regolazione del mercato del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali.
Queste ricette sono diventate molto popolari perché combinano critiche “da sinistra” e “da destra” all’azione sindacale. La sinistra del sindacato è per tradizione a favore sia di una rappresentanza più attenta e militante degli interessi degli inclusi sia di una sua estensione agli esclusi, naturalmente a discapito della probabilità di stipulare accordi e di istituzionalizzare la cooperazione con le controparti. Ma anche da destra i sindacati sono da tempo oggetto di critiche per la loro incapacità di rappresentare gli outsiders, incapacità che per i sostenitori di questa tesi deriverebbe da un eccesso di tutela di settori sempre più ristretti della forza lavoro – quelli che per differenza vengono definiti gli insiders.
Le “gabbie salariali” erano le differenze territoriali nei salari minimi contrattuali, che facevano sì che i lavoratori nel sud venissero retribuiti sistematicamente meno che al nord.
Se ogni lavoratore deve ricevere -mettiamo- lo 0.8% di aumento salariale per ogni 1% di aumento dei prezzi, il punto di contingenza, cioè quanto viene pagato effettivamente a seguito per ogni aumento dell'1% dei prezzi, varia a seconda della retribuzione: chi abbia uno stipendio di 100 riceverà 0.8, chi abbia uno stipendio di 200 riceverà 1.6. Se il punto è unico, tutti ricevono -mettiamo- 1; il che significa, in questo esempio, che l'indicizzazione è completa per chi abbia uno stipendio di 100 (e più che completa per chi abbia una retribuzione inferiore), e cala via via al crescere della retribuzione: per chi abbia una retribuzione di 200, un aumento di 1 corrisponde a una crescita dello 0.5%, metà dell'aumento dei prezzi. E' opportuno notare che un'indicizzazione completa non significa mantenimento del potere di acquisto, a meno che essa non sia istantanea. Nel caso italiano l'adeguamento era trimestrale, il che vuol dire che per tre mesi i salari reali diminuivano (in assenza di modifiche contrattuali), e venivano riportati al livello iniziale appunto dopo tre mesi.
Consideriamo un salario di 100 e uno di 200, cui si applica un'indennità di contingenza di 50. Il primo diventa 150 e il secondo 250; senza indennità il primo è la metà del secondo, con l'indennità diventa il 60%.
Tornerò più avanti su questo passaggio. Rispetto all’analisi tradizionale, invece, ciò che propongo ora di fare – come ho detto, in modo volutamente provocatorio – è di rovesciarne la sequenza logica. Possiamo dunque osservare che, negli ultimi vent’anni, i sindacati universalmente ritenuti più forti sono stati quelli capaci di svolgere funzioni positive per lo sviluppo economico del paese in cui operano. Dove hanno mostrato questa capacità, sono stati in grado di ottenere anche, direttamente o indirettamente, vantaggi per i propri rappresentati e legittimazione sociale, e questo ha consentito loro di “tenere” sul piano della rappresentanza sostanziale, anche laddove questa tenuta non si è tradotta in tassi di adesione elevati. Del resto, i sindacati tedeschi hanno tassi di adesione più bassi di quelli inglesi, ma non c’è dubbio che siano ben più forti di questi ultimi da ogni altro punto di vista. E i sindacati spagnoli o olandesi hanno acquistato negli ultimi anni influenza e anche capacità di rappresentanza, pur conservando livelli di sindacalizzazione piuttosto bassi, perché hanno dato un contributo positivo al modello di sviluppo del loro paese, mentre i sindacati francesi sono rimasti deboli perché non sono stati in grado di farlo.
Che cosa significa dare un contributo positivo allo sviluppo economico di un paese? Significa svolgere funzioni utili per il sistema delle imprese e per il governo dell’economia, ma capaci al tempo stesso di conseguire quelli che una volta si sarebbero chiamati “risultati di progresso”, cioè beni semi-pubblici che tendenzialmente avvantaggiano tutta la comunità e che quindi danno loro legittimazione sociale .
Non è facile per i sindacati conciliare una ragionevole tutela degli interessi dei loro rappresentati con lo svolgimento di funzioni utili allo sviluppo economico del paese o della comunità locale. Dopotutto, il compito per cui storicamente sono nati è il primo. Ma l’osservazione comparata ci mostra che, dove riescono a svolgere con una qualche efficacia anche il secondo, i sindacati acquistano maggiore capacità di influenza, e dunque la ragionevole probabilità di ottenere per questa via vantaggi anche per i propri rappresentati.
Non è facile neppure per gli imprenditori apprezzare il contributo positivo che allo sviluppo possono dare organizzazioni come quelle sindacali, che per le imprese sono anche e soprattutto agenti di redistribuzione del reddito prodotto dalle imprese stesse e fonti di vincoli alla propria libertà d’azione nell’organizzare la produzione nel modo più efficiente.
Fornire un contributo positivo allo sviluppo, dunque, non è affatto semplice per i sindacati, stretti fra l’esigenza di dare risposte alle domande più immediate della propria base, da un lato, e quella di convincere le controparti a considerarli una risorsa anziché un vincolo, dall’altro. Se riescono a svolgere funzioni positive per la loro economia, ciò è l’esito di una strategia consapevole e determinata da parte loro, non certo di una semplice accettazione passiva dell’iniziativa delle controparti. Dove questa strategia ha successo, i sindacati riescono anche a esercitare la loro influenza sulle scelte delle imprese e delle istituzioni pubbliche. La loro forza consiste allora nell’essere in grado di far valere la voce dei loro rappresentati su queste scelte e al tempo stesso di garantirne la collaborazione. E’ questa capacità di influenza che consente di mantenere la propria capacità di rappresentanza, non viceversa.
Ma quali sono le funzioni cruciali per il sistema delle imprese e per il governo dell’economia che i sindacati possono oggi svolgere e dalle quali dipende nel lungo periodo la propria forza?
Anche nel periodo fordista l’azione sindacale ha prodotto alcuni effetti benefici, benché non intenzionali, per il sistema economico. E’ però con il declino della produzione di massa che ai sindacati si offre la possibilità di andare oltre il tradizionale ruolo distributivo per esercitare funzioni “produttive” cruciali per il sistema delle imprese, quali l’organizzare la cooperazione della forza lavoro e il contribuire alla sua valorizzazione professionale. Nei nuovi sistemi produttivi, sono proprio le istituzioni delle relazioni industriali sorte per porre vincoli alle imprese (quali sindacati, rappresentanze aziendali, contrattazione collettiva) quelle che possono dall’altro lato fornire loro risorse cruciali e vantaggi competitivi. Queste istituzioni di rappresentanza e azione collettiva infatti limitano fortemente alcune forme di flessibilità (soprattutto quella salariale verso il basso e quella numerica in uscita), ma in diversi paesi hanno grandemente favorito la crescita di flessibilità funzionale e temporale (e in taluni casi anche numerica in entrata). Inoltre, come si è detto, svolgono la funzione di garantire alle imprese la cooperazione della forza lavoro nei continui processi di innovazione, cioè un bene semi-pubblico essenziale per lo sviluppo economico di un paese.
La cooperazione della forza lavoro nel processo produttivo è diventata per le imprese un'esigenza cruciale in larga misura per le stesse ragioni per cui lo è la disponibilità di risorse umane qualificate. Essa consente infatti il funzionamento di sistemi organizzativi che hanno bisogno del contributo attivo dei lavoratori al loro continuo miglioramento, cioè di qualcosa di più della semplice “pace sociale”. Benché in alcuni paesi e settori il management abbia cercato di ottenere questa cooperazione attraverso un rapporto diretto con i lavoratori, scavalcando il ruolo dei loro rappresentanti, molte imprese europee negli anni ottanta e novanta hanno considerato non conveniente un isolamento dei sindacati, non tanto o non solo perché capaci di frapporre resistenza, quanto per i motivi indicati sopra. Un'alleanza con i sindacati è inoltre particolarmente vantaggiosa per le imprese durante i periodi di profonda ristrutturazione, quando sono particolarmente vulnerabili e bisognose di legittimazione sociale, o addirittura di appoggio nei confronti delle pubbliche istituzioni a cui chiedono sostegno finanziario, e nei confronti dei lavoratori “eccedenti” su cui gravano i costi del riaggiustamento.
Dunque, in paesi quali la Germania, l’Olanda, l’Italia, l’azione sindacale in azienda e nel mercato del lavoro non ha rappresentato solo un elemento di rigidità, un semplice fattore di disturbo da neutralizzare; è stata invece tipicamente ambivalente, un vincolo per le imprese ma anche una risorsa per le loro esigenze di flessibilità. Lungi dall’assumersi semplicemente un ruolo redistributivo, molti sindacati europei hanno puntato a svolgere cruciali funzioni produttive, organizzando la cooperazione nei luoghi di lavoro, coordinando la dinamica salariale, contribuendo allo sviluppo delle risorse umane, concludendo patti sociali che mirano a una crescita più stabile e armonica. Tutto ciò ha consentito loro di mantenere capacità di rappresentanza nonostante le profonde trasformazioni del mondo del lavoro che certamente non favoriscono la sindacalizzazione.
E’ però evidente che si pone un interrogativo: possono i sindacati continuare a sottoscrivere accordi e patti sociali che non garantiscano benefici diretti ai propri iscritti senza vedere indebolita, nel lungo periodo, la propria capacità di rappresentanza? La legittimazione sociale e il riconoscimento di essere partners affidabili che essi acquisiscono dalle controparti sono sufficienti a mantenere il consenso della propria base?
Non è facile dare una risposta sicura a queste domande. Si può però sostenere che l’influenza sulle politiche pubbliche che essi acquisiscono mediante la concertazione consente loro di plasmarle comunque in modo più favorevole agli interessi dei lavoratori di ciò che altrimenti avverrebbe; e che una tale argomentazione, se avanzata attraverso canali capillari di democrazia interna, può risultare sufficientemente persuasiva da garantire il consenso della base. Si può dunque prevedere che, nonostante delusioni e ripensamenti, i sindacati europei continueranno a privilegiare la ricerca di patti o di forme di concertazione, nelle quali la capacità di rappresentanza generale è la condizione della possibilità di influire sulle politiche pubbliche, e la capacità di influenza è a sua volta condizione della “tenuta” della rappresentanza anche di fasce del mondo del lavoro altrimenti indotte a fare a meno dell’azione collettiva.
Capitolo 9
Le politiche per l’occupazione
In questo capitolo vedremo una breve rassegna sulle principali proposte di politiche per l’occupazione, tenendo conto della loro praticabilità ed efficacia.
9.1 Le politiche keynesiane
La teoria keynesiana ha ampiamente ispirato le politiche macroeconomiche per circa trent’anni a partire dal secondo dopoguerra e i risultati in termini di crescita e occupazione nei paesi europei sono stati senza dubbio positivi.
I responsabili della politica economica e anche numerosi teorici oggi sembrano mostrare pessimismo rispetto all’efficacia delle politiche keynesiane di sostegno alla domanda. L’incapacità di tali politiche di affrontare il fenomeno della stagflazione nel periodo successivo alle crisi petrolifere ha provocato un crescente disinteresse per l’approccio keynesiano, nonostante i successi ottenuti fino all’inizio degli anni settanta. A livello teorico, come abbiamo visto, il paradigma keynesiano è stato messo in disparte e la scena è stata dominata dapprima dai monetaristi e dai teorici della NMC, che sostengono che la disoccupazione può essere eliminata lasciando agire liberamente le forze di mercato e, successivamente, dai teorici della NMK, che si pongono al confine fra scuola neoclassica e scuola keynesiana e propongono ricette volte a incidere sul funzionamento del mercato del lavoro.
Alla luce delle teorie dell’equilibrio con razionamento possiamo affermare che l’inadeguatezza delle politiche keynesiane in seguito agli shock di offerta era prevedibile, perché tali perturbazioni hanno generato disoccupazione classica. Dunque le analisi e le politiche keynesiane non sono sbagliate, come molti pretenderebbero, ma in certi casi possono essere inadeguate.
A nostro parere l’elevata disoccupazione che ha colpito l’Italia e altri paesi dell’Europa continentale negli ultimi vent’anni ha caratteristiche prevalentemente di origine keynesiana, anche se erano certamente presenti elementi di contaminazione classica. Nell’attuale fase di crisi oggi certamente ci troviamo in una fase di disoccupazione keynesiana, La domanda da tempo nel nostro paese ristagna in tutte le sue componenti. La domanda di consumi ha mostrato una dinamica contenuta a causa del rallentamento nel tasso di crescita del PIL e alle aspettative negative dell’economia. La spesa pubblica ha subito drastici tagli in passato per consentire l’ingresso nell'unione monetaria europea e non ci sono prospettive di crescita, dati i vincoli del Patto di stabilità e crescita. La domanda di investimenti è rimasta debole, nonostante i bassi tassi di interesse, per l’incertezza del quadro macroeconomico è incerto. La congiuntura internazionale non ha offerto prospettive positive per la crescita delle esportazioni, in particolare per paesi come l’Italia, la cui specializzazione nei settori tradizionali è in competizione con le produzioni dei paesi in via di sviluppo.
Attualmente con la grave recessione che investe le economie industrializzate la situazione è drammaticamente peggiorata.
Le proposte keynesiane raccomandano il rilancio della spesa pubblica e del consumo pubblico e privato, e una politica monetaria espansiva di accompagnamento per ridurre il tasso di interesse e stimolare gli investimenti . Queste politiche forse oggi non sarebbero sufficienti, tuttavia consentirebbero di ridurre la disoccupazione attraverso uno stimolo alla domanda globale in beni e servizi.
Il problema è che il Patto di stabilità e le norme che regolano il comportamento della Banca Centrale Europea (BCE) hanno reso queste politiche di difficile, se non impossibile, attuazione.
L’obiettivo della BCE del mantenimento di un tasso di inflazione inferiore al 2% nel medio periodo è senza dubbio estremamente ambizioso e il tentativo di mantenere basso il tasso di inflazione ha frenato la crescita dell’economia europea. Ma oggi comunque una politica monetaria espansiva non è in grado di rilanciare l’economia. Se la domanda ristagna, ristagnano anche gli investimenti, le imprese non possono essere indotte a investire nonostante i bassi tassi di interesse, se c’è carenza di domanda.
La politica fiscale è oggi vincolata dal Patto di stabilità, che impone stretti vincoli ai bilanci pubblici e non permette quindi un’espansione fiscale che consenta un rilancio dell’occupazione. I trattati dell’Unione Europea non fissano alcun parametro vincolante per il tasso di disoccupazione; una soglia massima del tasso di disoccupazione dovrebbe invece far parte degli obiettivi della politica economica della UEM. A questo scopo è necessaria un’armonizzazione fiscale fra i paesi UEM, soprattutto per quanto riguarda i redditi da impresa e da capitale; ciò permetterebbe di evitare la concorrenza fiscale fra i paesi membri, che finisce col diminuire le pubbliche entrate e impedisce quindi di praticare politiche di rilancio dell’economia.
L’eliminazione dei tassi di cambio fra le monete poteva tradursi in un’opportunità per l’attuazione di politiche espansive concertate fra i paesi aderenti alla UEM. Ma, nella situazione attuale, in presenza dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità e dallo statuto della BCE, lo spazio per le politiche di sostegno alla domanda è estremamente limitato. In effetti, di fronte alle difficoltà in cui versa oggi l’economia europea, numerosi politici e studiosi si domandano se non sia il caso di allentare i vincoli imposti dal Patto che sembrano costituire un ostacolo alla ripresa.
Le politiche di sostegno alla domanda nel contesto attuale devono essere fortemente selettive, dati i vincoli imposti alla spesa pubblica, che rendono difficile realizzare politiche anticongiunturali in fasi recessive. E’ necessario attuare politiche che permettano di garantire la crescita dell’economia e dell’occupazione e la competitività del nostro sistema di imprese nel lungo periodo, tenendo conto dei vincoli di breve periodo. In questo contesto appare sempre più rilevante il ruolo della politica industriale.
9.2 La politica industriale
Le politiche industriali e le strategie per l’innovazione sono di fondamentale importanza per la crescita dell’economia e dell’occupazione, soprattutto in Italia dove per molto tempo si è mantenuta la competitività del sistema grazie alle svalutazioni competitive. Con l’adesione all’Euro ovviamente questa strategia non è più possibile e, se non viene attuata una seria politica industriale, si rischia di diventare un’area marginale dell’Europa con gravi problemi occupazionali e/o vaste fasce di working poors.
Un tempo molte imprese del sistema a partecipazione statale costituivano una leva importante della politica industriale italiana. Dopo l’ondata di privatizzazioni nel nostro paese la politica industriale si è indirizzata verso la creazione di condizioni di mercato più adeguate a incentivare la concorrenza fra le imprese. E’ fondamentale per la nostra economia rilanciare l’idea di una politica industriale attiva, che non si limiti a garantire il funzionamento del mercato.
Un aumento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) e formazione dovrebbe essere un obiettivo prioritario della politica economica; è necessario che aumentino i finanziamenti alla ricerca nel settore pubblico (Università e centri di ricerca) e che vengano predisposti validi incentivi alle imprese private che investono in R&S. Gli incentivi al settore privato devono essere finalizzati a introdurre innovazioni di prodotto, mentre fino a questo momento gli incentivi hanno premiato soprattutto l’innovazione di processo che risparmia lavoro e produce un aumento della disoccupazione. L’innovazione di processo non va trascurata, perché permette un ammodernamento della struttura produttiva, ma deve andare di pari passo con l’innovazione di prodotto e non porsi come sostitutiva.
Numerose analisi sottolineano l’importanza dei processi di formazione per creare occupazione di buona qualità. In una fase come quella che stiamo vivendo, caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici, le conoscenze possono diventare rapidamente obsolete e molti lavoratori possono perdere il loro ruolo. In particolare i disoccupati rischiano di perdere l’opportunità di rientrare nel mercato del lavoro se non sono in grado di riqualificarsi. Ma anche i lavoratori meno qualificati corrono il rischio di esclusione dal mercato del lavoro. In questo contesto assumono un particolare rilievo le politiche di formazione continua, sia sul posto di lavoro che fuori.
Si dovrebbe intervenire per fornire moderne infrastrutture in molte parti del paese che in questo campo presentano ancora segni di arretratezza. In particolare è importante creare infrastrutture adatte all’espansione dei settori più moderni. Nel nostro paese appaiono particolarmente carenti le infrastrutture di trasporto.
Sono necessarie azioni di sostegno per i settori in declino non solo attraverso politiche di aiuti alle aziende in crisi, bensì con misure mirate allo sviluppo di nuove attività e capacità.
Il nostro sistema industriale è caratterizzato da un gran numero di piccole e micro imprese e dalla presenza estremamente ridotta di complessi industriali di grandi dimensioni. E’ importante dunque incentivare i processi di crescita delle piccole e medie imprese, perché le dimensioni ridotte non consentono spazi sufficienti per avviare i processi di R&S necessari per accrescere la competitività del nostro sistema industriale.
Queste politiche sono essenziali affinché l’Italia possa essere presente nei settori innovativi, che negli ultimi anni hanno registrato una dinamica della domanda più sostenuta. La ricerca di oggi significa la crescita di investimenti nei settori innovativi domani e perciò più occupazione e soprattutto occupazione più qualificata. Se la specializzazione settoriale continuerà ad essere in comparti tradizionali, a domanda stagnante, in un mondo globalizzato l’Italia continuerà a perdere quote di mercato a favore dei paesi in via di sviluppo, dove il costo del lavoro è comunque più basso, e i problemi della disoccupazione, del basso tasso di occupazione e della scarsa qualità dei posti di lavoro creati diventeranno sempre più pressanti.
9.3 La flessibilità
La maggior parte degli economisti contemporanei colloca il problema della disoccupazione nel contesto di una teoria sui fallimenti del mercato in ambito microeconomico. Perciò le politiche suggerite per combattere la disoccupazione consistono in interventi volti a rimuovere gli elementi che ostacolano il libero funzionamento del mercato del lavoro, mentre vengono considerati inutili gli interventi macroeconomici. In questo ambito l’attenzione è rivolta alle politiche che consentono una maggiore flessibilità dei contratti di lavoro e dei salari. L’opinione dominante, infatti, è che l’elevato tasso di disoccupazione in Europa presente anche prima della crisi attuale dipenda da un’eccessiva rigidità del mercato del lavoro, che non permetterebbe alle imprese di adeguarsi rapidamente ai mutamenti del contesto economico.
In sintesi si ritiene che il mercato del lavoro sia rigido per vari motivi:
- il costo del lavoro è eccessivamente alto sia perché il livello dei salari è mantenuto troppo elevato a causa del forte potere dei sindacati, sia perché i contributi sociali e previdenziali sono eccessivi;
- le imprese che vogliono licenziare devono pagare pesanti indennità, il che rende difficile licenziare; ciò renderebbe le imprese meno propense ad assumere nuovi lavoratori nelle fasi espansive;
- i sussidi di disoccupazione sono troppo elevati e vengono elargiti per periodi di tempo troppo lunghi, il che disincentiva i disoccupati a trovare rapidamente un nuovo lavoro (si noti che questa affermazione non può valere per l’Italia, dato che nel nostro paese i sussidi di disoccupazione sono estremamente ridotti);
- i minimi salariali sono troppo elevati e ciò scoraggia le imprese ad assumere lavoratori poco qualificati, perché il loro costo è eccessivo rispetto al rendimento.
Di conseguenza le politiche proposte per ridurre la disoccupazione vanno nella direzione di una flessibilizzazione del mercato del lavoro. Il termine “flessibilità del mercato del lavoro” può essere usato in accezioni diverse. E’ utile, in primo luogo, individuare le principali forme di flessibilità che sono in questo momento oggetto dell’attenzione degli studiosi .
La flessibilità numerica riguarda la possibilità per le imprese di variare l’occupazione sulla base dell’andamento della domanda. Essa può essere realizzata sia con l’estensione del ricorso ai contratti a tempo determinato, che consentono di aumentare le assunzioni nei periodi di picchi produttivi, sia con l’allentamento dei vincoli ai licenziamenti nel caso di contratti a tempo indeterminato.
La flessibilità temporale permette alle imprese di variare il numero di ore lavorate in relazione alle esigenze produttive. Può realizzarsi attraverso forme di variabilità degli orari, utilizzo di “banche ore”, creazione di turni di lavoro inconsueti, ad esempio nei giorni festivi o di notte, introduzione di tipologie contrattuali, quali il “lavoro a chiamata”. Tale tipo di contratto, di recente introdotto nel nostro ordinamento, prevede la possibilità per i datori di lavoro di occupare i lavoratori solo quando le esigenze produttive lo richiedono (nei periodi in cui i lavoratori non lavorano è prevista una modesta indennità di disponibilità).
La flessibilità del costo del lavoro riguarda diversi aspetti delle retribuzioni. Un primo aspetto è la flessibilità salariale, che permette di ancorare le retribuzioni all’andamento dei risultati dell’impresa. Un’altra forma di flessibilità del costo del lavoro riguarda la decontribuzione degli oneri sociali e fiscali in base a particolari situazioni locali o particolari tipi di lavoro (ad esempio quelli meno qualificati e certe forme di contratti atipici). Rientra in questo tipo di flessibilità anche la riduzione dei minimi salariali. Infine la flessibilità del costo del lavoro può essere realizzata attraverso sistemi di contrattazione salariale centralizzata che permettono di ancorare l’incremento dei salari all’andamento dell’inflazione in una prospettiva di moderazione salariale.
Dunque con il termine flessibilità si possono intendere concetti molto diversi come diversi sono gli approcci al problema dell’introduzione delle varie forme di flessibilità. Da un lato c’è un approccio orientato unicamente alle imprese, che mira a una completa deregolamentazione del mercato del lavoro, dall’altro ci sono approcci più “soft”, che mirano a conciliare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori e propongono di affiancare alla flessibilità ammortizzatori sociali, per sostenere i redditi e garantire le tutele in termini di sicurezza sociale e previdenza dei lavoratori “intermittenti” .
Le politiche volte ad aumentare la flessibilità numerica e temporale e a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sono state perseguite con molta determinazione in numerosi paesi europei, senza dare tuttavia i risultati attesi dai loro sostenitori.
Con la diffusione dei contratti di lavoro atipici, e in particolare dei contratti a tempo determinato (che hanno consentito un aumento della flessibilità temporale), si sono creati molti lavori sottopagati e dequalificati. E’ certo che molti lavori atipici sono stati sostitutivi e non aggiuntivi rispetto ai lavori stabili a tempo indeterminato; forse le nuove forme di lavoro atipico hanno contribuito a creare anche nuovi posti di lavoro, ma certamente hanno causato un aumento delle sperequazioni fra lavoratori e non hanno dato un contributo decisivo alla lotta contro la disoccupazione, che ha continuato a crescere in numerosi paesi europei. La flessibilità temporale ha inoltre l’effetto di aumentare la reattività dell’occupazione alle fluttuazioni economiche, cioè provoca un pronto aumento dell’occupazione nelle fasi espansive e una rapida caduta dell’occupazione in fasi recessive e quindi tende ad accentuare le fluttuazioni cicliche dell’economia.
In Italia esistono numerosi strumenti che permettono un’ampia flessibilità del costo del lavoro. Il costo del lavoro reale per unità di prodotto dal 1993 al 2001 è diminuito nella maggior parte dei paesi europei e in particolar modo in Italia (dove è sceso di oltre il 10%); in Italia dal 1993 sono scese anche le retribuzioni reali, mentre crescevano negli altri paesi europei, ma ciò non sembra aver dato un contribuito di rilievo all’occupazione. Anzi, la fase di espansione occupazionale che ha caratterizzato tutti i paesi europei dopo il 1995, è stata più contenuta in Italia che in Francia e Gran Bretagna, dove le retribuzioni reali erano nettamente in crescita. Si può ragionevolmente ritenere che il calo delle retribuzioni reali in Italia non abbia permesso il rilancio della domanda di consumi e, di conseguenza, sia stato la causa di una più contenuta crescita dell’occupazione.
---------------------------------------------------------------------
La parte che segue è tratta, da “Quaderni di rassegna sindacale – Lavori” n. 1, 2001”. Sono stati fatti alcuni aggiornamenti.
Il lavoro atipico: tendenze e conseguenze
di Lia Fubini
Premessa
La crisi del modo di produzione fordista e l'emergere di un nuovo regime tecnologico hanno dato vita a soluzioni organizzative che comportano un uso diverso del fattore lavoro. I nuovi modelli produttivi hanno ampliato la divaricazione fra manodopera specializzata e lavoratori con qualificazioni medio-basse, creando un aumento dei differenziali salariali e una tendenza alla deregolamentazione del mercato del lavoro: si è sviluppato un orientamento liberista, dove grande enfasi viene posta sulla flessibilità del mercato del lavoro, sulla mobilità e sul rischio.
Il termine flessibilità è spesso usato in modo generico; si tratta in realtà di un concetto complesso, che rimanda a diversi aspetti del mercato del lavoro. In questo saggio l’attenzione sarà rivolta ai “contratti atipici”, attraverso i quali le imprese possono attuare la flessibilità numerica, cioè la libertà di assumere e licenziare, spesso realizzando consistenti risparmi sul costo del lavoro. Seguendo il modello nordamericano, sono stati introdotti nei paesi europei numerosi strumenti contrattuali, volti a ridurre i vincoli alle assunzioni e dimissioni dei lavoratori e a limitare il costo del lavoro, e si è consolidata una struttura duale del mercato del lavoro in cui coesistono nella stessa economia e spesso anche nella stessa impresa lavoratori con contratti stabili e lavoratori precari.
Il lavoro atipico, normalmente definito in contrapposizione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e alle forme tradizionali di lavoro autonomo, comprende i lavori a tempo parziale, i lavori dipendenti temporanei (quali i contratti di formazione lavoro, varie tipologie di contratti a termine, apprendistato, borse lavoro, piani di inserimento professionale, lavoro interinale), nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di lavoro parasubordinato, che si collocano in posizione intermedia fra lavoro dipendente e lavoro autonomo. I contratti temporanei comportano risparmi notevoli sul costo del lavoro in quanto consentono alle imprese di variare l’occupazione senza vincoli o costi di licenziamento; inoltre numerose forme contrattuali atipiche prevedono per lo più benefici contributivi per le imprese e/o l’acquisizione di forza lavoro a costi ridotti. Il part-time si distingue dalle altre tipologie di lavori atipici: infatti, se regolato da contratto a tempo indeterminato, non si caratterizza né per la temporaneità del contratto, né in linea di principio consente agli imprenditori un risparmio sul costo del lavoro. Ha tuttavia in comune con gli altri lavori atipici la caratteristica di essere una forma contrattuale prevalentemente destinata alla manodopera meno qualificata e per lo più non scelta, bensì accettata “in mancanza di meglio”, che spesso mantiene i lavoratori in posizione marginale e preclude le possibilità di carriera.
La diffusione del lavoro atipico: aspetti interpretativi.
Di fronte alla crescente flessibilità e alla diffusione dei lavori atipici si configurano diverse posizioni.
L’orientamento liberista, emerso ad esempio in alcuni Job Studies dell’OECD e sostenuto da gran parte del mondo imprenditoriale, considera i contratti atipici uno strumento fondamentale per accrescere la competitività e promuovere l'occupazione e la crescita, e ne lamenta l'eccessiva regolamentazione. Si sottolinea che la decisione di assumere viene presa più facilmente se esiste la possibilità di licenziare senza problemi e se, come avviene per la maggior parte dei contratti atipici, si riduce il costo del lavoro. In questo ambito creazione e incentivazione del lavoro atipico vengono considerati elementi positivi, in quanto permettono il dispiegarsi delle libere forze di mercato senza vincoli e rigidità che limitano la crescita e l’occupazione. Tale approccio si basa sulla convinzione che solo con un’organizzazione del lavoro flessibile si possa affrontare la concorrenza internazionale che deriva dai processi di globalizzazione e si possa rispondere alle esigenze organizzative imposte dal modo di produzione post-fordista basato su una sempre più marcata tendenza al decentramento e all'esternalizzazione di gran parte dei processi produttivi; un atteggiamento di tipo conservatore, volto a proteggere “il posto fisso”, viene considerato il retaggio di una struttura obsoleta di organizzazione della produzione e appare perdente perché non risponde alle esigenze della produzione flessibile. E’ opinione diffusa che l’esistenza di un mercato del lavoro duale costituisca il prezzo da pagare per ridurre la disoccupazione e favorire la crescita; a questo proposito viene portato come esempio il caso degli Stati Uniti, in cui la flessibilità del mercato del lavoro avrebbe permesso di mantenere relativamente basso il tasso di disoccupazione , determinando tuttavia un allargamento dei differenziali salariali. Viceversa le rigidità del mercato del lavoro europeo associate a un maggior welfare avrebbero limitato l’aumento delle disuguaglianze causando però un maggior tasso di disoccupazione e una crescita più contenuta.
Gli approcci critici evidenziano i rischi di un punto di vista liberista, che tende a delegare al mercato il problema dell'occupazione attraverso l’utilizzo di strumenti sempre più flessibili senza tenere conto dei fallimenti del mercato. Si mette in risalto come il lavoro atipico disincentivi la qualificazione, aumenti l’instabilità dei livelli occupazionali, comporti un aumento della precarietà del lavoro e un ampliamento dei divari salariali e contribuisca a creare vaste fasce di working poors, come testimonia l’esperienza statunitense. Nel contempo viene messa in dubbio la sua effettiva capacità di accrescere l’occupazione: si evidenzia che nell’Unione Europea il numero di contratti di lavoro flessibili è notevolmente aumentato e che ormai il mercato del lavoro non è più rigido di quello americano, ma ciò non ha determinato incrementi occupazionali di rilievo (Simonazzi e Villa 1999), bensì ha contribuito a creare una crescente disparità di condizioni fra lavoratori protetti e lavoratori marginali. L’ILO (1997) evidenzia come la mancanza di sicurezza del posto di lavoro e le disuguaglianze salariali causino problemi di criminalità, isolazionismo e marginalizzazione e possano comportare seri conflitti sociali. In contrasto con l’approccio liberista, si sottolinea che la buona performance occupazionale americana è il risultato di una crescita più sostenuta, attribuibile fra l’altro a politiche espansive, e che la causa dell’elevata disoccupazione europea non deve essere ricercata nella presenza di rigidità del mercato del lavoro, bensì nelle politiche restrittive perseguite dell’Unione Europea. Si sostiene quindi che l’occupazione si possa accrescere non attraverso la flessibilità bensì con adeguate politiche economiche di ispirazione keynesiana.
La situazione in Italia
La diffusione del lavoro atipico in Italia è un fenomeno relativamente recente rispetto ad altri paesi europei, ma in rapida espansione.
La diffusione dei contratti atipici presenta rilevanti differenze nelle diverse aree del territorio e in relazione al genere, all’età e al livello di scolarità. L’utilizzo di contratti temporanei è percentualmente più elevato al sud che al nord, fra le donne che fra gli uomini, fra i giovani, fra i lavoratori con bassi livelli di scolarità e qualificazione. Il lavoro atipico è diffuso soprattutto fra le fasce deboli della popolazione, ma, mentre nelle aree forti del paese (regioni del Centro-nord) esso spesso costituisce una fase transitoria che precede l’accesso al lavoro a tempo indeterminato soprattutto per i giovani di sesso maschile, nelle aree deboli (Mezzogiorno) e per il personale non qualificato si configura come un elemento di segregazione e discriminazione. (Fellini et al., 2000).
Il lavoro atipico è sostitutivo del lavoro tipico?
A questo punto sorge una questione: la crescita del lavoro atipico è avvenuta a scapito del lavoro tipico o ha costituito un netto aumento occupazionale?
Non sembra esistere un’evidenza certa che permetta di rispondere a tale domanda, almeno nel nostro paese. In certi momenti è possibile che la diffusione di forme contrattuali atipiche abbia contribuito all’aumento dell’occupazione, ma , in linea di massima sembra che il lavoro atipico abbia spiazzato il lavoro tipico. Gallino (1998) esaminando la situazione occupazionale in Italia e in Francia constata che i “lavori atipici, piuttosto che creare occupazione aggiuntiva, man mano che crescono riescono a malapena a recuperare una parte dei posti che ogni anno si perdono nelle grandi aziende, nella piccola distribuzione, e in agricoltura”. Porro (2000) sottolinea che i dati disponibili non permettono una conclusione generale, ma che l’esame dell’evidenza empirica “solleva qualche dubbio sull’effettivo contributo del lavoro temporaneo all’occupazione complessiva”.
Se si considera che il lavoro temporaneo evita alle imprese i costi di licenziamento può essere interessante considerare gli effetti di tale costo sulla domanda di lavoro. In genere, l’assenza di costi di licenziamento accresce il processo di creazione e distruzione di posti di lavoro, per cui favorisce un aumento dell’occupazione nelle fasi espansive del ciclo e una sua diminuzione nelle fasi recessive, può abbreviare la durata dei periodi di disoccupazione, in quanto accresce il turn-over dei lavoratori, ma complessivamente non sembra accrescere la domanda di lavoro. Viceversa la presenza di costi di licenziamento tende a rendere l’occupazione più stabile e alcune ricerche mostrano che possono contribuire ad accrescerla (Bentolila e Bertola 1990; Saint-Paul 1996). Se rivolgiamo l’attenzione alla situazione di altri paesi che, a differenza dell’Italia, hanno un’esperienza consolidata in fatto di contratti atipici, appare evidente che questi non hanno contribuito in modo sostanziale all’incremento dell’occupazione. Si consideri come esempio il caso della Spagna: attraverso l’introduzione nel 1984 di numerose forme di contratti temporanei, a fine anni Ottanta faceva registrare il 30% di occupazione atipica. In una prima fase il tasso di disoccupazione è sceso dal 21,2% del 1986 al 16,2% del 1990, ma dal 1991 ha ripreso a crescere e nel 1994 ha superarto il 24%. Dal 1997 sono state poste restrizioni al lavoro temporaneo e sono stati incentivati i passaggi dei lavoratori da temporanei a permanenti; a tale processo si è accompagnato un sensibile aumento dell’occupazione. Un’analisi comparata nei paesi OECD mostra che la legislazione a protezione del lavoro non ha effetto o ha un effetto minimo sull’occupazione complessiva, ma piuttosto ne influenza la composizione demografica: una protezione maggiore tende ad abbassare il tasso di disoccupazione degli uomini adulti, ma ad elevare quella di altri gruppi, in particolare dei giovani (OECD 1999).
Tenendo conto che una delle più importanti componenti di varie forme di lavoro atipico è la riduzione del costo del lavoro, può essere opportuno richiamare le ricerche condotte sugli effetti sull’occupazione degli sconti sul costo del lavoro. Emerge da numerose indagini svolte presso gli imprenditori sia in Italia che all’estero che le valutazioni in termini di occupazione degli sconti salariali hanno effetti molto modesti e che la maggior parte delle assunzioni sarebbe avvenuta anche in assenza di tali sconti (Zenezini 2000).
I risultati di tali indagini non possono peraltro sorprendere per più di una ragione.
In primo luogo, di fronte a carenza di manodopera le imprese sono indotte ad assumere comunque, anche se ovviamente preferiscono minimizzare il costo del lavoro e il rischio derivante da assunzioni a tempo indeterminato e perciò tendono a privilegiare, quando possibile, il lavoro atipico.
In secondo luogo si tenga conto che molte imprese, specie quelle a tecnologia avanzata, utilizzano fattori di produzione a coefficienti fissi o quasi fissi. In tale situazione data la capacità produttiva dell’impresa, la diminuzione del costo del lavoro non ha effetti significativi sull'occupazione. L’effetto netto sull'occupazione può essere positivo nel breve periodo solo quando esiste una effettiva sostituibilità fra capitale e lavoro; in tal caso le imprese sarebbero indotte dal minor costo relativo del lavoro a utilizzare tale fattore in quantità maggiore.
Per quanto riguarda l’effetto dell’introduzione dei contratti atipici, viene talora sottolineato che la diffusione di tali forme lavorative contribuisca all’emersione del “lavoro nero”. Tuttavia le stime sulle attività economiche informali e sommerse segnalano una crescita del lavoro irregolare nell’ultimo decennio, il che sembra indicare che i contratti atipici non sono stati in grado di risolvere il problema del “lavoro nero”.
Gli effetti sulla crescita
L’enfasi posta sulla flessibilità del lavoro ha portato spesso ad accantonare i problemi economici e sociali che questa può comportare. E’ importante considerare gli effetti della flessibilizzazione dei rapporti di lavoro sulla crescita economica, sul sistema delle imprese e sulle condizioni dei lavoratori.
La diffusione dei contratti atipici crea incertezza di prospettive non solo per i lavoratori temporanei, ma anche per quelli a tempo indeterminato, che si sentono minacciati dalla possibilità di una riduzione delle garanzie sul posto di lavoro. I contratti flessibili prevedono spesso basse retribuzioni e ai lavoratori temporanei è solitamente precluso l’accesso al credito.
L’insieme di questi elementi comporta una limitazione delle spese per consumi e non permette quella crescita della domanda che altrimenti si potrebbe realizzare. Si può obiettare che l’utilizzo di lavoratori atipici consente alle imprese una riduzione dei costi e, di conseguenza, dei prezzi e quindi comporta un’espansione della domanda e perciò dell’occupazione. Tuttavia l’esistenza di una bassa elasticità della domanda rispetto ai prezzi dei beni materiali, la crescente produttività del lavoro e il fatto che un’alta meccanizzazione incide in modo molto elevato sui costi fanno sì che i salari debbano raggiungere livelli davvero molto bassi perché si possa realizzare tale espansione. Ma in tal caso si crea una massa di working poors, il che comporta insostenibili costi sociali ed economici.
Il processo di crescita può essere condizionato dalla diffusione dei contratti atipici nella misura in cui questi generano un processo di sostituzione del capitale col lavoro o del lavoro qualificato con lavoro non qualificato nei settori in cui esiste concretamente tale possibilità. A prima vista tale risultato potrebbe essere valutato positivamente, poiché dimostrerebbe che è possibile, attraverso un maggior utilizzo di contratti atipici, accrescere l’occupazione dei lavoratori più deboli. Tuttavia tale processo ha un effetto negativo sulla produttività e sulla dinamica dell’accumulazione del capitale, scoraggia l’innovazione e rallenta l’introduzione di nuove tecnologie, mentre oggi la crescente globalizzazione richiede un aumento della produttività del lavoro per affrontare la concorrenza internazionale. Dunque la riduzione del costo del lavoro non qualificato può sortire l'effetto perverso di un calo relativo dello stock di capitale a medio - lungo termine, il che costituisce una minaccia alla crescita potenziale, alla competitività e quindi all'occupazione nel lungo periodo. In particolare in zone come il mezzogiorno, dove la disoccupazione è legata all'insufficienza di capitale, la diffusione del lavoro atipico finisce con l’accentuare tale problema.
La politica di flessibilizzazione del lavoro perseguita nei Paesi Bassi a partire dagli anni Ottanta ha avuto come effetto un aumento dell’occupazione, ma il tasso di crescita della produttività è sceso drasticamente; il tasso di innovazione nelle piccole e medie imprese olandesi è stato addirittura sistematicamente più basso di quello delle imprese europee con le stesse dimensioni. I risultati sono stati un invecchiamento dello stock di capitale e un rallentamento nel tasso di crescita della domanda interna, il che ha esposto l’economia a problemi di competitività (Kleinknecht 1998).
La formazione del capitale umano è un fattore cruciale di crescita che rischia di essere ridimensionato dall’utilizzo dei contratti atipici, dato che la temporaneità dei lavoratori limita i processi di apprendimento all’interno dell’impresa e che le imprese non sono incentivate ad investire nella formazione di lavoratori temporanei.
L’impatto sulla performance dell’impresa.
L'utilizzo di lavoratori atipici comporta per l'impresa notevoli vantaggi rispetto alle assunzioni con contratti tipici e ciò ne favorisce la domanda: permette risparmi sul costo del lavoro, evita i costi di licenziamento, dà la possibilità di assumere e pagare i lavoratori solo quando c’è lavoro e perciò di trasferire sui lavoratori parte del rischio dell’imprenditore, riduce la necessità di analisi dell’andamento della domanda e gli investimenti per lo sviluppo delle conoscenze della forza lavoro; inoltre la maggior parte dei lavoratori atipici ricevono retribuzioni mediamente più basse di quelle dei lavoratori tipici. L’insieme di questi elementi dovrebbe consentire un aumento della profittabilità nel breve periodo per le imprese, che di conseguenza dovrebbero aumentare le vendite e quindi gli occupati.
Tuttavia l’enfasi sulla flessibilità ha portato a sottovalutare gli svantaggi causati dall’utilizzo del lavoro atipico. Fra i lavoratori temporanei non può realizzarsi la “conoscenza tacita”, cioè quell'accumulo di conoscenze che si costruiscono attraverso l'esperienza e la sua condivisione e che permettono di creare microinnovazioni all'interno dell'impresa; non s’instaurano altresì quei comportamenti cooperativi che consentono di migliorare i processi produttivi e l’organizzazione del lavoro e minimizzano gli effetti negativi del moral hazard. Tanto più le imprese utilizzano lavoratori atipici, tanto meno possono beneficiare delle innovazioni che si realizzano on the job; inoltre non risulta conveniente investire nella formazione dei lavoratori temporanei e ciò, se da un lato costituisce una fonte di risparmio, dall’altro implica una carenza di competenze. L’utilizzo del lavoro atipico può dunque causare una riduzione del capitale sociale dell’impresa, costringendola a più elevati costi di gestione e di controllo (Kleinknecht et al. 2000). Un’organizzazione tendente a valorizzare le competenze derivanti dalla presenza di lavoratori stabilmente inseriti nell’attività produttiva comporta quindi costi iniziali più elevati, ma può permettere maggiori ritorni nel lungo periodo.
In teoria è difficile prevedere se a livello di singola impresa prevalgono gli aspetti positivi o negativi, cioè se dominano i vantaggi in termini di costi o le perdite in termini di capitale umano e sociale, anche perché bisogna considerare che gli effetti positivi per l’impresa sono immediati mentre quelli negativi si manifestano con un certo ritardo. Ma senza dubbio l’effetto di rallentamento della crescita che può derivare dalla diffusione del lavoro atipico non può che ripercuotersi negativamente sul sistema delle imprese. Si può ritenere che ogni singola impresa, di fronte alla possibilità di utilizzare il lavoro in modo flessibile, si trovi teoricamente in una situazione del tipo “dilemma del prigioniero”. Ogni impresa può trarre un vantaggio in termini di costi dall’uso del lavoro atipico, specie se questo non viene utilizzato dalle concorrenti. Se viceversa, a differenza delle imprese concorrenti, non impiega il lavoro flessibile si troverà ad operare in una situazione di costi più elevati. Ma se il lavoro atipico diventa un fenomeno generalizzato, tutte le imprese saranno penalizzate dai suoi effetti negativi sulla crescita. Date queste circostanze, s’impone la necessità di un intervento normativo che limiti l’utilizzo del lavoro flessibile non solo per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, ma anche per creare condizioni ottimali di crescita.
I costi per i lavoratori
Lo sviluppo del lavoro atipico rischia di creare un mercato del lavoro frammentato, caratterizzato dalla presenza di un numero sempre più ristretto di lavoratori privilegiati con contratti a tempo indeterminato e una fascia sempre più ampia di lavoratori precari, coperti da un debole sistema di protezione sociale, a cui vanno aggiunti i lavoratori del sommerso, completamente privi di garanzie. Anche il lavoro part-time, pur rispondendo in certi casi alle necessità di certe fasce di lavoratori, costituisce uno strumento di esclusione dalle carriere. Le imprese privilegiano infatti il part-time per mansioni ripetitive, lavori particolarmente pesanti e dequalificati.
La stabilità e la dignità dell’attività lavorativa rappresentano un bisogno fondamentale riconducibile a diverse esigenze dei lavoratori. A questo proposito assumono particolare rilievo:
a) la certezza del reddito. Nei contratti a tempo determinato non è garantita la continuità delle retribuzioni; di conseguenza viene limitata la possibilità di programmare il futuro. Ai lavoratori a tempo determinato è normalmente negata anche la possibilità di acquisti rateali, dato che mancano le garanzie che può offrire un lavoratore a tempo indeterminato. Il problema si propone anche per il reddito differito: discontinuità del lavoro significa anche discontinuità dei contributi previdenziali;
b) la sicurezza del lavoro. La continuità del lavoro soddisfa il bisogno di sicurezza e costituisce un elemento di identità e di rapporti sociali, dà il senso di appartenenza a una comunità e contribuisce all'autostima del lavoratore. Come è ormai documentato da un’ampia letteratura, l’incertezza relativa al posto di lavoro è, al pari della disoccupazione, fonte di ansia, depressione e stress ;
c) la garanzia dell’impiegabilità. Il lavoro atipico raramente offre la possibilità di acquisire e sviluppare nel tempo capacità professionali (Grazier 1990) e quindi l’opportunità di migliorare l’occupabilità attraverso processi di apprendimento e di riqualificazione. Molti lavoratori atipici che appartengono alle fasce deboli corrono perciò il rischio di cadere nella trappola dell’esclusione, passando da un lavoro dequalificato all’altro attraverso periodi di disoccupazione.
La regolazione del lavoro atipico.
Se la flessibilità viene considerata dalle imprese, a torto o a ragione, un elemento di nodale importanza, per i lavoratori la sicurezza è un bisogno primario. Si pongono quindi nuovi problemi di regolazione del lavoro. Una posizione di rifiuto del lavoro atipico oggi appare irrealistica; si deve dunque affrontare il problema della sua regolazione attraverso un’adeguata politica economica e sociale che permetta di limitare i rischi per i lavoratori.
Per quanto riguarda la sicurezza del reddito è necessario predisporre una serie di strumenti assicurativi e previdenziali in grado di garantire la continuità del reddito presente e un congruo livello di reddito nell’età della pensione. Si potrebbe pensare a adeguati sussidi di disoccupazione e forme di integrazione previdenziale nei periodi in cui i lavoratori sono disoccupati.
Il problema della sicurezza del lavoro dovrebbe essere affrontato incentivando le assunzioni a tempo indeterminato, ad esempio attraverso sgravi alle imprese che assumono lavoratori stabili. E’ importante inoltre portare avanti efficaci politiche attive per il lavoro che costituiscano una garanzia di impiegabilità, per esempio attraverso il miglioramento dei servizi di job placement. Si potrebbero favorire forme alternative di flessibilità, quali l’utilizzo di premi di risultato o la condivisione dei profitti che, pur implicando l’assunzione da parte dei lavoratori di parte del rischio di impresa, hanno il vantaggio di stimolare l’impegno dei lavoratori e i processi di apprendimento e di stabilizzare l’occupazione (Biagioli 2000), mentre i contratti atipici accentuano le fluttuazione cicliche dell’occupazione.
L’impiegabilità potrebbe essere migliorata attraverso politiche formative mirate. E’ importante muoversi in un’ottica di formazione permanente, dato che la possibilità di mantenere il lavoro o di passare a nuovi lavori dipende in larga misura dalla preparazione e dall’esperienza. Si potrebbe pensare di colmare i periodi di disoccupazione dei lavoratori temporanei con corsi di aggiornamento e di formazione.
Inoltre, poiché l’utilità del lavoro atipico per le imprese varia da settore a settore sarebbe opportuno studiare l’attuazione di misure diverse a seconda dei settori, per evitare che certe forme contrattuali finiscano con l’essere solo un regalo per gli imprenditori e un danno per i lavoratori, senza nessun effetto positivo per l’occupazione. I contratti atipici, opportunamente regolamentati, possono infatti incentivare assunzioni che altrimenti non si sarebbero fatte in certi settori, specie quelli caratterizzati da un’alta variabilità e imprevedibilità della domanda, ma sono certamente inutili se non dannosi in altri, soprattutto in quelli che utilizzano tecnologie avanzate.
Bibliografia
Amedeo E. J. , Horton S. (1997) “Labour Productivity and Flexibility”, London, MacMillan Press
Bettio F., Rosenberg S. (1999) “Labour markets and flexibility in the 1990s: the Europe-USA opposition revisited” International Review of Applied Economics, vol 13, n.3
Bentolila S., Bertola G.(1990) “ Firing costs and labor demand: How bad is Eurosclerosis?” , Review of Economic Studies n.57
Biagioli M. (2000) “Partecipazione dei lavoratori ai risultati economici delle imprese e politica della concertazione” in Fubini L. (a cura di) “Strategie per l’occupazione”, Roma, CarocciBurchell B.J. (1994) “ The effects of labour market position, job insecurity and unemployment on psychological health” in D. Gallie, C. Marsh, C. Vogler (editors) “Social Change and the Experience of Unemployment”, Oxford, Oxford University Press
Fatiguso R. (2000) “Olanda, flessibilità fuori moda” Il sole 24 ore, 13 agosto
Cerruti G. (2000) “ Il modello di analisi: flessibilità e sicurezza nelle politiche del lavoro” in Cerruti G., Di Monaco R., Follis M. (a cura di) “Flessibilità d’impresa e sicurezza del lavoro”, Milano, Franco Angeli Fellini I., Mazzolari F., Samek Lodovici M., Semenza R. (2000) “Nuove forme di lavoro e differenze territoriali in Italia”, Istituto per la Ricerca Sociale - Contributi di ricerca Irs n.52, Novembre, Milano
Gallino L. (1998) “Se tre milioni vi sembran pochi”, Torino, Einaudi
Grazier B., (1990) “L'employabilitè: brève radiographie d'un concept en mutation” in Sociologie du travail n.4
ILO (1997) “World Labour Report 1997-98”, Geneva, International Labour Office
IRES (a cura di) (2000) “Il lavoro atipico: tendenze e ruolo nell’occupazione italiana”, supplemento al numero 35 di Rassegna SindacaleISTAT (1998) “Indagine sulle forze di lavoro”, Roma
ISTAT (2000a) “Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro”, luglio, Roma
ISTAT (2000b) “Rapporto sull’Italia –edizione 2000”, Bologna, Il Mulino
Kleinknecht A. (1998) “Is wage restraint harmful to innovation?” paper presentato al workshop “Full employment in Europe”, 30 giugno, London
Kleinknecht A., Oostendorp R.M., Pradhan M.P. (2000) “Patterns of flexible labour and firm performance in the Netherlands: Exploring the OSA labour supply and demand panels”, working paper of the thematic TSER network “Full employment in Europe”, Delft
OECD (1994) “The OECD Job Study, Evidence and Explanations, Part II”, Paris
OECD (1999) “Employment outlook”, giugno, Paris
Ortona G. (2000) “Il Mercato del lavoro americano”, Nuvole n.16, maggio
Porro G. (2000) “I lavori atipici in Lombardia: confronti con l’Italia ed altri paesi” in Marelli E., Porro G. “Il lavoro tra flessibilità e innovazione”, Milano, Franco Angeli
Saint-Paul G. (1996) “Dual Labor Markets” Cambridge Massachusetts, The MIT Press
Simonazzi A., Villa P.(1999) “Flexibility and growth”, International Review of Applied Economics, Vol. 13, n. 3
Zenezini M. (2000) “Perché non funzionano le politiche del lavoro?”, working paper presentato al convegno “Vincoli macroeconomici e politiche strutturali”, 5-7 luglio, Bergamo
-----------------------------------------------------------------------------
9. 3 La flexsecurity
In Italia, come si è detto, sono state introdotte numerose misure di flessibilità che hanno generato una forte precarietà sul mercato del lavoro in particolare con la legge 30 (legge Biagi) del 2003, ma non si sono affiancate misure volte a garantire la sicurezza del reddito a chi rimane disoccupato. I sussidi di disoccupazione sono i più bassi d’Europa. Ricordiamo che il nostro ordinamento prevede l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o strutturale (a seconda che si tratti di difficoltà aziendali di natura congiunturale o strutturale) e il ricorso alla mobilità nei casi di difficoltà aziendali irreversibili.
Con la crisi attuale i lavoratori più colpiti sono i giovani e i precari. Si profila pertanto la necessità di garantire un reddito a quanti sono rimasti senza lavoro. Viene quindi proposto da più parti il modello danese della flexsecurity, cioè flessibilità sul lavoro unita a sicurezza del reddito. In Danimarca i costi di licenziamento sono molto bassi, ma esiste un generoso sistema di assistenza ai disoccupati. Questi ricevono dallo Stato circa il 90% della media dello stipendio delle ultime 12 settimane e hanno diritto di accedere a tali benefici per un massimo di quattro anni. Tali benefici vengono forniti anche ai lavoratori prossimi al pensionamento. Requisito necessario per percepire tali benefici è quello di aver lavorato per cinquantadue settimane nei tre anni precedenti; inoltre, per accedere ai sussidi, i disoccupati danesi devono frequentare programmi di formazione e accettare qualsiasi condizione lavorativa offerta dai centri per l’impiego. Il diritto all’indennità viene perso nel momento in cui si rifiuta una qualunque offerta di posto di lavoro.
La proposta di introdurre il sistema danese incontra riserve per la mancanza di risorse per finanziare tale sistema. Ma, come è stato sottolineato : “ A fronte delle riserve del Governo motivate dalla scarsità di risorse dalle quali attingere, si registra – nel corso degli ultimi mesi – un sostegno deciso da parte di autorevoli economisti e giuslavoristi di orientamento liberista (nonché dall’Unione europea) a politiche che – ispirate all’esperienza danese della flexsecurity – coniughino la flessibilità contrattuale con una presunta ‘sicurezza’ da offrire ai lavoratori nel caso in cui vengano licenziati, secondo un modello noto come flexsecurity
Va detto che, sul fronte liberista, si tratta di una svolta piuttosto significativa rispetto agli orientamenti dominanti nei primi anni Duemila; svolta che può essere spiegata in due modi. Si può ritenere, in primo luogo, che si sia preso atto del fallimento delle politiche di flessibilità del lavoro avviate, in Italia, dalla metà degli anni novanta – con il “Pacchetto Treu” - e che hanno subito una significativa accelerazione con la legge 30/3003 (la cosiddetta Legge Biagi). In effetti, vi è ampia evidenza empirica del fatto che, laddove i lavoratori sono meno protetti, sono minori i salari e, di norma, è minore l’occupazione. In secondo luogo, è possibile che il cambiamento di vedute non sia motivato dalla constatazione del fatto che quelle politiche non hanno generato gli effetti voluti, ma da considerazioni che attengono o all’impopolarità crescente delle politiche di precarizzazione del lavoro o direttamente all’attuale fase congiunturale. In altri termini, appare ragionevole ritenere che coloro che oggi spingono il Governo verso l’attuazione di politiche di flexsecurity – intellettuali comunque di orientamento neoliberista – si siano convinti che il principale problema delle imprese italiane nella crisi attuale è un problema di sbocchi e che, dunque, occorre in qualche modo provare a sostenere la domanda interna.”
9.4 La riduzione dell’orario di lavoro
Negli ultimi anni è stata rivolta particolare attenzione alle politiche di redistribuzione del lavoro. L’idea che sta alla base di tali politiche è che, a parità di orario di lavoro, la disoccupazione aumenta se il tasso di crescita della produttività del lavoro è superiore al tasso di crescita della domanda. In presenza di introduzione di tecnologie labour-saving e/o di ristagno della domanda, dunque, la riduzione dell’orario di lavoro permetterebbe di riassorbire la disoccupazione.
Certamente la tendenza alla riduzione dell’orario di lavoro è un aspetto che ha caratterizzato le società industrializzate fin dalla nascita del lavoro subordinato , ma solo con la grande depressione degli anni trenta il tema della riduzione di orario accompagna il dibattito sulla disoccupazione. Nel secondo dopoguerra, in una situazione di piena occupazione, le riduzioni di orario hanno avuto essenzialmente l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro; con gli anni ottanta, invece, si ritorna ad accostare il tema della disoccupazione con quello della riduzione dell’orario.
Possiamo distinguere due tipi di riduzioni di orario, quelle che prevedono una riduzione proporzionale del salario e quelle che invece contemplano la riduzione di orario a parità di retribuzione.
Al primo tipo appartengono i contratti part-time che hanno conosciuto un notevole sviluppo in vari paesi europei, specie nel nord Europa. In Italia invece la quota di lavoratori part-time è relativamente bassa e molti lavoratori sono occupati part-time non per scelta, ma perché non hanno trovato occupazione a tempo pieno. La scarsa diffusione del part-time nel nostro paese sembra dipendere da due motivi: il livello dei salari reali e la qualità dei lavori part-time. Nei paesi in cui il part-time è più diffuso le retribuzioni reali sono decisamente più elevate che in Italia e una retribuzione part-time consente uno standard di vita dignitoso, mentre nel nostro paese il lavoro part-time è scelto prevalentemente, almeno nelle classi centrali di età, da lavoratrici che vivono in famiglie non monoreddito. Per quanto riguarda la qualità delle occupazioni part-time va detto che in altri paesi Europei, i contratti a tempo parziale vengono stipulati anche per impieghi qualificati, mentre nel nostro paese riguardano prevalentemente le mansioni meno qualificate. Quindi il part-time può creare problemi di marginalizzazione dei lavoratori più deboli, specie quando questa forma contrattuale non è la conseguenza di una scelta, ma dell’impossibilità di trovare lavoro a tempo pieno.
Molte esperienze di riduzione di orario sono state sperimentate a livello di impresa. Ad esempio, anni fa la Volkswagen, per evitare licenziamenti, ha deciso, in accordo con i sindacati, una riduzione dell’orario di lavoro accompagnata da una riduzione meno che proporzionale dei salari. Analoghe finalità hanno in Italia i contratti di solidarietà, che stabiliscono, in particolari situazioni di crisi aziendale, la riduzione di orario con relativa diminuzione della retribuzione, che viene compensata dalla cassa integrazione guadagni nella misura del 50%.
Faccio un esempio molto semplice, solo per chiarire. Se un sindacato territoriale copre l’evasione fiscale delle imprese della zona, sicuramente svolge funzioni utili (nel breve periodo) a quelle imprese e forse anche a chi trova nell’economia sommersa l’unica fonte di lavoro, ma non contribuisce ad arricchire l’economia di risorse che la rendano più forte e competitiva, e difficilmente ne ricava maggiore legittimazione. Se invece collabora alla gestione della formazione professionale, oltre che svolgere una funzione utile per le imprese dà anche un contributo positivo allo sviluppo economico della comunità e rafforza la sua immagine di attore capace di perseguire interessi generali.
Fa eccezione il lavoro interinale che, a differenza degli altri lavori atipici, comporta costi diretti più elevati del lavoro tipico, perché le imprese devono pagare, oltre alle retribuzioni contrattuali, il costo di intermediazione e una quota destinata al fondo per la formazione; ma la flessibilità temporale che presenta tale forma contrattuale lo rende comunque appetibile, come dimostra la notevole crescita del suo utilizzo dal momento della sua introduzione.
E’ comune opinione che il part-time costituisca una scelta delle donne che vogliono conciliare l’attività lavorativa con l’attività di cura; in realtà solo il 23% delle occupate part-time ha scelto volontariamente un orario di lavoro a tempo parziale e tale percentuale scende al 15% nelle donne fra i 15 e i 29 anni (ISTAT 1998).
Si vedano a questo proposito Bettio e Rosenberg (1999) e gli altri articoli contenuti nel numero 3 della “International Review of Applied Economics” dedicato alla flessibilità del mercato del lavoro negli anni Novanta.
Si noti tuttavia che il tasso di disoccupazione americano non è comparabile con quello europeo a causa dei diversi sistemi di rilevazione; se si utilizzassero le stesse modalità di calcolo, le differenze fra Unione Europea e Stati uniti risulterebbero decisamente ridotte (Gallino 1998, Ortona 2000).
Le tendenze e il ruolo del lavoro atipico in Italia sono state analizzati in dettaglio nel supplemento al n.35 di “Rassegna sindacale” (Ires 2000).
Questo dato dovrebbe contribuire a sfatare il mito secondo cui la disoccupazione è generata da eccessive rigidità e che l’utilizzo flessibile del lavoro risolverebbe i problemi occupazionali.
Si noti che nei Paesi Bassi si è verificata un’inversione di tendenza rispetto al lavoro atipico voluta anche dal mondo imprenditoriale; nel 1999, 177000 contratti a tempo determinato sono diventati stabili (Fatiguoso 2000).
Per moral hazard si intende la possibilità di un comportamento disonesto in situazioni in cui questo possa parzialmente sfuggire al controllo. Se fra i lavoratori si instaura un processo di cooperazione e controllo si minimizza il rischio che qualcuno si sottragga all’impegno sul lavoro, rischio che diventa più concreto nei contratti temporanei, che non offrono possibilità di carriera.
La riduzione generalizzata del tempo di lavoro a parità di retribuzione è uno strumento assai dibattuto; è stato sperimentato in Francia con l’adozione dell’orario generalizzato di 35 ore settimanali, equivalente a una riduzione del tempo di lavoro del 10%. Tale processo è stato scaglionato nel tempo, per permettere alle imprese un adeguamento del sistema produttivo ed è stato accompagnato da incentivi finanziari. In ogni caso la legge consente diverse forme di riduzione dell’orario di lavoro da definire nell’ambito della contrattazione di impresa, per esempio mezza giornata di riposo settimanale o una giornata ogni due settimane o un aumento delle ferie annuali. I risultati sembrano essere stati soddisfacenti, dato che, dall’introduzione della legge (1997) al 2000 sono stati creati 1.600.000 posti di lavoro, di cui 350.000 nel 1999 e 500.000 nel 2000 (la migliore performance occupazionale in Francia del XX secolo). Ovviamente la crescita dell’occupazione deve attribuirsi in larga misura alla congiuntura favorevole, tuttavia si stima che circa la metà della riduzione del tasso di disoccupazione sia dovuta alle “35 ore” e che l’attuazione delle “35 ore” abbia contribuito ad un crescita economica in Francia sensibilmente superiore alla media europea. Anche se i giudizi sull’esperienza francese dell’introduzione delle “35 ore” sono contrastanti, anche i critici più agguerriti hanno riconosciuto che la riduzione dell’orario di lavoro ha dato un contributo alla crescita dell’occupazione e le misure di accompagnamento hanno impedito una perdita di competitività delle imprese. Tuttavia il governo francese insediatosi nel 2001 ha ammorbidito la legge sulle 35 ore, consentendo numerose deroghe, e il risultato è stato una nuova crescita del tasso di disoccupazione.
Nonostante i buoni risultati ottenuti in Francia, la politica della riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione è guardata con scetticismo. In effetti si tratta di una politica difficile da realizzare in un solo paese, perché rischia di peggiorare la competitività delle imprese nazionali. Richiede perciò politiche di accompagnamento attraverso incentivi finanziari che nel breve periodo possono peggiorare il saldo del bilancio pubblico. Tuttavia gli effetti sulla crescita sono positivi perché l’aumento dei posti di lavoro e, di conseguenza delle retribuzioni complessive, fa aumentare il reddito e quindi i consumi. Quindi l’aumento del gettito fiscale derivante dalla maggiore occupazione e la diminuzione dell’ammontare totale dei sussidi disoccupazione dovrebbe ridurre l’impatto negativo sul saldo di bilancio pubblico. Il rapporto fra disavanzo e PIL difficilmente si dovrebbe deteriorare perché tale politica ha un effetto positivo sulla crescita del prodotto.
9.5 Le politiche attive
Le politiche attive del lavoro comprendono interventi volti a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di un insieme di politiche piuttosto eterogeneo, che include gli interventi formativi, l’aiuto nella ricerca del posto di lavoro, il sostegno all’inserimento professionale. In pratica lo scopo delle politiche attive è quello di ridurre la disoccupazione frizionale e strutturale e di incentivare la partecipazione alla forza lavoro. Tali politiche sono fortemente consigliate dall’UE.
Esaminiamo alcune possibili politiche attive.
I servizi per l’impiego sono quei servizi di orientamento svolti attraverso centri specializzati che dovrebbero aiutare a ridurre il tempo della ricerca di lavoro. Gli uffici di collocamento dovrebbero svolgere questa funzione, ma, almeno in Italia, si sono rivelati spesso inefficienti.
I sussidi all’occupazione sono quei sussidi elargiti alle imprese per favorire le assunzioni, generalmente mirati all’assunzione di disoccupati di lunga durata o di categorie svantaggiate. Rientrano in questa categoria i cosiddetti contratti a causa mista (apprendistato e contratti di formazione lavoro). I sussidi all’occupazione servono per evitare l’esclusione dal mercato del lavoro dei soggetti deboli.
Gli incentivi all’autoimpiego sotto forma di sostegno monetario e di assistenza tecnica ai disoccupati che intendono avviare un’attività imprenditoriale dovrebbero promuovere lo sviluppo di una nuova imprenditorialità.
I corsi di formazione professionale costituiscono uno degli aspetti più problematici delle politiche attive. Infatti, se in teoria tali corsi dovrebbero fornire una formazione ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, spesso finiscono per costituire solo un “parcheggio temporaneo” per i disoccupati, in quanto raramente sono mirati a soddisfare gli effettivi bisogni delle imprese. Nel nostro paese risultano spesso molto costosi e poco efficaci, tanto che alcuni affermano che il contributo principale all’occupazione è costituito dall’assunzione del personale che svolge i corsi di formazione.
La creazione diretta di posti di lavoro nel settore pubblico e nel settore non-profit, è destinata di solito a categorie svantaggiate e ha il vantaggio di creare posti di lavoro che soddisfano bisogni sociali che altrimenti rimarrebbe insoddisfatta. In Italia, ad esempio, i Lavori Socialmente Utili costituiscono uno schema di creazione diretta di posti di lavoro.
9.6 La strategia europea per l’occupazione
La strategia europea per l’occupazione, varata dal Consiglio Europeo di Lussemburgo nel 1997 e introdotta nello stesso anno nel trattato di Amsterdam, prevedeva la pubblicazione annuale di raccomandazioni specifiche per gli stati membri in materia di occupazione e la preparazione da parte degli stati membri di piani di azione nazionali.
La strategia di Lisbona, lanciata enfaticamente nel 2000 come impegno per le questioni occupazionali e sociali, che avrebbe dovuto controbilanciare il ruolo egemonico delle politiche monetarie e fiscali. In realtà è diventata un contenitore vuoto, un arnese fatto di indicazioni, orientamenti, pilastri, ecc., che poggia su basi teoriche fragilissime, subordinato alle politiche monetarie e fiscali. La strategia di Lisbona non è riuscita a raggiungere neppure uno degli obbiettivi prefissati e questo momento di crisi ne evidenzia il fallimento.
La strategia europea per l’occupazione si basa su quattro pilastri:
Il primo pilastro è quello dell’occupabilità. Il suo scopo è quello di modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e di favorire la formazione dei disoccupati.
Il secondo pilastro è quello dell’imprenditorialità e delle politiche attive per l’impiego. L’idea è quella di stimolare la creazione di un maggior numero di posti di lavoro di qualità migliore.
Il terzo pilastro è quello dell’adattabilità. Scopo di tale pilastro è quello di dotare imprese e lavoratori dei mezzi adeguati per adottare le nuove tecnologie e adeguarsi alle nuove condizioni del mercato.
Il quarto pilastro riguarda le pari opportunità e il suo obiettivo è di eliminare gli elementi di discriminazione fra i sessi.
Nell’ottica dei “4 pilastri”, la UE raccomanda al nostro paese di riformare il mercato del lavoro con un attivo coinvolgimento delle parti sociali al fine di aumentare l’occupazione, specie quella femminile. Tali riforme dovrebbero ridurre gli squilibri regionali, promuovere politiche per l’occupabilità, diminuire l’incidenza del lavoro irregolare. In particolare la UE ci raccomanda di:
- accrescere la flessibilità del lavoro, aumentando nel contempo la sicurezza dei lavoratori;
- elevare il grado di partecipazione degli anziani,
- prevenire la disoccupazione di lunga durata di giovani e adulti, migliorando i servizi pubblici all’impiego e accelerando l’introduzione del sistema informativo del lavoro;
- migliorare l’efficacia delle politiche attive per il lavoro;
- migliorare i servizi di sostegno per accrescere l’occupazione femminile;
- adottare una strategia di formazione continua.
Il vero problema della strategia europea per l’occupazione è che mancano interventi coordinati delle politiche occupazionali e sociali. Le politiche monetarie sono ovviamente centralizzate nelle mani della BCE. La politiche fiscali mantengono una maggiore autonomia, ma il loro coordinamento è assicurato dal trattato di Maastricht. Viceversa il coordinamento delle politiche per l’occupazione e delle politiche sociali è affidato a procedure di confronto reciproco e di apprendimento tra stati membri, Le linee guida della strategia europea per l’occupazione non hanno carattere di obbligatorietà.
“Questa configurazione della politica economica europea ha nel tempo inevitabilmente finito per imporre una gerarchia all’agenda europea in cui le politiche del lavoro e dell’occupazione hanno una posizione secondaria rispetto alle politiche macroeconomiche. I mercati del lavoro devono adattarsi all’impianto sostanzialmente rigido delle politiche macroeconomiche e alla “robustezza” della politica economica – stabilità dei prezzi e vincoli del bilancio pubblico – devono corrispondere la moderazione salariale e la flessibilità del lavoro. Nel suo primo rapporto annuale, la Banca Centrale Europea aveva del resto affermato di ritenere impossibile l’uso della politica monetaria per stimolare la domanda aggregata e la crescita, aggiungendo che ogni tentativo in tale direzione avrebbe minacciato la stabilità dei prezzi e avrebbe avuto solamente effetti controproducenti nel lungo periodo. In seguito, la BCE ha più volte presentato questo orientamento come un ferreo imperativo per le riforme dei mercati del lavoro che dovrebbero essere disegnate in modo da aumentare il grado di adattamento dei lavoratori all’evoluzione delle condizioni macroeconomiche.
Tra questi orientamenti e le enunciazioni sul cosiddetto “modello sociale europeo” vi è un evidente contrasto, sul quale è stata più volte richiamata l’attenzione, anche nelle sedi istituzionali europee. In diverse occasioni il Parlamento Europeo ha sostenuto la necessità di riequilibrare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e delle politiche dell’occupazione per evitare che a queste ultime venga assegnato solamente un ruolo residuale (ad es., Parlamento Europeo, 2003). In una direzione analoga, un recente documento della Confederazione dei Sindacati Europei afferma che il ruolo subordinato delle politiche dell’occupazione riflette la prevalenza degli orientamenti monetaristi nel disegno della politica macroeconomica europea.”
9.7 L’impostazione delle politiche del lavoro in Italia
Il contratto a tempo indeterminato è stato per decenni la tipologia contrattuale tipica del lavoro subordinato, praticamente l’unica, ad eccezione dei lavori stagionali e dell’apprendistato, nato come strumento di apprendimento di un mestiere regolamentato nel 1955. Dalla fine degli anni ’70 e soprattutto dalla metà degli anni ’80 si iniziano a normare e diffondere tipologie contrattuali a tempo determinato. Questi interventi, dal punto di vista normativo, sono caratterizzati da 3 momenti rilevanti: il contratto di formazione-lavoro del 1984, conseguente ad un accordo per la riduzione del costo del lavoro del 1983; la legge del giugno 1997 nota come “pacchetto Treu”, conseguente agli accordi governo-imprenditori-sindacati confederali del 1993 e del 1996; la legge 30 del 2003 nota come “legge Biagi”, conseguente all’accordo governo-imprenditori-CISL-UIL del 2002.
Con il contratto di formazione-lavoro (cfl), istituito nel 1984, si muovono i primi passi verso la liberalizzazione del mercato del lavoro. E’ proprio in quegli anni che inizia a diffondersi l’uso di tipologie contrattuali instabili, contratti a termine (che escono dall’ambito del lavoro stagionale), partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative. Il cfl aveva le seguenti caratteristiche: riservato ai giovani al di sotto dei 29 anni, durata massima di 24 mesi, inquadramento due livelli sotto quanto stabilito dai contratti, benefici contributivi per le aziende, divieto di utilizzare nuovi cfl se non veniva assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione lavoro era venuto a termine nei 24 mesi precedenti. Per l'applicazione di tale tipologia di contratto i datori di lavoro non dovevano avere in corso sospensioni di lavoro, aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti. Il cfl prevedeva dei percorsi formativi per i giovani.
La legge 196/1997, il cosiddetto “Pacchetto Treu” è l’ulteriore passo verso la liberalizzazione del mercato del lavoro. L’elemento caratterizzante il pacchetto Treu è l’introduzione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (il lavoro interinale), a cui sono dedicati i primi 11 articoli (su 27 che compongono la legge), con la conseguente nascita delle agenzie interinali. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (agenzia interinale) pone uno o più lavoratori da essa assunti con contratto a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice) o a tempo indeterminato a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa. Prevede dunque un rapporto triangolare tra agenzia di fornitura di lavoro temporaneo, datore di lavoro e lavoratore. Nella legge 196/1997 tale contratto era previsto: a) nei casi di utilizzazione temporanea di personale da adibire a qualifiche non previsti dai normali assetti produttivi aziendali, b) nel caso in cui si rendava necessaria la sostituzione di lavoratori assenti, c) nel caso in cui i contratti nazionali di categoria lo prevedano. Il ricorso al lavoro temporaneo era vietato in una serie di casi fra cui è importante ricordare: a) la sostituzione di lavoratori in sciopero, b) le mansioni il cui svolgimento può rappresentare un pericolo per la sicurezza del lavoratore, c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura nei 12 mesi precedenti (con l’eccezione della sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti), d) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale (tale divieto è stato poi eliminato nel 1999).
Il “Pacchetto Treu” conteneva poi interventi sul part-time e l’orario, sull’occupazione nel settore della ricerca, sull’apprendistato, sui lavori socialmente utili, facilitava l’accesso alla formazione professionalizzante, tirocini e stage, conteneva misure per l’emersione del lavoro nero (con sanatoria e percorso graduale), prevedeva mutui agevolati per nuove attività imprenditoriali giovanili.
Il percorso di riforma del mercato del lavoro in direzione di una sempre maggiore flessibilizzazione ha assistito ad un’accelerazione con il governo di Centro-Destra.
Nel periodo 1996-2001 si era avuto in sostanza, dapprima, un aumento delle forme contrattuali modulate secondo fattispecie più varie rispetto a quella costituita dal lavoro a tempo pieno e indeterminato, assieme alla fine del monopolio pubblico del collocamento. La fase durante la quale ciò è stato realizzato restava tuttavia ancorata ad una concezione di fondo per la quale ogni nuova forma contrattuale (flessibilizzante il regime d’impiego per il solo fatto di essere introdotta) veniva munita di tutta una serie di vincoli e di condizioni normative che potevano essere attenuati solo con il consenso delle parti sociali. In tal modo, si potrebbe dire, s’istituiva un meccanismo per il quale in parte non trascurabile la flessibilità effettiva veniva a dipendere dalla forza negoziale delle parti. Quest’impostazione era coerente con l’idea secondo cui la fine del “fordismo” e la “globalizzazione” avrebbero avuto bisogno di maggiore flessibilità per sostenere la domanda di lavoro, ma non a scapito del ruolo dei sindacati dei lavoratori, importante ai fini della politica dei redditi “concertata” – richiesta anch’essa, si riteneva, nel nuovo contesto economico internazionale. Flessibilità del lavoro, dunque, concertata nel doppio e connesso senso di (moderata) flessibilità dell’impiego e di (moderata) flessibilità del salario, dove i due aspetti potevano tenersi insieme dando pieno e sostanziale significato al termine concertazione, in particolare, per evitare che un eccesso di deregolazione dell’impiego potesse spingere a rivendicazioni salariali eccessive a compenso, o - peggio - ad una perdita significativa e rapida del monte salari nella distribuzione del reddito con effetti negativi dal lato della domanda effettiva e quindi della crescita.
Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30, il Parlamento ha conferito al Governo ampia delega per ulteriori riforme del mercato del lavoro che hanno trovato una prima applicazione con il D. Lgs. 276/2003. Con queste norme è stata rivista in modo fondamentale l’impostazione delle riforme del mercato del lavoro. La centralità torna alla norma imperativa orientata ad ulteriori ampliamenti delle fattispecie contrattuali e alla riduzione di vincoli e condizioni, talvolta perfino tali da comportare problemi di compatibilità con la normativa europea, e retrocede vistosamente il ruolo delle parti sociali. Si tratta, pertanto, di una vera e propria “deregolazione” del mercato del lavoro. Non si tratta cioè più di una sorta di sostituzione di regole rigide (quali quelle della legge) con regole più flessibili (quelle contrattuali), si tratta invece in senso proprio e pieno di un arretramento delle regole a vantaggio del libero funzionamento del mercato del lavoro nel quale conteranno molto di più le “autonome” determinazioni delle singole parti, del singolo lavoratore e del singolo datore di lavoro. Ciò corrisponde, evidentemente, ad un’altra idea circa il meccanismo economico. Si potrebbe dire che in tale concezione è un errore fornire alle parti sociali il terreno per determinare uno “scambio sociale” equilibrato. In essa è presente piuttosto la convinzione che il sindacato dei lavoratori mantiene un orizzonte miope e non riesce a scambiare minori garanzie oggi per maggiore occupazione e sviluppo domani. In tale concezione non è tanto la domanda effettiva che guida lo sviluppo, ma il tasso di profitto e quindi maggiore flessibilità del lavoro e del salario sono considerati indispensabili, e senza vincoli concertativi, per mantenere la competitività in un mondo globalizzato.
I principali tappe del processo di tale riforma sono le seguenti:
- “Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia” presentato dal Ministero del Lavoro del Governo Berlusconi nell’ottobre 2001, alla cui stesura parteciparono alcuni economisti e giuslavoristi, fra cui Marco Biagi. Nel Libro Bianco vengono indicate e linee guida per una riforma del mercato del lavoro.
Per dare attuazione al Libro Bianco e agli accordi contenuti nel “Patto per l’Italia” furono presentati in Parlamento due disegni di legge, uno fu approvato come legge 30/2003, l’altro, che conteneva una delega al governo per attuare la riforma degli ammortizzatori sociali senza che ciò comportasse oneri aggiuntivi per lo Stato, non fu mai approvato.
- La legge 30 del 14 febbraio 2003, composta di soli 10 articoli, delegava il Governo a rivedere la disciplina dei servizi per l’impiego e dell’intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, a riordinare i contratti di tipo formativo a riordinare i contratti a contenuto formativo e di tirocinio, a riformare la disciplina del lavoro a tempo parziale, a disciplinare e/o razionalizzare le tipologie del lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, a disciplinare la certificazione dei rapporti di lavoro al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, a razionalizzare le funzioni ispettive in materia di lavoro e di previdenza sociale .
- La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 entrato in vigore il 24 ottobre.
Nel seguente articolo, tratto dalla rivista “Nuvole”, n. 26, 2005, si approfondiscono la filosofia e i contenuti della legge 30 del 2003
La nuova precarietà del lavoro
di Lia Fubini
Premessa
La flessibilità appare come un elemento distintivo della cultura dominante di questa epoca. In Italia il mito della flessibilità del lavoro è mutuato dal modello statunitense, che peraltro è caratterizzato da crescenti disuguaglianze, da una forte segmentazione del mercato del lavoro e dall’impoverimento di vaste fasce di popolazione. Ma la precarietà del lavoro negli Stati Uniti, come in Gran Bretagna, pur comportando costi sociali rilevanti, non si accompagna a un arretramento delle condizioni dell’economia grazie alla gestione attiva della politica economica. Viceversa, in Italia la precarietà aggrava una situazione di declino dello sviluppo economico.
I documenti dell’Unione Europea, così come quelli delle principali organizzazioni internazionali quali l’OCSE e il Fondo Monetario Internazionale (unica importante eccezione è l’International Labour Office) sono ispirati alla cultura della flessibilità, vista come panacea per risolvere ogni squilibrio. La strategia europea per l’occupazione coniuga però l’idea di flessibilità con quella della sicurezza dei lavoratori e propone un mix di politiche articolate in cui l’idea di flessibilità si affianca a quella di formazione e di tutela dei lavoratori.
In Italia, dagli anni ’80 il tema della flessibilità ha assunto un ruolo centrale nel dibattito sul mercato del lavoro. Una significativa crescita del numero di “contratti atipici” si è avuta all’inizio degli anni ’90 e, successivamente, con la legge 196/1997 (il cosiddetto Pacchetto Treu). Va riconosciuto che la flessibilità era concepita dal legislatore come uno strumento per entrare o rientrare nel mondo del lavoro nella prospettiva di una futura stabilizzazione. Le politiche del lavoro portate avanti negli anni ‘90 sono state concordate con i sindacati e sono state condotte sulla scia di quelle adottate da altri paesi europei.
Il processo di flessiblizzazione del mercato del lavoro ha conosciuto una notevole accelerazione con la legge 30/2003 (la cosiddetta”Legge Biagi”) e i successivi decreti attuativi, in particolare il 276/2003. Sono state introdotte le forme più disparate di lavoro atipico. Quelle che hanno destato maggiori perplessità sono il lavoro a chiamata e lo staff leasing. Sono stati creati nuovi istituti nel quadro di una radicale trasformazione del mercato del lavoro, quali la certificazione, la riforma del collocamento, la normativa sui lavoratori svantaggiati.
Alcuni elementi critici della legge 30
I principali elementi critici della legge 30 e dei successivi decreti attuativi possono essere sintetizzati come segue:
- l’abbandono del principio dell’inderogabilità in senso peggiorativo delle regole nazionali del rapporto di lavoro e l’introduzione del principio della contrattazione individuale;
- l’abolizione del divieto di intermediazione di manodopera;
- la normativa sui lavoratori svantaggiati;
- l’introduzione di nuove forme contrattuali.
Contratti individuali e certificazione. Il principio dell’inderogabilità in senso peggiorativo dei diritti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi (articolo 2113 del codice civile) ha permesso in passato la tutela del lavoratore, ha costretto le imprese ad accettare la normativa nazionale riguardante salari e condizioni di lavoro e ha dato quindi legittimità giuridica alla rappresentanza sindacale. La nuova riforma prevede la possibilità per il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, di derogare alle regole. Con la certificazione dei contratti di lavoro istituita “al fine di ridurre il contenzioso” in materia di contratti di lavoro, si possono “certificare le rinunzie e le transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”. Certamente il ricorso alla certificazione prevede il consenso di entrambe le parti, ma è evidente che il lavoratore è la parte debole che può essere costretta a “rinunzie e transazioni” per ottenere il posto di lavoro. La possibilità di stipulare contratti individuali che prevedano la rinuncia a dei diritti può avere risvolti negativi per la rappresentanza e la tutela dei diritti dei lavoratori. Ma l’aspetto più inquietante è che fra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti ci sono gli enti bilaterali costituiti da sindacati e associazioni imprenditoriali. In pratica si richiede ai sindacati di essere i garanti delle rinunce a diritti previsti dalla contrattazione sindacale. Si crea perciò un conflitto fra il tradizionale ruolo del sindacato e la funzione degli Enti bilaterali.
Abolizione del divieto di intermediazione di manodopera. Con l’introduzione del lavoro interinale nel 1997 veniva rotto il tabù dell’intermediazione, ma questa veniva considerata un’eccezione; l’ambito di utilizzo del lavoro interinale era comunque limitato. Con la legge 30 si elimina praticamente la 1369/60 che regolamentava il “divieto di intermediazione di mano d’opera”. Viene introdotta la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, o staff leasing, e vengono ampliate le possibilità di utilizzo di somministrazione a tempo determinato. Si allarga anche il numero di soggetti abilitati alla somministrazione. Sono autorizzati all’intermediazione non solo le vecchie agenzie interinali, ma anche gli enti più disparati, come le università pubbliche e private, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, gli enti bilaterali. Si tenga presente, poi, che viene previsto anche il contratto di appalto che si distingue dalla somministrazione di manodopera semplicemente perchè gli appaltatori di servizi, a differenza delle agenzie autorizzate, devono organizzare e dirigere direttamente la manodopera, il che consente a quanti intendano esercitare intermediazione di manodopera di aggirare i requisiti richiesti ai soggetti abilitati alla somministrazione. Possiamo dunque concordare con le analisi dei sindacati che parlano di legalizzazione del caporalato.
Nel caso di somministrazione e di appalto di manodopera, il datore di lavoro non assume la responsabilità dei lavoratori. Si profila la possibilità di imprese senza lavoratori propri. Pertanto il ruolo della rappresentanza sindacale diventa problematico, dato che manca un rapporto formale fra l’imprenditore e il lavoratore, per cui viene meno il diritto di rappresentanza nei luoghi in cui si svolge effettivamente la prestazione di lavoro. Si tende inoltre a separare la condizione dei lavoratori all’interno dello stesso luogo di lavoro.
Particolarmente grave è il tentativo di coinvolgere il sindacato nell’intermediazione di manodopera; si cerca infatti di affidare al sindacato il ruolo di ufficio di collocamento. Come ovvio, se tale tentativo avrà successo, sarà incentivata l’iscrizione ai sindacati che si occupano di somministrazione di manodopera, penalizzando quei sindacati, in primis la Cgil, che rifiutano tale ruolo.
Anche la possibilità di coinvolgere scuole e università, anche private, nella somministrazione di lavoro, nonché nei meccanismi di certificazione, non è privo di gravi risvolti negativi. Possiamo immaginare la competizione fra gli istituti superiori e fra le università nell’ambito della funzione di agenzia per il lavoro; in tal modo alla primaria funzione di formazione e ricerca si sostituisce la capacità di procacciare posti di lavoro. In ogni caso l’estensione del numero di enti autorizzati alla somministrazione di manodopera è destinata a creare conflitti e confusione.
I lavoratori svantaggiati.
Fra le varie norme che tendono a svilire la figura del cosiddetto lavoratore svantaggiato (che peraltro è una categoria molto ampia che comprende una quota consistente della forza lavoro), vale la pena citarne alcune:
- Il lavoratore decade dalle liste di mobilità, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata alla stato di disoccupazione se non accetta l’offerta di lavoro con un contratto di durata di almeno 6 mesi inquadrato in un livello retributivo non inferiore all’80% rispetto alle mansioni di provenienza (ad ogni scadenza contrattuale, dunque, la retribuzione può essere inferiore del 20% rispetto a quella precedente). Il luogo di lavoro deve essere raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici dalla località di residenza.
- Al fine di consentire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati, all’agenzia di somministrazione è consentito stipulare contratti in deroga rispetto ai contratti collettivi nazionali e di detrarre dal compenso dovuto indennità e sussidi di disoccupazione eventualmente percepiti dal lavoratore. Ad esempio, un lavoratore che ha diritto a un sussidio di disoccupazione per la durata di 12 mesi è costretto, per non perdere il sussidio, ad accettare un’offerta di lavoro, poniamo per 12 mesi secondo le modalità di cui sopra e, allo scadere del contratto, si ritrova senza lavoro e senza sussidio.
- L’aspetto forse più grave è la normativa sui lavoratori disabili che prevede la possibilità di segregare i disabili in apposite cooperative; l’impegno ad assegnare commesse di lavoro a tali cooperative elimina il vincolo all’assunzione preliminare per i lavoratori disabili che fino ad ora veniva garantito al fine di promuoverne l’inserimento nella società. E’ evidente in questa norma l’obiettivo di emarginare qualsiasi elemento “di disturbo” per le imprese, quali il lavoratore disabile, cancellando l’idea del ruolo del lavoro come motore di integrazione sociale.
Le nuove tipologie di lavoro. Non è possibile in questa sede esaminare le numerose forme di contratti atipici previste nei decreti attuativi della legge 30. Si è già accennato allo staff leasing. Vale la pena soffermarsi su un’altra fra le forme contrattuali più discusse e cioè il lavoro a chiamata, che è stato definito da più parti “la massima mercificazione del lavoro”. Tale contratto si rivolge ai soggetti più deboli, e prevede che il lavoratore si metta “a disposizione del datore di lavoro per il soddisfacimento di esigenze di carattere occasionale, transitorio, intermittente o discontinuo”. Il lavoratore intermittente ha diritto a un’indennità di disponibilità pari a non meno del 20% della retribuzione, indennità che non viene corrisposta in caso di malattia e che dovrà essere restituita in caso di mancata risposta.
La filosofia della legge
L’aspetto critico della nuova legge non è tanto il numero di forme contrattuali, che contribuisce a creare ulteriore confusione in una situazione già sufficientemente caotica, né la creazione dei nuovi istituti che tendono a destrutturare le garanzie individuali e collettive dei lavoratori, quanto la filosofia che la ispira.
La legge 30 segue la logica che ha guidato gli estensori del Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia presentato dal Ministero del Lavoro nell’ottobre del 2001. Uno degli obiettivi chiave della politica del lavoro, secondo il Libro Bianco, deve essere quello di cambiare in modo radicale il sistema di tutele di cui gode tradizionalmente il lavoratore dipendente, trasformando il sistema di regole su cui si reggono i rapporti di lavoro, costruito a partire dal dopoguerra, in un sistema di tutele operanti nel mercato. “Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva sul mercato del lavoro” . Ciò significa passare, come usa dire fra gli economisti fautori di tale punto di vista, da una tutela on the job a una tutela in the market. Questo approccio si basa sull’ipotesi, mai dimostrata, che la tutela del rapporto di lavoro vada a scapito dell’occupazione, soprattutto dell’occupazione delle fasce deboli della popolazione. Il moltiplicarsi di formule contrattuali atipiche e l’estensione dei servizi all’impiego aumenterebbero le opportunità occupazionali, in particolare per le fasce deboli della forza lavoro, rendendo le tradizionali tutele legislative e la contrattazione collettiva centralizzata inutili, se non dannose, in quanto costituirebbero un ostacolo alle nuove assunzioni. Si eviterebbe così l’emarginazione delle categorie svantaggiate. Come dimostra l’esperienza dei paesi anglosassoni, questa logica tende a creare un mercato del lavoro duale, con una fascia crescente di working poors, dato che la liberalizzazione “secondo le regole del mercato”, non fa che indebolire il potere contrattuale dei lavoratori meno qualificati specie quando manca un adeguato sistema di ammortizzatori sociali.
La logica “liberista” che guida il Libro Bianco basata sulla presunta capacità del mercato di appianare ogni squilibrio contiene alcuni elementi di continuità con la filosofia che ha guidato le politiche per il lavoro nell’ultimo decennio in Italia. Tuttavia gli elementi di discontinuità sono prevalenti. Negli anni ’90, come si è visto, si era perseguita una politica contrattata col sindacato di precarizzazione del lavoro volte a favorire la flessibilità in entrata; nella nuova legge, viceversa, con il ridimensionamento delle tutele dei lavoratori salariati e l’introduzione di varie forme di contratti atipici che spersonalizzano la funzione del lavoratore si è passati ad una mercificazione vera e propria del lavoro.
Si noti che se nel Libro Bianco era citato, seppure in modo generico, l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro, al fine di evitare l’esclusione sociale, nella legge 30 non si trovano provvedimenti concreti che tendano a tale obiettivo. Viene abbandonata la concezione del lavoro come fonte di realizzazione dell’individuo e di coesione sociale, ed è implicita l’idea del “lavoro purchè sia”, del “meglio un lavoretto precario e sottopagato che niente”. Non è un caso che il Libro Bianco insista sull’idea di tutela del lavoro e non del lavoratore e proponga un nuovo “statuto dei lavori” in sostituzione dello “statuto dei lavoratori”, considerato rigido e obsoleto. Obiettivi più o meno espliciti sono: l’abbassamento delle tutele dei lavoratori dipendenti, l’eliminazione della centralità del lavoro a tempo indeterminato, lo svuotamento della funzione di rappresentanza sindacale e il mantenimento di un basso costo del lavoro. E’ questa, d’altra parte, la filosofia di quanti sostengono la tesi della tutela del lavoratore attraverso il mercato, smentendo così la lezione di Adam Smith, sempre citato per la “mano invisibile del mercato”, ma molto raramente ricordato per la sua appassionata difesa delle coalizioni dei lavoratori.
Gli obiettivi della legge 30
La legge 30 ha molti elementi in comune con la riforma Hartz in Germania; ma, a differenza di questa, non è nata sulla base di esigenze concrete di riformare il mercato del lavoro al fine di accrescere l’occupazione, o la mobilità del lavoro, o di moderare livelli salariali troppo elevati, o di mettere un freno a un eccessivo livello di conflittualità. E’ mia opinione che la flessibilità non determini aumenti occupazionali di rilievo e che, in ogni caso, vada a scapito della qualificazione della forza lavoro ; infatti esiste uno stretto legame fra stabilità dell’occupazione e sviluppo delle competenze dei lavoratori. Tuttavia, dato che il pensiero dominante ritiene che la flessibilità possa portare a un aumento dell’occupazione, si potrebbe ritenere che la legge 30 sia stata dettata dalla eccessiva rigidità del lavoro in Italia, che avrebbe costituito un freno alla crescita dell’occupazione. Ma, come si è visto, negli anni ‘90 sono state introdotte numerose forme di contratti flessibili e, come mostra una ricerca condotta da Contini, la mobilità del lavoro in Italia è superiore a quella dei partners europei, ad eccezione del Regno Unito . Peraltro dal 1995, cioè prima ancora della legge Treu, si è registrata una buona performance occupazionale; infatti dal 1996 al 2003 l’occupazione è cresciuta in media dell’1,2% l’anno.
Né si sentiva la pressante esigenza di comprimere i livelli salariali. I salari reali in Italia sono relativamente bassi, se confrontati con i principali paesi industrializzati e per tutti gli anni ‘90 la dinamica salariale è stata decisamente contenuta; in certi momenti i salari reali sono addirittura scesi, mentre crescevano nel resto dell’Unione Europea. Come viene evidenziato nell’articolo di Tronti, la dinamica salariale estremamente contenuta ha rallentato la domanda di consumi e quindi è stata un ostacolo alla ripresa economica.
La determinazione con cui si sono perseguiti gli obbiettivi indicati dal Libro Bianco deriva essenzialmente dall’incapacità di portare avanti adeguate politiche industriali.
Il tessuto industriale italiano è caratterizzato da una miriade di piccole imprese che operano per lo più in settori a tecnologia matura e sono in competizione con le imprese dei paesi in via di sviluppo. Le grandi imprese italiane sono sparite o in crisi; il settore dei servizi avanzati non ha tenuto il passo con gli altri paesi industrializzati. In assenza di serie politiche economiche volte a rilanciare la competitività del sistema industriale attraverso investimenti in ricerca e formazione, l’unica soluzione per aiutare le imprese a essere competitive sui mercati internazionali è parsa dunque quella di utilizzare il lavoro in modo sempre più flessibile, in modo da ridurne sempre più il costo. Le imprese, anziché sviluppare strategie innovative, si adagiano sulla loro inefficienza, scaricandone l’onere sul fattore lavoro. Si incentiva così la competitività sul prezzo e non sulla qualità. E’ una sfida perdente e gli effetti negativi di tale politica non hanno tardato a farsi sentire. La nostra produzione perde competitività sui mercati internazionali, nonostante il basso costo del lavoro e la flessibilità.
Un altro dato allarmante riguarda la produttività del lavoro: in tempi recenti è calata. Un calo nel tasso di crescita della produttività nelle economie industrializzate è fisiologico: aumenta il peso del settore dei servizi e cala quello dell’industria; dato che mediamente la produttività nel terziario è più bassa che nel manifatturiero è normale che la crescita della produttività rallenti. Ma un conto è un rallentamento nella crescita, o un calo momentaneo, un conto è un decremento che, come avviene in Italia, si manifesta per anni. Una prolungata caduta della produttività è sintomo di una profonda crisi industriale, di un incremento di attività nei servizi arretrati e della mancanza di innovazioni. Una diminuzione permanente della produttività porta inevitabilmente a un conflitto distributivo, dato che si riduce “la torta da spartire” fra lavoratori e padroni. Il governo ha impostato una politica economica volta non a far crescere “la torta”, ma a fare in modo di assottigliare la fetta destinata ai lavoratori evitando la compressione dei profitti e i conflitti che potrebbero derivarne. Il tentativo di snaturare il ruolo dei sindacati e di individualizzare i contratti di lavoro può dunque essere letto in questo senso. Il livello di conflittualità (misurato in ore di sciopero) è oggi decisamente contenuto rispetto al passato. Tuttavia un’ulteriore riduzione della produttività accompagnata da una diminuzione dei salari reali potrebbe riaccendere la miccia. Un ridimensionamento del tradizionale ruolo del sindacato serve a scongiurare tale pericolo e certamente costituisce un regalo al padronato, in assenza di politiche industriali e in presenza di stagnazione. Il tentativo di coinvolgere il sindacato nell’attività di intermediazione e di certificazione ha chiaramente l’obiettivo di modificarne la funzione, togliendogli autonomia e trasformandolo da organo di contrattazione a organo parastatale di gestione dei servizi. Da un lato dunque si riafferma la necessità della presenza del sindacato, dall’altro si cerca di imbrigliarlo attraverso il coinvolgimento nel meccanismo della certificazione. Il fine ultimo pare quello di cancellare quell’insieme di norme e tutele nate per riequilibrare l’asimmetria di potere esistente fra lavoratore e imprenditore.
Grazie alla precarizzazione del lavoro, proliferano lavoretti flessibili, poco produttivi e mal pagati, mentre si perdono posti di lavoro nelle grandi imprese. La crescita di posti di lavoro poco produttivi ha consentito negli ultimi anni un incremento dell’occupazione, ma l’economia italiana è stagnante; la rilevazione Istat di fine 2004 indica che quasi ovunque il numero degli occupati è in calo, anche nel nord-est; l’unica area in cui il mercato del lavoro mostra una performance positiva è il nord-ovest.
Dunque il modello di precarizzazione del mercato del lavoro mutuato dai paesi anglosassoni non sembra dare i risultati sperati. Né ci si poteva aspettare altrimenti, in assenza di un’adeguata politica industriale e di un concreto impegno nella ricerca.
Una prima valutazione degli effetti
A prima vista con la legge 30 non sembra per il momento che siano intervenuti significativi cambiamenti nel mercato del lavoro. Nonostante il moltiplicarsi del numero dei contratti atipici, le ultime rilevazioni Istat non segnalano un aumento dell’occupazione precaria. Tuttavia le nuove forme contrattuali costituiscono un’arma potente in mano alle imprese, dato che la minaccia di assunzioni con contratti atipici e forme di contratti individuali è un ricatto spesso presente nel confronto con i sindacati nella contrattazione aziendale. Per il momento, però, i sindacati non hanno accettato il coinvolgimento negli istituti di certificazione e di somministrazione di manodopera attraverso gli enti bilaterali. Ma una valutazione non può ancora essere fatta. Molti aspetti della legge non sono chiari; numerosi giuristi mettono in evidenza che la legge è stata fatta in maniera affrettata e attualmente c’è un proliferare di note esplicative volte a chiarire aspetti controversi.
In ogni caso le prospettive non sono rosee. Ritengo che in futuro, se la legge 30 non verrà abrogata, come invece è auspicabile, le imprese impareranno a districarsi nei suoi meandri e utilizzeranno gli strumenti proposti per rendere sempre più precaria la condizione dei lavoratori e sempre più problematico l’intervento dei sindacati.
9.8 Conclusioni
Le politiche condotte negli ultimi vent’anni nei principali paesi europei per ridurre la disoccupazione e aumentare il tasso di occupazione hanno puntato prevalentemente a riforme strutturali del mercato del lavoro, alla moderazione salariale, all’impostazione delle politiche attive. In tempi recenti si è insistito anche su politiche di disincentivazione alla disoccupazione o alla inattività, attraverso la riduzione dei sussidi di disoccupazione e di invalidità e la limitazione dei prepensionamenti. Sono cresciuti i contratti a tempo determinato e, in generale, le forme di lavoro atipico, i salari reali sono scesi o rimasti stagnanti in quasi tutti i paesi dell’UE (unica eccezione fra i paesi maggiori è stata la Gran Bretagna), è scesa la quota dei salari sul valore aggiunto. Queste politiche non sembrano tuttavia aver dato i risultati attesi. Dal 1991 al 2001 nella UE il tasso di occupazione è cresciuto debolmente (passando dal 62,2% al 63,9%) e il tasso di disoccupazione si è ridotto di meno di mezzo punto percentuale (dall’8,1% al 7,7%) e poi ha ripreso a crescere. Nonostante l’evidente insuccesso delle politiche perseguite, la strategia non cambia. Se in fase espansiva l‘occupazione aumenta se ne attribuisce il merito alle politiche di flessibilizzazione e alla moderazione salariale, quando in fase recessiva cresce la disoccupazione si tende a sottolineare la necessità di perseguire con determinazione le stesse politiche.
Capitolo 10
La questione salariale
In questo capitolo presentiamo due articoli sulla questione salariale in Italia.
Distribuzione del reddito e diseguaglianza: l’Italia e gli altri
di Stefano Perri*
Economia e politica - http://www.economiaepolitica.it/ - 23 Gennaio 2009
Scriveva Keynes, nelle Conseguenze economiche della pace, che il processo di formazione del capitalismo industriale si è fondato su un “doppio inganno”. Da una parte i lavoratori si appropriavano di una piccola parte della torta che avevano contribuito a produrre, mentre i capitalisti ne ricevevano “la miglior parte”, con la tacita condizione di non consumarla, ma di destinarla prevalentemente all’accumulazione del capitale.
Dopo la crisi del ’29 e la seconda guerra mondiale, il processo di sviluppo è sembrato invece basarsi su una graduale diminuzione delle diseguaglianze che ha stimolato la domanda aggregata. Tuttavia, dagli anni settanta, le diseguaglianze sono tornate a crescere, con l’aggravante che nei paesi sviluppati la “miglior parte della torta” ha alimentato prevalentemente la speculazione piuttosto che gli investimenti reali. In molti hanno scambiato questa restaurazione del “doppio inganno”, che con la crisi attuale mostra tutte le sue contraddizioni, con la via maestra della modernizzazione.
In questo quadro il governo italiano ha varato una manovra del tutto inadeguata. Avendo appreso l’idea che le aspettative si auto-realizzano dalle storielle che è uso raccontare, Berlusconi sembra ritenere che bastino le sue esortazioni a consumare per ristabilire la fiducia. Soprattutto non sembra rendersi conto che la spesa per il consumo dipende dal reddito delle famiglie e che l’ insufficienza della domanda aggregata è il risultato del mutamento nella distribuzione del reddito che ha caratterizzato in modo fondamentale l’ultima fase economica nei paesi sviluppati.
Vediamo come si è evoluta la distribuzione del reddito negli ultimi 20 anni, seguendo il recente rapporto dell’OCSE Growing unequal?[1] e confrontando la situazione Italiana con quella di altri paesi sviluppati: la Germania, la Francia, il Regno Unito e gli USA. L’Italia sembra essere il paese che riesce a cumulare contemporaneamente alcune delle caratteristiche più negative dei paesi anglosassoni e di quelli del continente europeo. Queste note si riferiscono alla evoluzione della distribuzione del reddito precedente la crisi. Proprio per questo motivo mettono in evidenza alcune delle sue cause fondamentali.
L’aumento della diseguaglianza a partire dalla metà degli anni 70 è stato caratterizzato dalla diminuzione della quota delle retribuzioni del lavoro sul reddito nazionale. Come si può vedere dal grafico che segue questa quota è diminuita consistentemente nei paesi dell’OCSE, ma è caduta in modo molto più pronunciato in Italia[2].

Come conseguenza in Italia la quota del reddito nazionale che si ottiene attraverso il lavoro è la più bassa tra i paesi che stiamo confrontando:
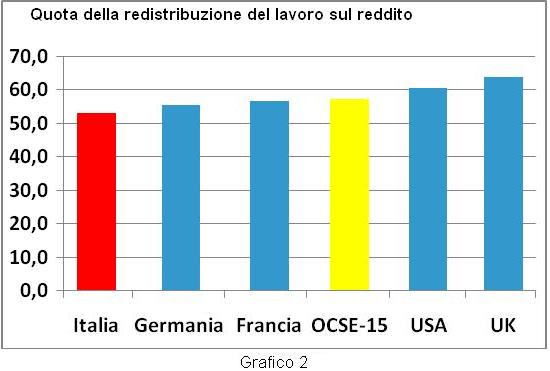
La forte diminuzione della quota dei redditi da lavoro dipende in larga misura dall’evoluzione del salario reale. Secondo le stime del rapporto dell’ Organizzazione Internazionale del lavoro, a parità di potere di acquisto, gli stipendi reali sono diminuiti in Italia del 16% circa tra il 1988 e il 2006[3].
La quota dei redditi da lavoro in Germania e Francia è diminuita seguendo l’andamento medio, mentre negli Usa e nel Regno Unito la quota è diminuita meno della media OCSE. Anche in questi paesi però la diseguaglianza è aumentata e nel caso degli USA enormemente. Sono state infatti all’opera anche altre cause, principalmente l’andamento del differenziale nelle retribuzioni del lavoro e l’effetto dei trasferimenti del reddito da parte dello stato alle famiglie e della tassazione, cioè il ruolo dello stato nel modificare il reddito disponibile delle famiglie rispetto al reddito di mercato.
La diseguaglianza nella distribuzione del reddito è rappresentata dall’indice di concentrazione dei redditi, l’indice Gini. L’Italia risulta avere verso la metà degli anni 2000 un alto indice di Gini, inferiore solo a quello degli USA tra i paesi considerati e superiore alla media di 24 paesi dell’OCSE. Germania e Francia hanno invece un indice Gini inferiore alla media, cioè sono paesi con una distribuzione del reddito notevolmente più egalitaria.
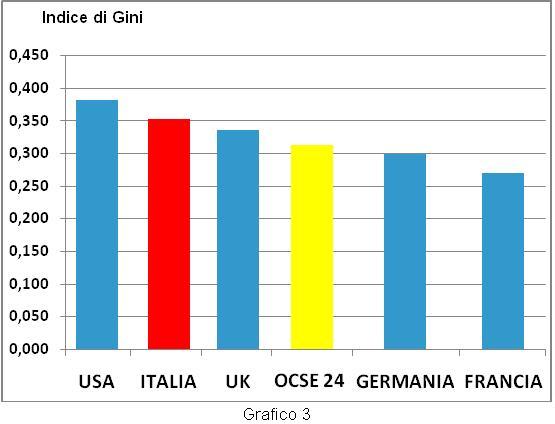
Negli ultimi venti anni la crescita dell’indice Gini è stata molto alta in Italia (inferiore solo a quella degli USA tra i paesi confrontati)[4].
E’ interessante per comprendere come si manifesta la diseguaglianza, confrontare i redditi mediani, quelli del decile più povero e quelli del decile più ricco della popolazione. Come si vede dai grafici, questo confronto mette in luce in modo drammatico la gravità della situazione italiana. Infatti, mentre sia per il reddito mediano che per il reddito del 10% più povero l’Italia è l’ultima tra i paesi considerati, e ha redditi minori rispetto alla media OCSE, il reddito del 10% più ricco risulta più alto rispetto alla media OCSE, e anche rispetto alla Francia. Si tratta di un dato che mostra in modo inconfutabile lo squilibrio che il nostro paese vive, con conseguenze molto rilevanti sia sul piano sociale che economico.
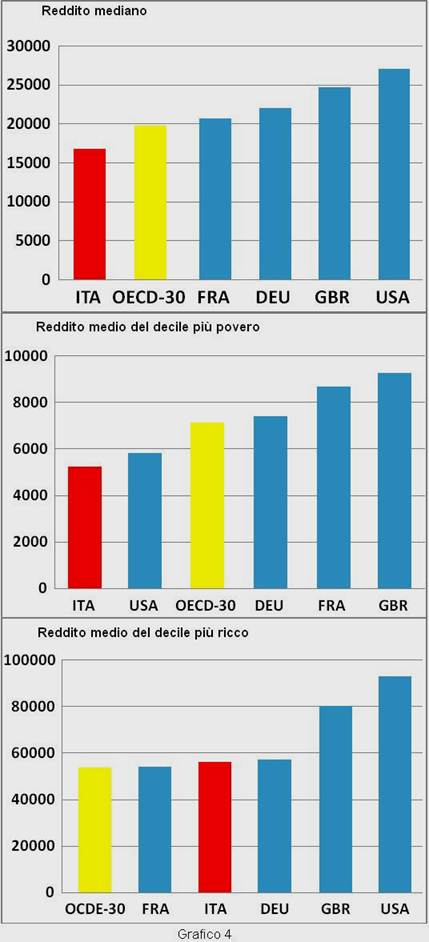
Vale la pena soffermarsi anche su uno dei dati più significativi presenti nel rapporto dell’OCSE, che svela il contenuto ideologico dell’identificazione del liberismo con una forte dinamica sociale e con ciò che si indica come meritocrazia. L’elasticità dei redditi intergenerazionali misura la probabilità che i figli mantengano lo stesso reddito dei padri. Più basso è il valore e più alta è la probabilità che i redditi cambino di generazione in generazione. L’Italia ha un valore molto alto per questo parametro. I dati della Francia e della Germania, mostrano che la mobilità sociale è favorita da una distribuzione meno diseguale del reddito e dalla robustezza delle istituzioni del Welfare, ancora in questi paesi non smantellate. Il sogno americano, la possibilità per ciascuno di migliorare indipendentemente dalle condizioni di nascita, è molto più effettivo nei paesi dell’Europa continentale che in quelli anglosassoni.
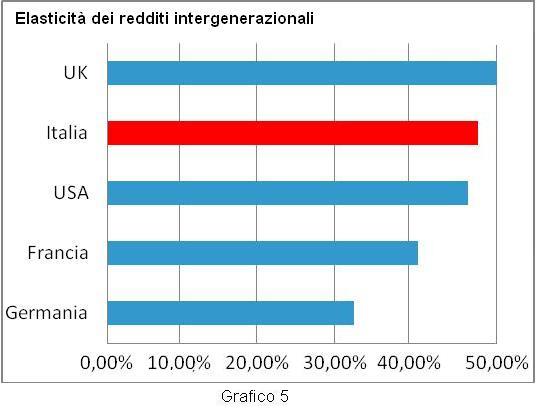
Vediamo ora come la distribuzione dei redditi è modificata dall’intervento pubblico, comparando i redditi di mercato con i redditi disponibili, calcolati tenendo conto dei trasferimenti dallo stato alle famiglie e della tassazione.
Secondo i dati OCSE in Italia l’effetto dell’intervento dello stato sulla diseguaglianza nella distribuzione dei redditi è superiore a quello dei paesi anglosassoni e alla media OCSE. Tuttavia risulta sensibilmente inferiore a quello della Germania e della Francia. Guardando anche gli altri paesi dell’ Unione Europea, i cui dati non sono riportati nel grafico, l’Italia si situa in effetti agli ultimi posti nell’efficacia distributiva dell’intervento pubblico[5]. Occorrerà capire quanto la scarsa efficacia redistributiva dell’intervento dello stato relativamente agli altri paesi europei sia dovuta all’alta evasione fiscale e agli sprechi nella spesa pubblica e quanto dipenda dalla struttura stessa della tassazione e dei trasferimenti. Dalle elaborazioni dell’ OCSE risulta in particolare che la progressività dei trasferimenti, e di conseguenza il loro impatto redistributivo, è molto minore in Italia rispetto alla media degli altri paesi, tanto per quanto riguarda le persone in età da lavoro che per gli anziani. Quello che è certo è che la politica economica, sia in relazione agli obiettivi più immediati di stimolo della domanda aggregata, sia in relazione alla correzione delle cause strutturali della crisi globale e di quella del nostro paese in particolare, deve porsi come obbiettivo prioritario la maggiore efficacia dell’intervento redistributivo dello stato.
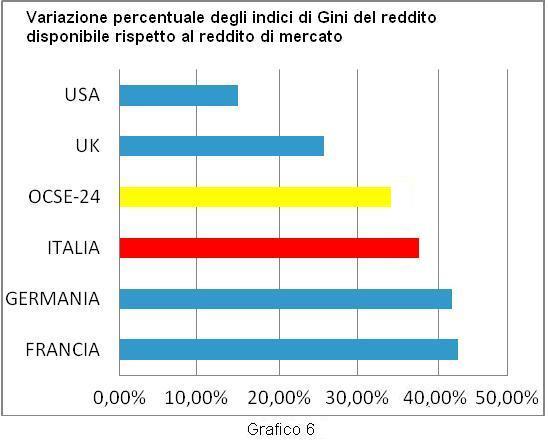
Il rapporto dell’OCSE cerca anche di stimare l’impatto dei servizi pubblici, principalmente relativi alla sanità e all’istruzione, sulla distribuzione del reddito.

Anche in questo caso l’efficacia redistributiva dell’intervento pubblico in Italia si rivela superiore a quella dei paesi anglosassoni, ma ora risulta inferiore alla media dei paesi OCSE oltre che alla Francia e alla Germania. Anche in questo caso, guardando anche agli altri paesi dell’Unione Europea, l’Italia si situa agli ultimi posti. Si capisce come una politica di tagli indiscriminati come quella prevista dalla finanziaria per l’istruzione, non può che aggravare una situazione già molto preoccupante.
I dati testimoniano in modo evidente che tutte le economie dei paesi sviluppati hanno subito negli ultimi decenni un processo di redistribuzione dei redditi a favore dei profitti e delle rendite (che si presentano spesso collegati tra loro). Questa redistribuzione è una delle cause più importanti dell’attuale crisi. L’Italia, in questo quadro, ha assistito ad un processo ancora più accentuato e ancora più squilibrato rispetto alla maggior parte degli altri paesi. Ne deriva la necessità di una riforma fiscale progressiva e redistributiva, sia in funzione di stimolo alla domanda aggregata nell’immediato, sia come condizione per un processo equilibrato di sviluppo nel lungo periodo.
*Professore ordinario di economia politica nell’Università di Macerata.
[1] Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD Countries, OECD, 2008.
[2] La quota stimata dall’OCSE non si riferisce solo alle retribuzioni del lavoro dipendente, ma anche a quelle relative al lavoro autonomo, di cui si tiene conto, sia pure attraverso una stima approssimativa
[3] World of Work Report 2008. Income inequalities in the Age of Financial Globalization, International Labour Office,International Institute for Labour Studies, ILO, Geneva, 2008.
[4] Si veda, in questa rivista, Cristina Tajani Distribuzione e povertà, Europa e mondo Crescita diseguale, diseguale recessione 29 Dicembre 2008
[5] Secondo il rapporto ISAE, Politiche pubbliche e redistribuzione, novembre 2007, la situazione italiana è ancora peggioredi quella indicata dai dati OCSE. L’Italia sarebbe infatti il paese dell’Unione Europea in cui l’efficacia redistributiva dell’intervento pubblico è la più bassa rispetto a tutti i paesi dell’Unione Europea. http://www.isae.it/Rapporti_trimestrali/Rapporto_ISAE_novembre_2007.pdf
-------------------------------------------------------
Specializzazione produttiva, competitività, salari. L’Italia e gli altri
di Roberto Romano - Economia e politica - http://www.economiaepolitica.it/ 16 Aprile 2010
Tra i paesi industrializzati l’Italia è quello che ha cercato più di altri di competere nei mercati internazionali mediante una accentuata politica salariale deflattiva. I dati relativi alla bilancia commerciale e alle quote nel commercio internazionale dimostrano che questa politica non ha avuto successo. E così, a dispetto della moderazione salariale, l’Italia riesce sempre meno a difendere il “core” del suo modello di specializzazione produttiva, fondato prevalentemente su attività e servizi che non necessitano di cospicui impegni sul terreno della conoscenza. Viceversa, in quei paesi nei quali gli investimenti in nuove tecnologie sono elevati, non solo si registrano livelli più alti dei salari reali, ma anche i risultati in termini di competitività internazionale sono ben superiori ai nostri.
Tutti i dati sembrano confermare queste affermazioni: gli investimenti e l’introduzione di innovazioni sono correlati a un aumento della competitività, ad un aumento della occupazione e, soprattutto, ad una occupazione di maggiore qualità. Inoltre, le imprese innovative, mediamente, realizzano profitti più alti di quelle legate a tecnologie tradizionali; grazie agli sforzi nel campo della ricerca e sviluppo, i profitti sono “garantiti” nel tempo e si registrano comportamenti migliori anche nei periodi di crisi. In qualche misura si può dunque configurare una “nuova dimensione dell’oligopolio” legata all’innovazione e agli investimenti, che diventano una barriera all’entrata per gli imprenditori, delineando per le stesse imprese innovatrici un certo livello di potere nel mercato[1].
Prendendo in esame la quota percentuale dei prodotti ad alta tecnologia sulle esportazioni dei beni manifatturieri per destinazione di produzione[2] di Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone e Canada[3], possiamo osservare l’evoluzione e la crescita della componente high tech a livello generale da un lato, e il peso della produzione high tech di ogni paese dall’altro (si veda la Tabella 1 in basso).
Per i beni strumentali-capitali la quota di produzione legata alla componente high tech sulle esportazioni manifatturiere è passata dal 26,98% del 1961-65 al 44,38% del 2006; per i beni intermedi la percentuale high tech passa dall’8,65% al 26,02%; per i beni di consumo la quota percentuale passa dal 12,96% al 29,30%. Forse non è corretto considerare la crescita della componente h-t sull’esportazione dei beni manifatturieri come soglia “oligopolistica”; essa tuttavia rappresenta bene un fattore di competitività sul mercato internazionale.
Tra i paesi indagati l’Italia è quello che manifesta una marcata debolezza nei settori ad alta tecnologia. Tra l’altro, la distanza che separa l’Italia dagli altri paesi si accentua nel tempo. Nella produzione di beni strumentali l’Italia passa dal 29,33% del periodo 1961-65, al 18,74 del 2006. Più in particolare si osserva una progressiva incapacità nel mantenere un ruolo importante nei settori avanzati. Se nel 1961-65 la distanza dalla media dei paesi considerati nella componente h-t dei beni strumentali aveva valori positivi pari a 2,35 punti percentuali (cioè l’Italia superava la media dei paesi analizzati) alla fine del 2006 l’Italia accumula un ritardo pari a 25,64 punti; per i beni intermedi si passa dallo 0,38 a meno 10,14 punti percentuali; per i beni di consumo si passa dal meno 7,73 a meno 14,41punti percentuali.
I dati mostrano inoltre che dove la spesa in ricerca e sviluppo è maggiore della media, il salario tende ad essere più alto e il numero delle ore lavorate è più basso[4]. Nei paesi in cui la spesa in ricerca e sviluppo è prossima al 2% del pil, le ore lavorate per addetto sono sempre più contenute rispetto a quelle che si registrano nei paesi in cui la spesa in ricerca e sviluppo è prossima o di poco superiore all’1% del pil. La Germania spende in ricerca e sviluppo il 2,53% del pil, mentre le ore lavorate annue per addetto sono pari a 1.433; la Gran Bretagna spende l’1,82% del pil e le ore lavorate sono 1.670; in Francia si spende il 2,04% del pil in ricerca e sviluppo, mentre le ore lavorate sono pari a 1.561. Passiamo all’Italia. Da noi la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,18% del pil, mentre le ore lavorate sono pari a 1.824 ore per addetto.
Lo stesso trend lo possiamo osservare dal lato dei salari. Se in quasi tutti i paesi considerati i tassi di crescita dei salari hanno conosciuto forti contrazioni a partire dal 1985, il fenomeno è significativamente diverso da paese a paese (si veda la Tabella 2 in basso).
Nei paesi che hanno rafforzato la parte manifatturiera high tech si registrano valori assoluti dei salari e tassi di crescita superiori alla media; in Italia, invece, si registra un forte rallentamento della dinamica salariale rispetto ai partners economici, soprattutto a partire dal 1995[5].
Tutto ciò sembra indicare che i paesi che hanno saputo adeguare il target della propria struttura produttiva alle nuove sfide della conoscenza e dell’innovazione, hanno anche potuto sfruttare posizioni di mercato meno concorrenziali, con risultati soddisfacenti per i profitti e, in media, anche per i salari. Stando a queste evidenze, si può affermare che lo sforzo nello spingere il sistema produttivo a credere nella ricerca e sviluppo, più che nel trasferimento di tecnologia, dovrebbe esser considerato la vera frontiera della politica economica.
Tabella 1
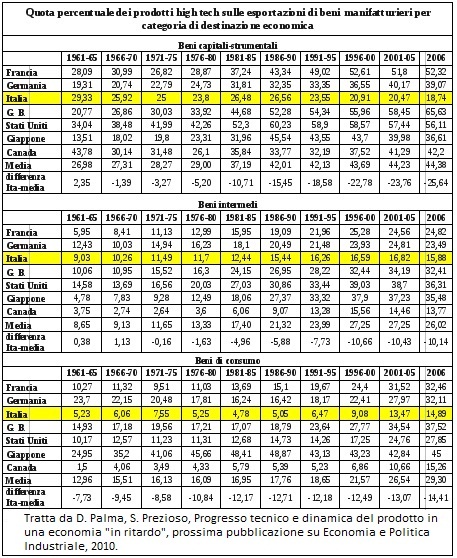
Tabella 2
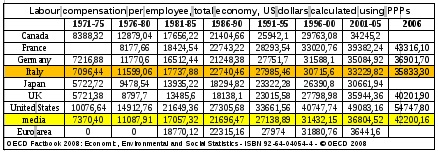
[1] Alfred Kleinknecht, 1998, Is labour market flexibility harmful to innovation?, ed. Cambridge journal of economics. 1998, 22, 387-396.
[2] Beni strumentali, beni intermedi, beni di consumo.
[3] Tratta da D. Palma, S. Prezioso, Progresso tecnico e dinamica del prodotto in una economia “in ritardo”, prossima pubblicazione su Economia e Politica Industriale, 2010.
[4] OECD EMPLOYMENT OUTLOOK 2008.
[5] Labour compensation per employee in ppps in US dollars.
Per incentivare il passaggio ai nuovi contratti la legge ha previsto uno sconto fiscale per ogni lavoratore in forza della durata di cinque anni per le imprese che, in seguito alla riduzione di orario a parità di salario aumentino l’occupazione di almeno il 6%. E’ stata prevista una sovvenzione aggiuntiva per le imprese con più del 60% di operai e per quelle che riducono l’orario a 32 ore o che assumono giovani, disoccupati di lungo periodo o disabili.
M. Zenezini in L’inconsistenza (e le conseguenze negative) della politica europea dell’occupazione, (2005)
Il “Patto per l’Italia” fu siglato nel luglio 2002 da associazioni sindacali e imprenditoriali e recepiva molte indicazioni contenute nel Libro Bianco; la Cgil non ne condivise il contenuto e non firmò.
Fonte: http://www.personalweb.unito.it/lia.fubini/pol_ec_e_lav_mod_2.doc
Sito web: http://www.personalweb.unito.it/lia.fubini/
Autrice: Lia Fubini
Politica economica e del lavoro
Visita la nostra pagina principale
Politica economica e del lavoro
Termini d' uso e privacy